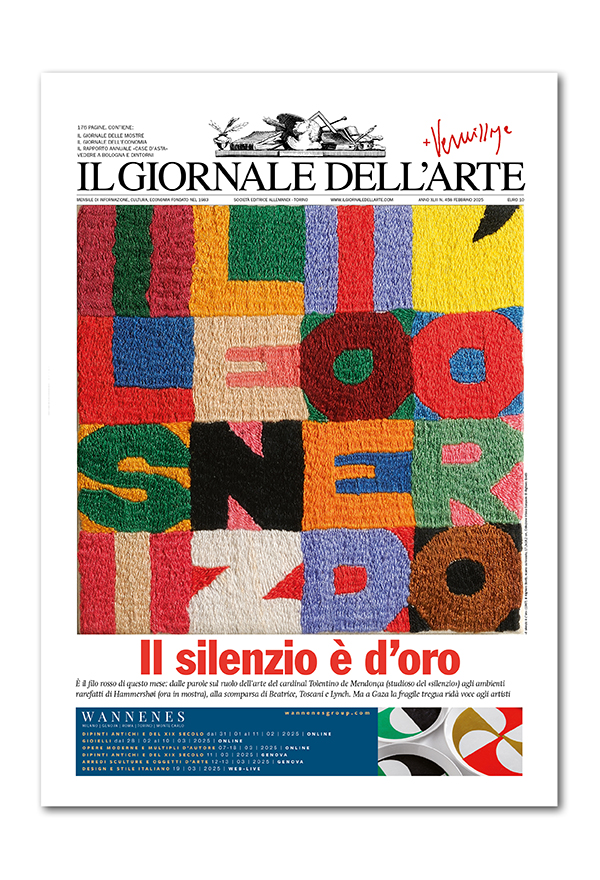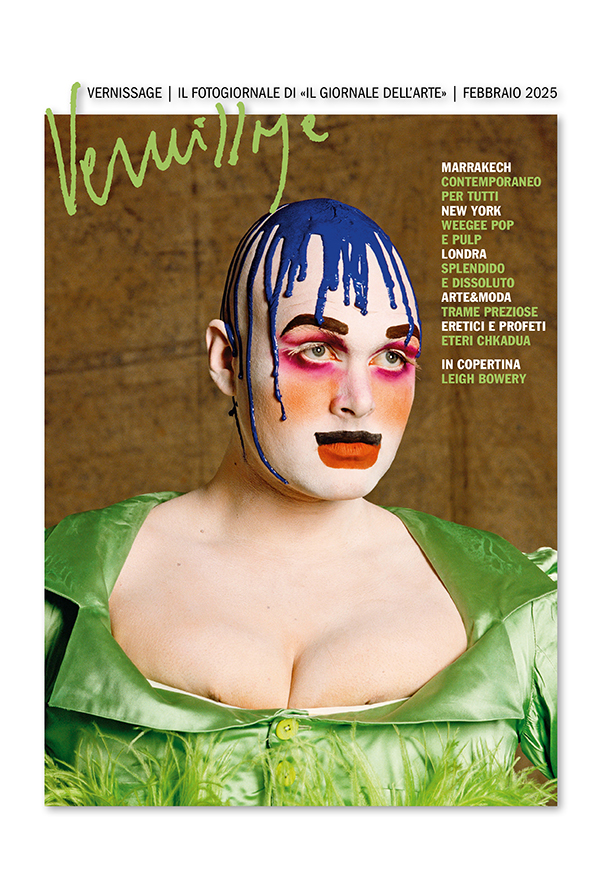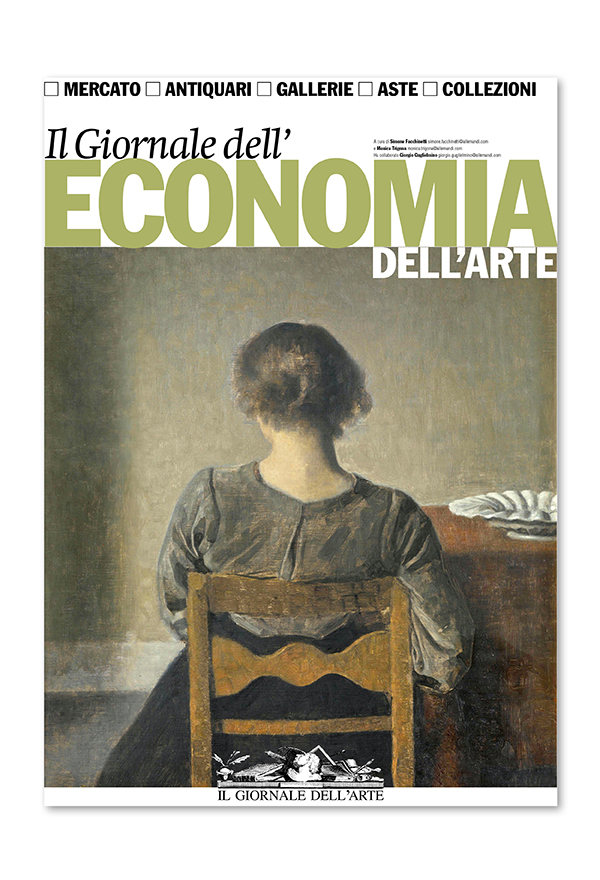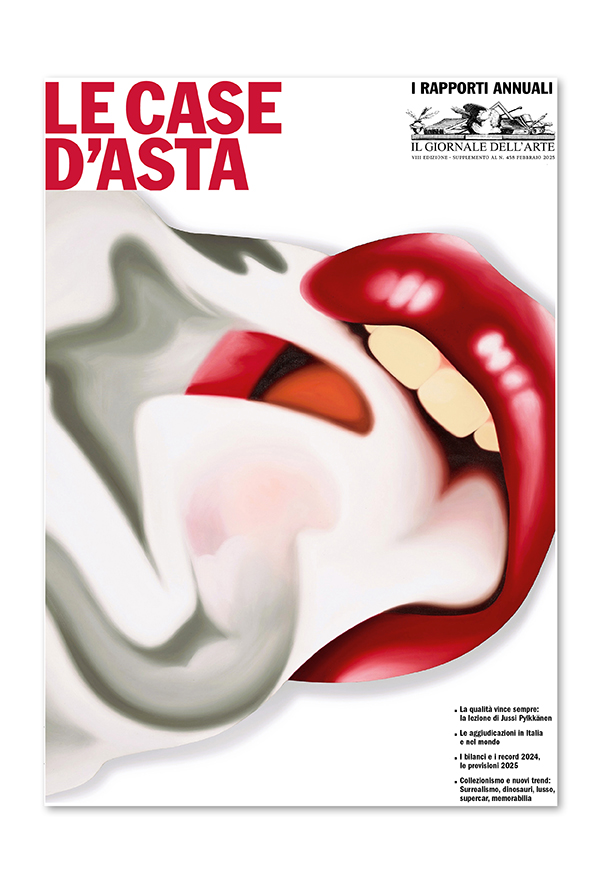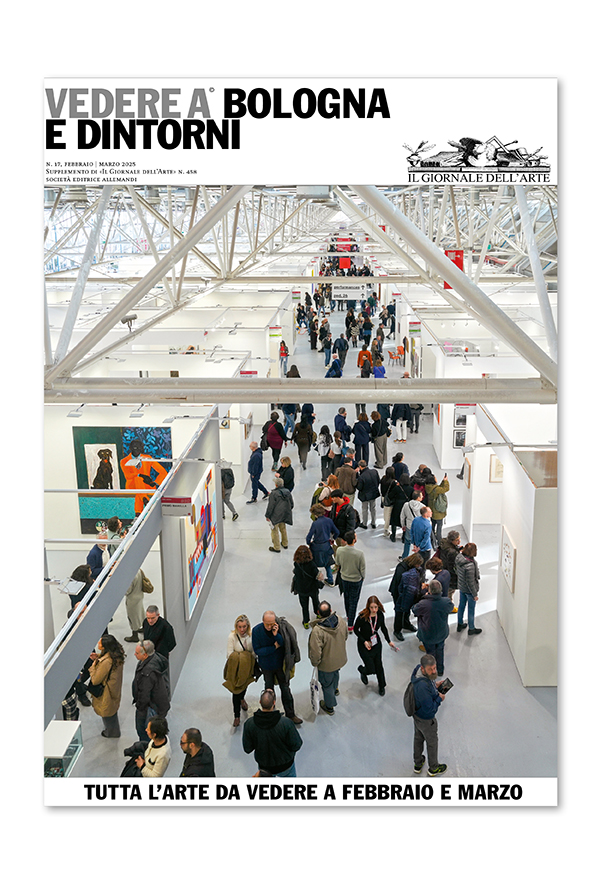È un territorio ben noto, per la Galleria dell’Incisione, quello che, specie nell’area germanica, va dalla fine dell’800 agli anni ’20 del ’900, e le sue mostre su quella stagione esibiscono sempre nuove scoperte.
Ma la rassegna «Nel segno di Emilio Bertonati. Dal Simbolismo alla Nuova Oggettività» (fino al 31 gennaio) diventa anche l’occasione per rendere omaggio a un fine intellettuale e gallerista (la sua Galleria del Levante fu attiva a Milano dal 1962 al 1980, e a Monaco di Baviera dal 1967) che negli anni in cui Parigi sembrava essere l’unica capitale dell’arte, guardò invece a Vienna, Berlino, Monaco: alle atmosfere notturne del loro Simbolismo, poi alla realtà «ghiacciata» e crudele della Nuova Oggettività postbellica.
Esplorando al contempo i rapporti intessuti con alcuni artisti italiani. In mostra, opere di Franz von Stuck e Maurice Denis; Giulio Aristide Sartorio e Alberto Martini; Alfred Kubin, Otto Dix, George Grosz, Karl Hubbuch, Franz Radziwill, Rudolf Schlichter; di Edita Broglio, Mario Broglio, Cagnaccio di San Pietro e di altri artisti di quella temperie culturale, mentre a Milano, in Palazzo Reale, in una mostra esemplare, va in scena fino al 27 febbraio il fenomeno del Realismo Magico, così affine alla Neue Sachlichkeit, la Nuova Oggettività.
Architetto di formazione, storico, critico, gallerista e organizzatore d’importanti mostre internazionali su terreni dell’arte sino ad allora poco o mai dissodati (dall’avanguardia russa e ungherese del primo ’900 alla Secessione di Dresda e alla fotografia sperimentale tedesca), pittore e incisore visionario lui stesso, Bertonati era sempre (lucidamente) controcorrente non per ribellismo ma per una vera vocazione alla scoperta di nuovi ambiti di ricerca, affiancato da studiosi come Testori, Tassi, Carluccio, Russoli, Bossaglia, Barilli, Sgarbi, ma sorretto anche dal suo gusto sicuro, che già nel 1968 lo aveva indotto a presentare la prima grande mostra postbellica sulla Nuova Oggettività degli anni Venti politicamente scottanti.

«La grande bestia» (1919) di Richard Müller