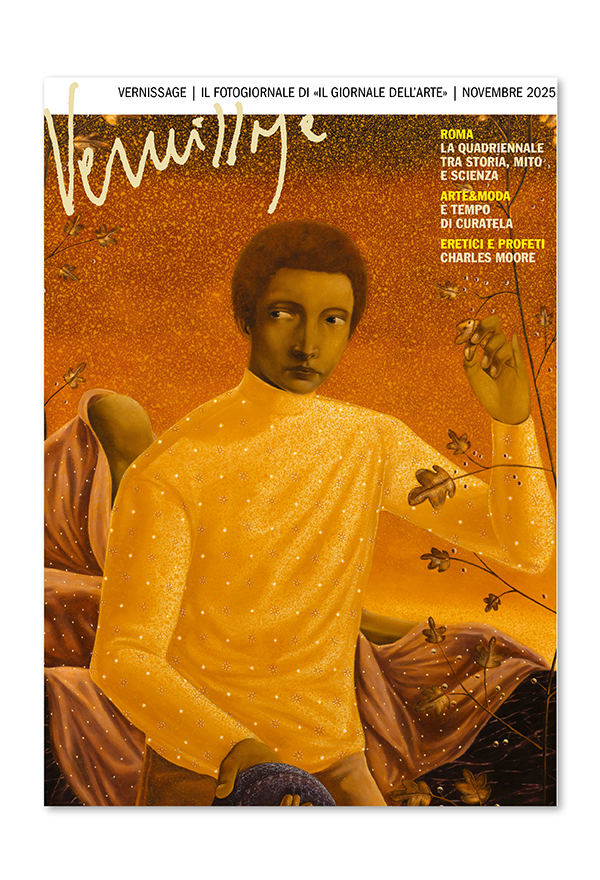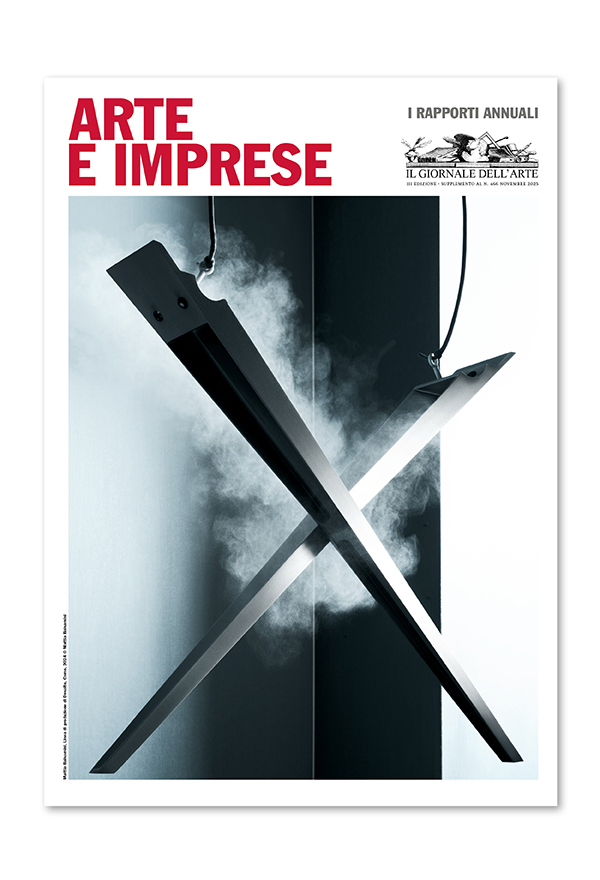Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Jenny Dogliani
Leggi i suoi articoliNegli ultimi anni il rapporto tra arte contemporanea e mondo del vino ha smesso di essere un episodio sporadico per assumere i contorni di un fenomeno strutturale. Sculture in vigna, installazioni site specific, residenze d’artista, musei d’impresa e collezioni aperte al pubblico stanno trasformando numerose cantine italiane in luoghi di produzione culturale, oltre che agricola. Il convegno nazionale promosso da MetodoContemporaneo, ospitato al Polo Santa Marta dell’Università di Verona il 14 novembre 2025, ha provato a fare il punto su questo scenario, con un taglio dichiaratamente scientifico: capire che cosa sono oggi le cosiddette art wineries, come operano, quali impatti generano sui territori e perché rappresentano un laboratorio importante nel dialogo tra impresa, paesaggio e arti visive. MetodoContemporaneo nasce proprio da questa esigenza di lettura sistematica. Il progetto, promosso dall’Università di Verona in collaborazione con BAM! Strategie Culturali, si è posto un obiettivo ambizioso: mappare per la prima volta, con criteri omogenei, le realtà vitivinicole italiane che hanno scelto di integrare l’arte contemporanea nella propria identità e nel proprio rapporto con il territorio. La ricerca ha dato vita a una piattaforma online, Metodocontemporaneo.com, pensata come strumento di consultazione, ma anche come dispositivo narrativo capace di restituire la complessità di un fenomeno che attraversa regioni, modelli d’impresa e forme diverse di impegno culturale. Dalla mappatura emergono decine di cantine distribuite lungo tutta la penisola, con configurazioni molto differenti fra loro. Ci sono aziende che hanno costruito collezioni d’impresa visitabili, realtà che hanno commissionato opere permanenti inserite nel paesaggio, tenute che hanno dato vita a parchi d’arte, fondazioni che hanno affiancato alla produzione enologica spazi museali o progetti espositivi, fino a residenze d’artista pensate come luoghi di ricerca sul paesaggio vitato e sul suo immaginario. A unire queste esperienze è l’idea che la cultura del vino non si esaurisca nel prodotto, ma si inscriva in una trama più ampia di storie, memorie, relazioni sociali e responsabilità verso i contesti in cui le cantine operano. Il convegno veronese ha messo attorno allo stesso tavolo chi questo processo lo studia e chi lo pratica quotidianamente. Da un lato i responsabili scientifici del progetto – Luca Bochicchio e Monica Molteni per l’Università di Verona, affiancati dal gruppo di ricerca coordinato da Costanza Vilizzi e dal lavoro sul campo di BAM! Strategie Culturali – hanno illustrato metodo, risultati e prospettive della mappatura. Dall’altro, una serie di interlocutori privilegiati ha portato la propria esperienza diretta: da Planeta a Frescobaldi, da Castello di Ama a La Raia, dalla Fondazione Lungarotti al Vigne Museum, fino alle esperienze di Officina Malanotte. Il quadro che ne è uscito è quello di un paesaggio in trasformazione, nel quale le cantine diventano nodi di una rete culturale che coinvolge artisti, curatori, istituzioni, comunità locali e nuovi pubblici.

Non si tratta soltanto di collocare opere nel vigneto. Il confronto ha mostrato come l’arte venga sempre più interpretata come forma di responsabilità culturale. Il Manifesto di Noto promosso da Planeta, ad esempio, legge il vino come bene comune e veicolo di relazione, oltre che eccellenza agricola. Progetti come «Artisti per Frescobaldi» ridefiniscono le pratiche di mecenatismo contemporaneo, chiamando artisti internazionali a misurarsi con la storia, il paesaggio e le trasformazioni del territorio. Castello di Ama ha costruito nel tempo un vero e proprio «museo diffuso» in cui le opere non illustrano la cantina, ma instaurano con il luogo un rapporto dialettico, talvolta persino conflittuale. La Raia lavora sull’idea di un innesto armonico tra intervento artistico, agricoltura biodinamica e tutela del paesaggio collinare. La Fondazione Lungarotti, con il Museo del Vino, lega la propria produzione a una riflessione storica di lungo periodo sulla cultura enologica in Italia. Il Vigne Museum in Friuli mette in relazione arte, natura e sperimentazione sonora, mostrando come il vigneto possa diventare un dispositivo di ascolto e di percezione. Officina Malanotte assume la forma di una residenza che usa la cantina come laboratorio sociale, dove l’arte diventa strumento per rinsaldare legami comunitari. Accanto ai casi studio, il convegno ha insistito su un altro aspetto: il rapporto tra queste iniziative e le politiche culturali più ampie. L’intervento di Monica Calcagno, che ha collegato MetodoContemporaneo al bando Changes CREST del PNRR, ha inquadrato il progetto dentro il tema della transizione dei territori e della capacità della cultura di orientare processi di cambiamento. La presenza di Ilaria Bonacossa, oggi direttrice di Palazzo Ducale a Genova e già curatrice di progetti come «Antinori Art Projects» e La Raia, ha permesso di collegare le art wineries alla storia più generale delle collezioni d’impresa in Italia, mostrando continuità e discontinuità rispetto ai modelli novecenteschi.

Uno degli elementi più interessanti emersi dalla ricerca riguarda il pubblico. Il primo evento diffuso organizzato da MetodoContemporaneo, che il 17 e 18 ottobre 2025 ha coinvolto quattordici cantine in un programma coordinato di attività culturali gratuite, è stato anche un test sul campo. Le analisi condotte sui visitatori – a partire dai dati raccolti da BAM! Strategie Culturali – indicano la presenza di profili nuovi rispetto all’enoturismo tradizionale: persone attratte non solo dal vino, ma dall’idea di poter vivere un’esperienza che combina paesaggio, arte e convivialità in modo integrato. Al tempo stesso emerge una crescente percezione delle cantine come luoghi in cui si produce cultura, non semplicemente come destinazioni di consumo o di degustazione. Da questo punto di vista, MetodoContemporaneo non si limita a registrare un fenomeno. Il progetto ambisce a definire strumenti che permettano di misurare l’impatto culturale e sociale delle iniziative, aprendo la strada a criteri di valutazione che vadano oltre i numeri delle presenze o delle bottiglie vendute. Si tratta di un passaggio delicato: in un contesto in cui il turismo deve fare i conti con la questione della sostenibilità e i territori rivendicano un ruolo attivo nella definizione dei propri modelli di sviluppo, la relazione tra paesaggi produttivi, comunità locali e pratiche artistiche diventa un laboratorio per ripensare la nozione stessa di paesaggio. Non più sfondo da contemplare, ma spazio vissuto, abitato, attraversato da narrazioni e competenze diverse. Le parole di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo hanno sintetizzato questa postura: «l’arte, nei territori del vino, non è decorazione ma responsabilità, modo per mettere in dialogo comunità, paesaggio, cultura del cibo e del vino». L’idea che il paesaggio non si osservi dall’esterno, ma si viva in prima persona riassume bene la prospettiva di molte art wineries italiane: usare le opere, le installazioni, i dispositivi espositivi come strumenti per far emergere questioni ambientali, sociali, democratiche, più che come segni di prestigio. In filigrana si intravede un dato che riguarda l’Italia nel suo complesso. Il Paese possiede un patrimonio vitivinicolo straordinario, ma anche una rete crescente di soggetti – imprese, fondazioni, cantine, musei – che hanno scelto di interpretare questo patrimonio in chiave culturale, costruendo nuove forme di racconto e di relazione. MetodoContemporaneo dimostra che questo patrimonio non è solo insieme di vini, etichette e marchi, ma anche un tessuto di luoghi dove arte e lavoro agricolo, memoria e innovazione, ospitalità ed esperienza estetica possono coesistere. Per il mondo dell’arte, il progetto apre almeno due piste di riflessione. Da un lato invita a guardare alle cantine come a nuovi spazi di committenza, capaci di offrire agli artisti occasioni di confronto con paesaggi e comunità specifiche. Dall’altro interroga la critica e la ricerca curatoriali sulla necessità di dotarsi di strumenti per leggere questi contesti ibridi, che non sono né musei in senso stretto né semplici luoghi di consumo.
Altri articoli dell'autore
La Power Station of Art di Shanghai amplia la propria identità con Espace Gabrielle Chanel, un nuovo spazio pubblico di 1.700 metri quadrati progettato da Kazunari Sakamoto e sostenuto dal Chanel Culture Fund
Una nuova linea di skiwear tecnico integra nella progettazione di materiali performativi altamente tecnologici i procedimenti visivi dell’artista
Una mostra, un libro, un podcast e dieci nuove creazioni per suggellare una forma di diplomazia culturale applicata al lusso
La 14ma edizione dell’evento consolida l’idea della sponsorizzazione come parte di un ecosistema di cultura d’impresa