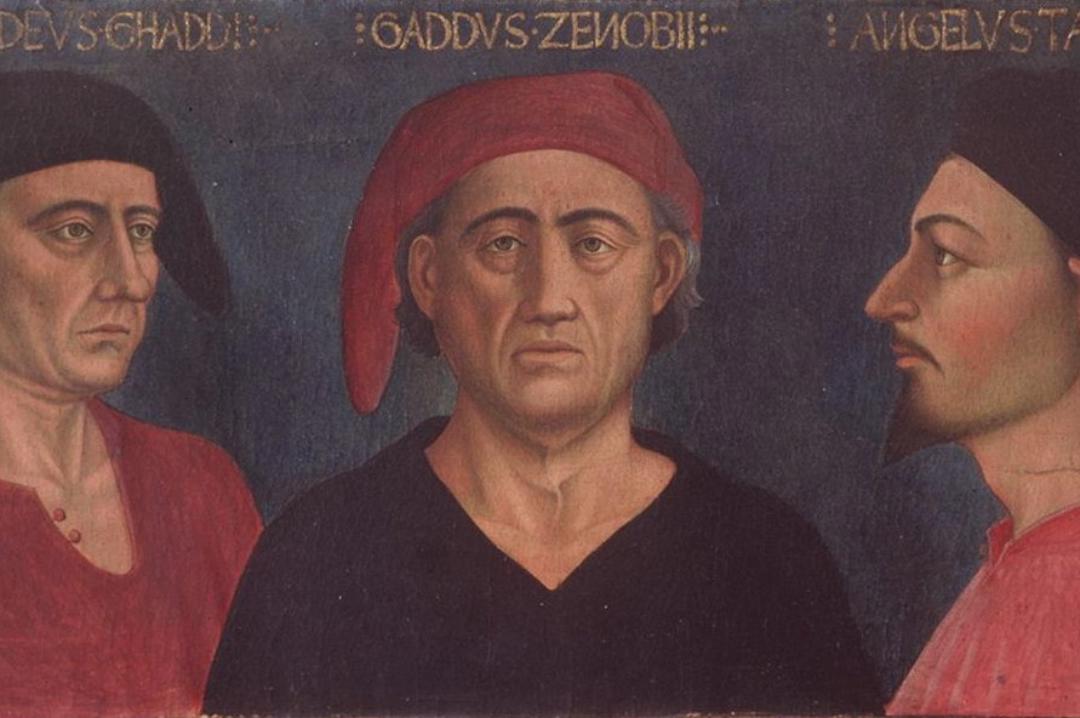Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Elisabetta Matteucci
Leggi i suoi articoliLa Villa di Papiano è entrata a far parte dell’Associazione Nazionale Case della memoria. Immersa nel verde degli olivi del Montalbano e conosciuta anche come la Villa dell’Americana, è sottoposta a tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.
Visitarla offre la possibilità di conoscere nell’intimità la filantropa e benefattrice Laura Towne Merrick (Filadelfia, Stati Uniti, 1842-Firenze, 1926), la cui memoria si conserva ancora negli abitanti di Lamporecchio. Il complesso, di epoca rinascimentale, costruito su un edificio medievale preesistente, ha ospitato per alcune centinaia di anni la famiglia Torrigiani. Nella seconda metà dell’Ottocento fu acquistato da una nobildonna, Miss Merrick che, affascinata dalle bellezze naturali e artistiche, ai primi anni Ottanta decise di trasferirsi definitivamente in Italia. Sesta dei sette figli di uno dei più influenti imprenditori e benefattori di Filadelfia, Samuel Vaughan Merrick, magnate industriale nel campo della siderurgia, nel 1869 intraprese un Grand Tour in Europa, officiando quella sorta di rito culturale iniziatico praticato fin dal XVII secolo dagli esponenti dell’upper class nordeuropea.
Dopo aver abitato a Firenze, nel 1889, dietro suggerimento dell’amico Emilio Torrigiani, decise di comprare un antico casale a Papiano, in provincia di Pistoia, facendone la propria residenza estiva. Annessi all’edificio erano il terreno, le stalle, le rimesse, i magazzini, le cantine e una cappella consacrata ai lati del giardino, oltre a vigneti e al terreno boschivo. Torrigiani, che le aveva fatto conoscere quei luoghi così cari alla propria infanzia, l’aiutò ad apportare modifiche e interventi strutturali all’intera tenuta come i loggiati in stile neorinascimentale, il giardino all’italiana con siepi simmetriche, vasche, fontane e fioriere e ancora il restauro della limonaia, degli spazi di servizio, delle cantine, del frantoio e della piccola chiesa, ancora oggi consacrata.
La Villa fu dotata di un impianto di illuminazione a gas (dato il disturbo oculare di cui Miss Merrick soffriva, ogni ambiente era provvisto di luci soffuse e sontuosi lampadari di Murano) e collegata tramite un acquedotto a una sorgente così da dotarla di un impianto idrico con acqua corrente che garantiva una costante irrigazione alla casa, agli annessi e al giardino. Al primo piano si trovava l’appartamento di Laura, costituito da sale e salottini arredato in stile eclettico con suppellettili in legno scuro, tappeti, cineserie, tendaggi, drappeggi in damasco e cimeli. Uno stile diffuso tra gli angloamericani che, proprio nella seconda metà dell’Ottocento, costituivano un’importante colonia sulle pendici fiorentine e non solo. Qua Miss Merrick poteva dedicarsi agli ozi prediletti come la fotografia, l’antiquariato e il collezionismo. Ancora oggi, come se ogni cosa fosse rimasta intatta, è possibile ammirare nei diversi ambienti i mobili, i tappeti, i quadri e gli effetti personali (i vestiti, i ricami e la biancheria intima) così come lei stessa li aveva collocati.
Al nutrito numero di persone di servizio si aggiungevano i contadini che dalle terre della tenuta ricavavano vino e olio. In quel fazzoletto di terra, Miss Merrick aveva costruito il suo piccolo feudo dove, lontano da occhi indiscreti, sfarzo e clamori, l’amore per la natura aveva soppiantato l’attrazione per salotti e circoli culturali e la fama di benefattrice si era imposta su quella della nobile e aristocratica ereditiera. La sua biografia è, dunque, indissolubilmente legata alla storia del territorio pistoiese dove, all’epoca del suo arrivo, era molto diffusa la tradizione del ricamo. Già segretaria e membro del comitato nella scuola di ricamo di Filadelfia, favorendo le abilità artigianali delle ragazze e disponendo di sufficienti risorse economiche, ai primi del Novecento Miss Merrick istituì con piglio manageriale la Scuola dei merletti e Lavoro Femminile, il cui obiettivo era di introdurre un’industria sussidiaria per le donne sprovviste di un impiego fisso. All’interno della scuola, oltre ai punti di ricamo tipici del Pistoiese, veniva insegnato un nuovo punto, nato proprio all’interno di quella piccola istituzione: il Punto Lamporecchio. Oltre a finanziare il restauro della Chiesa di Santo Stefano, Miss Merrick creò alcune associazioni di carattere sociale ed educativo come la Società Operaia di Mutuo Soccorso, volta a sostenere i disagi dei lavoratori dovuti a malattie, invalidità, vecchiaia e motivi bellici. Le sue elargizioni, finalizzate a sussidiarne i componenti, permisero il costituirsi di un capitale sociale.
Anche le famiglie più indigenti nonché la locale Società Filarmonica, nata agli inizi dell’Ottocento, usufruirono delle sue generose donazioni e finanziamenti. Alla morte di Miss Merrick, non essendoci discendenti diretti, l’eredità della tenuta di Papiano passò al nipote John Vaughan Merrick che, a sua volta, nel 1955 la vendette a Mauro Venturini, padre dell’attuale proprietario grazie al quale l’intero complesso è stato aperto alle visite.
Altri articoli dell'autore
La «modernità» nella pittura del figlio di Vincenzo, interpretata alla luce del concetto elaborato da Charles Baudelaire, e il possibile preambolo ottocentesco all’invenzione dei dipinti di paesaggio di formato longitudinale
Ma quando comincia a insinuarsi nella pittura italiana, alla stregua di quella francese e inglese, il richiamo sempre più seducente di un mondo alternativo ed esotico, ricco di spunti nuovi?
È apprezzata anche all’estero, soprattutto Oltremanica, la produzione di questi pittori che tramandarono il mestiere di padre in figlio rinnovando il vedutismo settecentesco secondo le moderne concezioni del paesaggismo europeo
Quando ha avuto inizio in Italia il processo? Quali fattori lo hanno determinato? Quali sono stati i primi musei ad avere una sezione dedicata all’Ottocento?