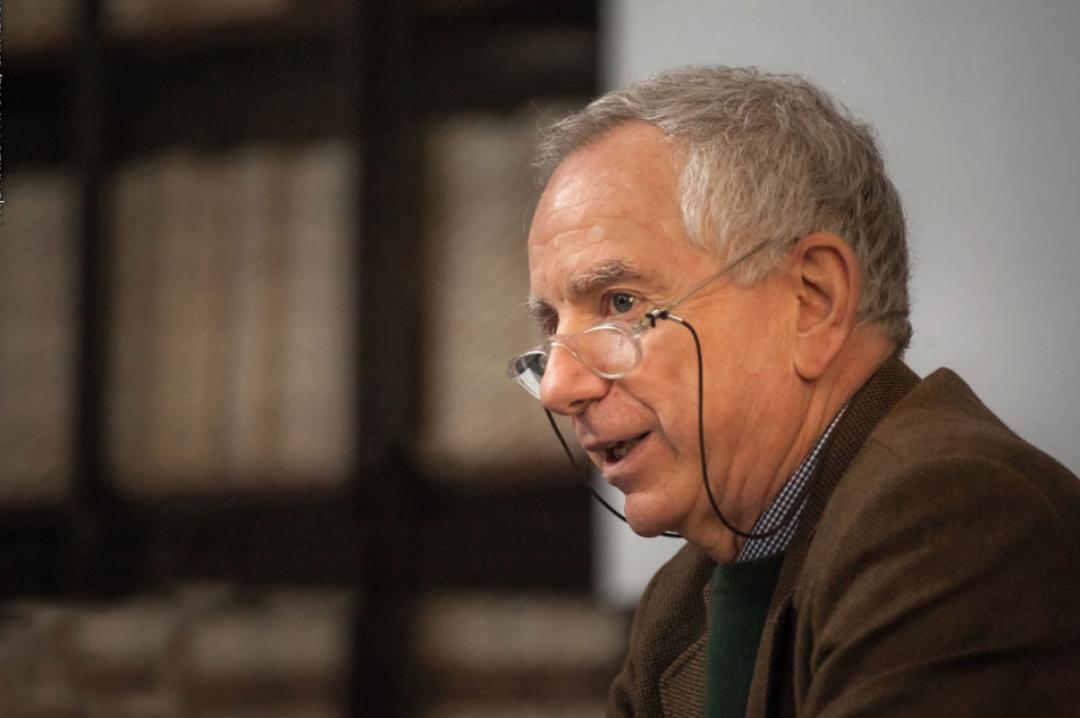Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Dopo Archeologie del contemporaneo (Carocci, Roma 2023), che ha avuto il merito di proporre in modo più sistematico questi temi al pubblico italiano, Giuliano De Felice li approfondisce in un libricino dalla scrittura piacevole e la sottile ironia.
L’obiettivo è ambizioso: ragionare sul senso dell’archeologia e del suo rapporto con la società, alla ricerca «di un ruolo etico e civile che dia senso al lavoro archeologico». Anche se il Novecento ha allargato lo sguardo a tutte le tracce materiali del passato (e ora anche del presente), l’archeologia è nata anche come scienza degli immondezzai. E infatti De Felice si concentra su «cianfrusaglie, rottami, ruderi, rifiuti» e sceglie 10 oggetti esemplificativi della contemporaneità (e i relativi contesti: discariche, miniere abbandonate, campi di sterminio), che descrivono un mondo tutto al negativo, visto con gli occhi di chi peraltro sostiene che la storia è «una sequela di contese e ostilità» e che pertanto «l’archeologia scava nell’orrore». Fatto spesso vero, ma che non può condannarci a un desolato pessimismo per il quale i tempi moderni sono solo guerre, migrazioni, profughi, secondo una visione che rischia di togliere dal nostro orizzonte l’infinita varietà delle tracce materiali della contemporaneità e le feconde riflessioni sui rapporti fra i diversi sistemi di fonti.
Sembra dunque che lo studio degli orrori e delle marginalità debba dare corpo a una riconversione etica dell’archeologia, che ruota attorno alla memoria dei ghetti (dove peraltro la materialità si esprime in forme spesso arcaiche che di moderno hanno ben poco). Tutti temi nobilissimi e al tempo stesso parziali. Certo rappresentativi dei mali del mondo, che rispetto ai mali di sempre hanno la marcia in più della loro globalità planetaria. Ritroviamo qui la prospettiva che mezzo secolo fa accompagnò la nascita dell’archeologia medievale italiana concentrata sullo studio dei miseri e delle loro capanne, sdegnando palazzi e chiese, città e opere d’arte, e tanti altri aspetti di vita quotidiana.
L’eticità dell’archeologia sembra costruita sui contenuti della ricerca piuttosto che sui suoi metodi e su quel crinale affascinante che coniuga la scientificità della costruzione del dato con la libertà responsabile della sua interpretazione. Mi sembra una «scelta di campo» rischiosa. Nel momento in cui imponessimo a una disciplina i suoi temi, accantonandone altri, legittimeremmo l’operazione inversa, quella classicistica e selettiva, che l’archeologia ha contrastato positivamente nelle ultime due generazioni. Temo infatti che un’archeologia prestata all’ideologia (quale essa sia) sia condannata allo sfruttamento dell’uso pubblico della storia e in definitiva all’irrilevanza.
De Felice ci parla di un’«archeologia dell’opposizione», di «narrazioni diverse da quelle dominanti», in pagine ricche di empatia, che criticano l’archeologia delle meraviglie, che evita le narrazioni scomode e la complessità del reale. Ha una sacrosanta paura (condivisa) dell’uso distorto delle identità, ma invano cercheremmo un accenno critico all’ideologia liberticida del correttismo politico esasperato, all’orrore della cancel culture (che torna ad abbattere le statue), ai divieti antiscientifici di esposizione degli scheletri e via dicendo. Il libro ha un respiro globale che offre una miniera di informazioni. A un certo punto, l’autore pone una domanda, si direbbe, insensata: «Di chi è l’archeologia?» e abbozza tuttavia risposte sensate (ampliare la conoscenza, imparare dal passato, insegnare qualcosa di utile per l’umanità del futuro), che però non lo soddisfano. Dietro l’angolo c’è la domanda trabocchetto se «possiamo davvero arrogarci il diritto, da una prospettiva occidentale, di parlare a nome di tutta l’umanità». Dietro la critica a questo desiderio (che non è un diritto) vedo con preoccupazione il rischio dell’abbandono della prospettiva universalistica della scienza e del libero confronto di idee che la alimenta.
L’archeologia del contemporaneo in dieci oggetti
di Giuliano De Felice, 188 pp., ill., Laterza, Bari-Roma 2024, € 15
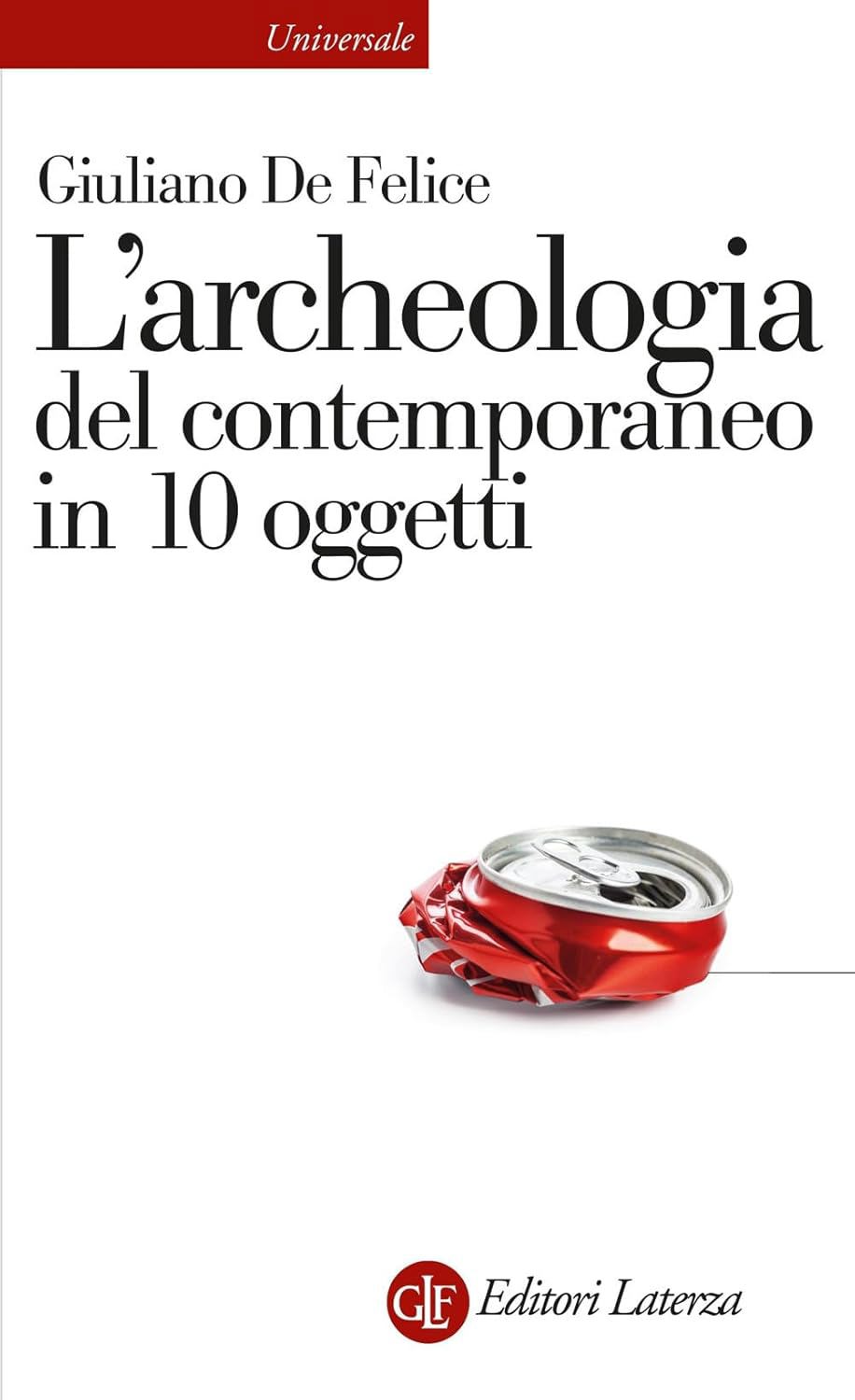
La copertina del volume
Altri articoli dell'autore
Appello al ministro Giuli: nel silenzio generale, si sta decidendo che qualsiasi foto scattata d’ora in poi, magari anche per errore con la fotocamera del cellulare, non potrà essere divulgata liberamente se non a partire dal 2095
A partire cronologicamente dalle citazioni di un fascinoso antiquario cinquecentesco, lo studioso e divulgatore Andrea Augenti ripercorre le vite di alcuni dei maestri del passato di questa disciplina
L’archeologo Daniele Manacorda traccia una road map per il neonominato al dicastero del Collegio Romano
Il vero problema sembra essere la nuova (vecchia) organizzazione per Dipartimenti, già varata ai tempi del ministro Buttiglione e presto abbandonata non per motivi politici, ma perché ritenuta non adeguata a un Dicastero come quello della Cultura, capillarmente distribuito sul territorio