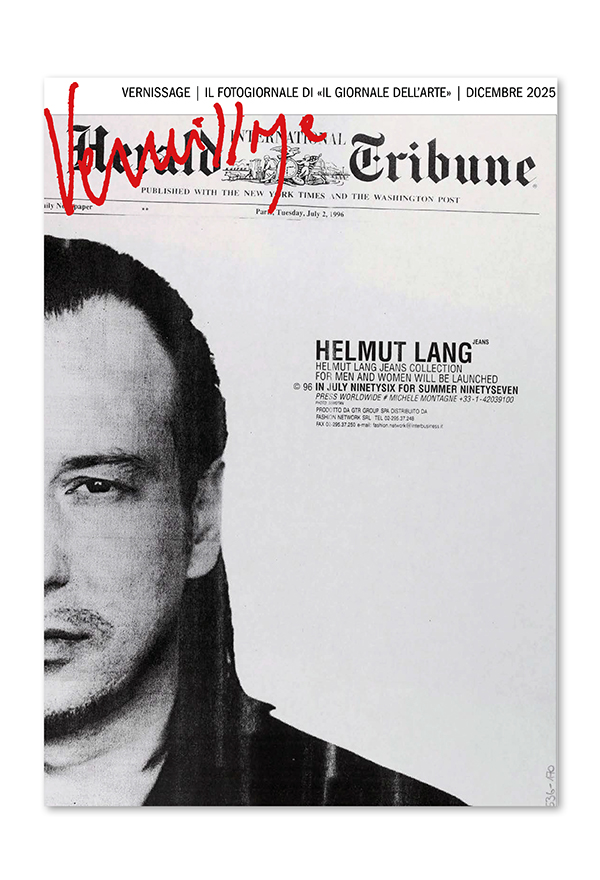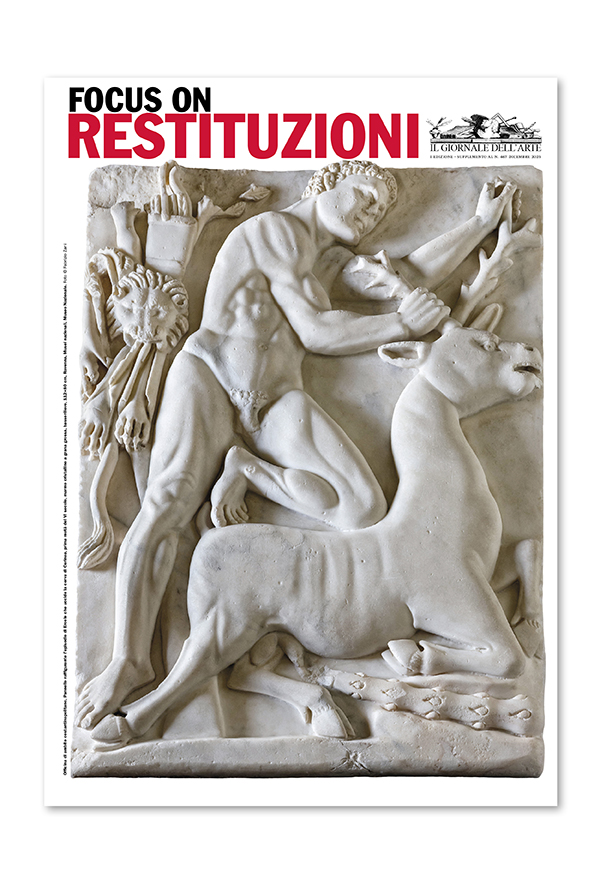Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Jean Clair
Leggi i suoi articoliLa mia prima emozione che potessi qualificare come artistica la provai in un museo scientifico: al Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi, davanti ai piccoli strumenti di vetro e di rame che Lavoisier utilizzava nel suo laboratorio. Si trattava di arte? Il nome del museo lo asseriva: Conservatorio delle Arti e dei Mestieri. Ora non si chiama più così, ma è intitolato «Museo delle tecniche».
Solo più tardi ho ritrovato lo stesso piacere in un museo detto «delle Belle Arti», mi pare fosse davanti alla Madonna del cancelliere Rolin, al Louvre, la cui precisione ottica mi incantava.
E solo più tardi ancora compresi che gli oggetti della scienza erano a volte delle opere d’arte, e che le opere d’arte erano spesso oggetti scientifici. L’estetica a volte poteva essere un’euristica.
La più bella dimostrazione di questa equazione l’ha fatta Claude Lévi-Strauss, a proposito di un ritratto di dama di Cluet di cui ammirava la «collerette». L’emozione profonda, ci dice, che suscita la riproduzione del collo di merletto, filo per filo, con un effetto di trompe-l’œil scrupoloso, è la stessa che produce il modellino a scala ridotta, il capolavoro dell’artigiano, che è il prototipo dell’opera d’arte. Entrambi, per effetto della riduzione, procedono per una sorta di inversione del processo della conoscenza: per conoscere un oggetto, abbiamo tendenza a operare a partire delle sue componenti. La riduzione della scala capovolge la situazione; più piccola, la totalità dell’oggetto appare meno temibile. La virtù intrinseca del modello è di compensare la rinuncia alle dimensioni sensibili attraverso l’acquisizione di dimensioni intelligibili.
La scienza che lavora in scala reale, che rimpiazza un essere con un altro, l’effetto con la causa, è dell’ordine della metonimia, mentre l’arte che lavora in scala ridotta producendo un’immagine omologa all’oggetto rientra nel campo della metafora.
Ars, in latino, ci parla di abilità: è un talento particolare acquisito attraverso lo studio e la pratica (diciamo: «possedere l’arte di...»); una conoscenza legata a un mestiere, un’esperienza del corpo che permette la precisione e l’economia dei gesti, un’attitudine appresa che si schiude all’eleganza, al fascino, alla grazia (diciamo: «fare con arte»). Ars è nel contempo la «maniera» dell’artista e il marchio dell’artigiano. Nel linguaggio popolare francese l’homme de l’art, l’uomo dell’arte, è l’uomo del mestiere. Questa qualità può limitarsi a una parte del corpo, una particolare abilità manuale, un gesto, un’attitudine, per esempio il portamento del ballerino, o la voce posata del cantante o dell’oratore (l’actio nella retorica)... Si parlerà anche della «mano intelligente» dell’architetto, quella sua arte particolare che unisce competenze manuali e intelligenza concettuale.
Da questo punto di vista l’arte, ars, si oppone alla natura, come l’artificio si oppone al naturale. Ma si oppone anche all’ingenium, che non è il genio, bensì l’inclinazione spontanea, la disposizione propria della sensibilità. L’ars è acquisita, l’ingenium è innato. L’ingenium è la capacità naturale dello spirito a produrre, una potenza generativa che è allo stesso tempo predisposizione nativa e invenzione. Vicino a quella che Lévi-Strauss descriveva con il termine di bricolage, l’ingenium è quell’attitudine dello spirito umano a riunire dati eterogenei per produrre qualcosa di nuovo. Oltrepassa i limiti della semplice ragione, è, appunto, quell’eccesso che somiglia a un dono, all’invenzione ingenua, al tratto di genio.
Ars si oppone infine alla scientia, che è un sapere essenzialmente linguistico e verbale, un’informazione, una conoscenza, o l’insieme delle conoscenze acquisite su un soggetto. Cicerone oppone i due termini di ars e scientia quando parla di «artem scientia tenere», possedere un’arte in teoria. Scientia, la conoscenza astratta e generale, non è il sapere concreto e singolare che si incarna in un gesto, in un tour de main, quel linguaggio del corpo che Aristotele chiamava giustamente tèchne: «I Greci, ricorda Ernst Gombrich, avevano un solo termine e un solo concetto per l’arte e per l’abilità: tèchne». La storia dell’arte, per definizione, era la storia delle tecniche.
Se consideriamo le lingue germaniche, ritroviamo più o meno le stesse opposizioni. Kunst, l’arte, deriva dall’alto tedesco können, che ci parla di una disposizione intermedia tra la conoscenza e la competenza, tra il sapere e l’abilità. In ogni caso nulla di comparabile alla pretenzione che oggi dissimuliamo sotto il termine di «arte». Können ha la stessa origine del gotico kann, dell’antico inglese can, nel senso di un potere radicato in un sapere.
Notiamo, per inciso, che können non va confuso, nonostante l’omofonia, con kennen, che significa conoscere, essere al corrente, come to know in inglese: è questo il campo della conoscenza, del knowledge, della scientia.
Già all’origine quindi troviamo nel termine «arte» un’ambivalenza, un’oscillazione tra un savoir-faire che rientra nel campo di un apprendimento e di una conoscenza, dell’ordine del codificabile e del trasmissibile, e d’altra parte una qualità eccezionale, una tendenza particolare di un individuo, uno slancio dell’essere, una disposizione singolare dei suoi organi, delle sue cellule, che gli permetterebbe di esercitare un potere di cui gli altri non dispongono, nonostante abbiano le stesse conoscenze. Ma i due aspetti sono legati: non ci può essere pouvoir-faire senza savoir-faire, né savoir-faire senza vouloir-faire.
Malkunst, nel sedicesimo secolo, è l’arte di dipingere, e cioè quell’insieme complesso di ricette e di conoscenze che permettono all’artigiano di esercitare il suo mestiere. Ma oltre alla chimica che gli permette di preparare i colori, quest’arte complessa riunisce ben altre competenze: la matematica e la fisica che permettono di fondarsi sulla prospettiva come scienza esatta e di disporre correttamente i corpi nello spazio; l’anatomia, insegnata nei teatri di Padova, di Bologna, di Londra, di Vienna; la fisiologia, ossia lo studio del funzionamento dei tessuti, delle carnagioni, degli organi; l’ottica, la diottrica e la catottrica, che permettono di progredire nella scienza dei colori, delle rifrazioni, dei riflessi, delle trasparenze; e anche un po’ di zoologia che permette di distinguere e di tagliare correttamente i calami per disegnare e i peli animali di cui son fatti i pennelli, di martora per esempio... Tutto un insieme di conoscenze e di ricette che hanno permesso all’arte della pittura di passare dallo statuto di ars mechanica a quello delle artes liberales, e all’artista, di non essere semplicemente un abile artigiano ma un letterato, un sapiente, un polymathes, un polytechnes.
Queste dispute di linguaggio sono dispute di frontiere. Da qui l’esitazione tra un Conservatorio delle Arti e dei Mestieri e un Museo delle tecniche. Da qui anche le esitazioni a delimitare, in periodi di rinnovamento, i diversi campi delle conoscenze.
A Bologna, a Palazzo Poggi, si dispiega il sogno di un sapere che coprirebbe l’insieme di tutte le attività umane, dall’Accademia delle Belle Arti all’Accademia delle Scienze, passando per le facoltà di medicina, chirurgia, filosofia, fisica, storia naturale, chimica, ottica, ostetricia, geografia, geologia, minealogia... Sono così riuniti i capolavori dell’arte e i prodigi della scienza. Nello stesso luogo gli affreschi erotici di Nicolò dell’Abate (nella foto) e le cere anatomiche come la «Venerina» di Susini (nella foto ) ci parlano, con una stessa emozione, degli enigmi della morte e dell’amore.
Il mutamento radicale che si è operato verso l’anno 1800, alle soglie del Romanticismo, e che darà al termine arte l’accezione orgogliosa che conosciamo, dipende da troppe cause perché le si possa analizzare anche brevemente. L’arte cessa di essere tour de main, savoir-faire, grazia della mano. Diventa virtuosismo, ipertrofia del singolare, eccesso del particolare. Questa è l’«arte» come la intendiamo oggi, che si limita, per catacresi, a una piccola parte della creazione artistica, quella che si è sviluppata dopo il Romanticismo, l’«arte moderna». Non è più una maniera, ma un manierismo (qui naturalmente non nel suo senso storico), un’arte per l’arte, una pittura della pittura. Prendendo se stessa come oggetto, l’arte moderna rinuncia al dialogo che aveva intrattenuto con le altre forme del sapere.
D’altronde non sarebbe più in grado di intrattenere un dialogo. Davanti all’esplosione delle conoscenze, della scientia, ogni sapere si rinchiude su se stesso. La crescita della scientia sarà accompagnata da un’evoluzione della sensibilità che avvicinerà l’arte, ormai prigioniera della propria autoriflessione, all’ingenium, o piuttosto a quella parte dell’ingenium che ha a che fare con la capacità d’invenzione, trascurando la parte del dono, della disposizione naturale, che la regola doveva dirigere, come sottolinea Cartesio nelle sue Regulae ad directionem ingenii. Arte e genio tendono ormai a confondersi, ma anche, con la scomparsa di ogni regola, genio e follia.
Per dire le cose in breve, quando le scienze, fondandosi a partire da Lavoisier, poi da Claude Bernard, sul metodo descrittivo e sperimentale, trovano il modo di sviluppare il loro territorio indefinitamente e in maniera imperiosa, il territorium artis si riduce invece progressivamente come pelle di zigrino. Liberata dai canoni immutabili della tradizione, ma in preda all’hybris dei moderni, secondo la vulgata del genio e della follia che va da Diderot a Lombroso, la pratica delle arti farà delle proprie opere il prodotto di un cervello sregolato. Fu quindi un’ironia della storia se Condorcet e l’abate Gregorio sognarono, nel 1793, una possibile riunione delle arti e delle scienze, quando l’ideale dei lumi, a quella data, à già morto. L’ars, nel senso antico, non è più capace di affermare la propria coerenza di fronte alle regole della scientia o alle invenzioni dell’ingenium .
Nel 1791, dopo la Rivoluzione, per decreto dell’Assemblea Nazionale, il Palazzo del Louvre doveva essere dedicato, come è scritto, alla «riunione di tutti i monumenti delle scienze e delle arti»... La riunione delle Arti e delle scienze, delle quali un Museo Centrale avrebbe dovuto, secondo gli auspici della Convenzione, raccogliere gli exempla, è un’utopia. A Parigi tre musei, con destini distinti, furono creati nel 1793: il Museo del Louvre, il Muséum d’histoire naturelle e il Conservatoire des Arts et Métiers, e i capolavori delle arti, delle scienze e delle tecniche sono ormai isolati.
Questa separazione dell’arte e della conoscenza si manifesta in modo esemplare nel declino del sapere anatomico.
William Hunter, a Londra, insegnava l’anatomia a degli artisti come Etty e Reynolds oltre che agli studenti di medicina.
In Francia, David e Houdon erano anatomisti minuziosi e rigorosi come gli studiosi del Museo di scienze naturali. E viceversa, questi ultimi, come Vicq d’Azyr per esempio, realizzarono delle tavole anatomiche per nulla inferiori alle produzioni dei migliori artisti dell’epoca.
Un secolo più tardi, Paul Richer, neurologo, assistente di Charcot alla Salpêtrière, ma anche professore di anatomia alla Scuola delle Belle Arti di Parigi, personaggio nella tradizione di un William Hunter alla Royal Academy, sognerà di mettere alla disposizione degli artisti «le acquisizioni più sicure e più recenti della scienza, per quanto riguarda le proporzioni umane» (nella foto). Ma il suo progetto di una «scienza del bello» naufragherà, progetto che avrebbe coronato nelle arti quel che il positivismo aveva fondato nelle scienze, e che sarebbe stato per le arti contemporanee l’equivalente dei trattati empirici, da Dürer a Lomazzo, per le arti antiche. La sua Nouvelle anatomie artistique du corps humain (Nuova anatomia artistica del corpo umano), pubblicata nel 1906, proporrà solamente un accademismo freddo e senza vita.
Solo i regimi dittatoriali degli anni Trenta diffonderanno quelle vignette di corpi troppo razionali, credendo di ritrovarvi gli exempla dell’umanità nuova, muscolosa e sana, che intendevano produrre.
Più fecondo fu il libro pubblicato un anno dopo, nel 1907 (l’anno delle «Demoiselles d’Avignon»), da Marcel Réja, L’art chez les fous (l’arte presso i pazzi). Fu decisamente dalle parti dell’abnorme, del folle, del degenerato che l’arte moderna cercherà, se non i propri modelli, le proprie domande.
A partire dal 1870-1880, i progressi delle tecniche di esplorazione del corpo e soprattutto i metodi di registrazione grafica di Marey avevano reso superflue le conoscenzedell’anatomia descrittiva. E nel mondo degli artisti, il termine «accademia» era nel frattempo diventato peggiorativo, non se ne coglieva più il senso originale.
Ormai conduciamo una doppia vita. Da un lato il mondo intelligibile, dall’altro il mondo sensibile. L’arte ha ceduto il monopolio dell’oggettività alle scienze, conservando solo quella soggettività, quell’ipertrofia morbida dell’ego che caratterizza il sedicente genio dell’artista. La scienza nel frattempo si è tagliata fuori dal mondo reale, perduta nei suoi grafici, e nelle sue specialità così minime che ormai nessun dialogo è più possibile.
Mentre oggi i musei delle arti sperimentano un’affluenza senza precedenti (10 milioni di visitatori per il solo Louvre nel 2012), molti musei delle scienze sembrano essere in decadenza, persino il Muséum National d’Histoire Naturelle di Parigi, che vide, con Buffon, Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Lamarck, la nascita della biologia moderna, e la scarsità dei finanziamenti e dell’interesse conducono a trascurare, a volte persino a distruggere, le collezioni.
Un tale divorzio è una catastrofe spirituale. La scienza continuerà senza dubbio il proprio cammino. E sembra persino credere che tanto più progredirà quanto più non si caricherà del peso della storia, del passato, dei documenti ormai superati del proprio patrimonio. A che cosa può servire una cera di Ercole Lelli quando disponiamo ormai di tecniche di imaging sofisticatissime, che utilizzano i raggi X, gli ultrasuoni, la risonanza magnetica, gli isotopi radioattivi? Ma è l’arte la grande perdente di questa separazione, nonostante le apparenze, nonostante le folle che accorrono alle mostre, nonostante il successo.
Panofsky, allievo di Warburg e di Cassirer, sosteneva che il suo metodo di analisi delle opere d’arte, l’iconologia, si fermava alle soglie dell’arte moderna perché le opere dell’arte moderna avrebbero cessato di fondarsi su un corpus religioso, letterario o scientifico, per non essere altro che i prodotti di una soggettività inafferrabile, o di variazioni astratte sui modi di dipingere, nella specificità di un gesto o di un colore. Queste opere senza soggetto, senza motivo, senza leggenda, dato che in esse si avrebbe «un passaggio diretto dal motivo al contenuto», non potrebbero più essere l’oggetto di una ricerca delle loro fonti «colte», formali, letterarie o scientifiche. Non ho mai condiviso questa tesi. Ho sempre pensato invece che l’arte moderna, come un tempo l’arte antica, continua a fondarsi su un insieme di conoscenze intellettuali e scientifiche, nonostante le fonti siano più vaghe, meno precise, più difficili da reperire. Ma è uno stesso allontanamento dal mondo sensibile che vivono ora gli uni e gli altri, artisti e scienziati. Curare un paziente, era in fondo una pratica non tanto distante da quella del disegno negli anfiteatri delle scuole delle belle arti, fondato sull’osservazione della natura. La vista aveva un ruolo essenziale, giudicava la malattia già a partire dal colore della pelle del malato. Venivano poi la palpazione, il tatto, l’olfatto e persino il gusto, dato che non si esitava a assaggiare il sapore degli umori; tutta una sinestesia permetteva di tratteggiare il «quadro» clinico, di arrivare o no alla conclusione di un «bel caso». Ricordiamo la sensualità delle descrizioni delle malattie nella Madame Bovary di Flaubert, la precisione nelle descrizioni degli odori, degli incarnati...
Ma il vecchio Cézanne o il giovane Picasso avevano ancora bisogno di osservare, di interrogare il nudo, la verità brusca del corpo, il suo odore, il suo sapore, per far avanzare la loro arte? Ricordiamo le stupefacenti e sgradevoli bagnanti di Cézanne: che pena, che fatica per accennare a un corpo! Una grazia si è persa, una prossimità della carne e del suo conforto. Il modello, si direbbe, non serve più, si riveste, si allontana, apre la porta per andarsene. Forse per sempre?
Il fatto è che «Les Demoiselles d’Avignon» (nella foto) porteranno il malessere al suo estremo, al punto che il quadro, incompiuto, resterà a lungo invisibile. E la sua vista era e rimane insopportabile. Numerosisimi studi anatomici l’avevano preceduto, alcuni corredati di misure e di cifre precise, come se Picasso avesse tentato, fino allo scacco infine riconosciuto, di fondare una nuova teoria delle proporzioni del corpo umano.
Il fatto è però che il passaggio dall’esoscopia all’endoscopia, dalla macroscopia alla microscopia, sembra segnare la separazione tra un’arte che vuole render conto del visibile e una scienza che affonda nell’invisibile, e che invece di rappresentare delle superfici registra ormai delle relazioni.
Il mondo era un tessuto che percorrevano gli occhi dell’artista come quelli dello scienziato, e che entrambi descrivevano, con un risultato la cui bellezza risultava dall’arte come dalla conoscenza. Ma una volta che le scienze avranno occupato con autorità i diversi campi del sapere, l’artista, scacciato da un regno che condivideva da pari a pari, rimandato all’empirismo dell’artigiano («stupido come un pittore»), non potrà far altro che darsi al soliloquio o al vaticinio, alla ricerca di uno status ma anche di un mestiere perduto.
Ma il divorzio è veramente così radicale? Non ne sono sicuro.
Nella prima mostra, su Marcel Duchamp, che ho realizzato nel 1977 per l’apertura del Centre Pompidou, ho voluto mostrare che l’opera di Duchamp lungi dall’essere quella di un iconoclasta e di un provocatore era stata, almeno fino al 1920, il tentativo eroico, disperato, di rifondare l’arte della pittura sulla scienza del suo tempo. Ho quindi mostrato che, lettore attento e appassionato di Raymond Poincaré e di Esprit Jouffret, aveva tentato di sviluppare una nuova arte della prospettiva fondata sulle geometrie pluridimensionali; la sua prospettiva fondata sulla quarta dimensione doveva essere rigorosa come quella immaginata all’epoca del Rinascimento da Alberti attraverso la sua parete di vetro. Il risultato fu il suo «Grand Verre», «La sposa messa a nudo», al quale lavorò senza interruzione per dodici anni. Siamo lontanissimi dall’immagine caricaturale che si è voluta dare dell’autore dell’orinatoio e dei ready made...
Vorrei anche ricordare che quando mi fu chiesto di realizzare la mostra per il Centenario della Biennale di Venezia, nel 1995, scelsi il tema «Identità e alterità», e decisi di fondare la scelta delle opere e il senso del percorso sull’insieme delle scoperte scientifiche del 1895, che furono decisive non solo per la forma, ma anche per il senso dell’arte moderna, e in particolare nel campo del ritratto. Furono Lumière, Roentgen e Marconi che sconvolsero la nostra visione della forma umana.
Furono anche i medici, neurologi e psichiatri, l’invenzione dell’isteria e della degenerazione, Charcot in Francia e Lombroso in Italia (nella foto), e lo studio dei sogni grazie a Freud e alla scoperta dell’inconscio, che, compresi più o meno bene dagli artisti, incamminarono l’arte sulle vie tumultose che da Munch e Ensor a Lucian Freud e Picasso, hanno dato forma all’arte del nostro tempo.
Così la storia delle avanguardie, tra il 1860 e il 1914, lungi dall’accompagnare, e ancor meno annunciare, il progresso delle scienze e delle tecniche, è piuttosto un movimento erratico, incoerente, spesso disperato: alla ricerca di una nuova legittimità, di nuovi modelli,
si rivolgerà a quel che crede comprendere delle nuove geometrie e dei nuovi spazi, e anche alle nuove immagini prodotte dalle scoperte astronomiche e fisiche (i raggi X), e più in generale alla fotografia.
Ma in un mondo in cui ormai l’invisibile rimpiazza il visibile, questa ricerca di nuovi riferimenti, di configurazioni ancora accessibili all’occhio condurrà l’arte a subire il fascino delle produzioni più confuse al margine del progresso, l’occultismo, lo spiritismo, la medianità, che pretendono di provare attraverso la fotografia l’esistenza di radiazioni e di poteri oscuri. Tutte queste pseudoscienze che proliferano intorno alla fine del diciannovesimo secolo fanno credere, in un mondo che la scienza ha «disincantato», all’esistenza di universi inaccessibili ai sensi come alla ragione, mondi «extra-retinici» attraversati da onde e da effluvi che la nuova pittura e la nuova scultura vogliono rivelare.
Duchamp, Kupka, Malevic, Mondrian, Kandinskij, per citare i nomi più conosciuti della modernità, saranno attratti durevolmente da tali fantasmagorie.
Più tardi, nel dopoguerra, il ricorso alle droghe, ancora fortuito e occasionale per i romantici, diventa sistematico, da Henri Michaux ad Arnulf Rainer, da Antonin Artaud a Stanisław Witkiewicz, e spingerà (definitivamente?) l’esperienza artistica verso una sperimentazione perigliosa, dove la conoscenza avanza sull’orlo del baratro, diventa perdizione, caduta negli abissi, prova incomunicabile.
Si sarebbe tentati di pensare che l’arte e la conoscenza hanno preso irrimediabilmente cammini divergenti. Rimangono tuttavia dei campi in cui l’arte mantiene intatto il suo prestigio, e conserva le chiavi del proprio regno. È il caso per esempio del disegno d’osservazione. Al liceo un’ora alla settimana era dedicata a questa pratica. Ma non era tanto davanti alle nature morte fatte di qualche flacone e qualche bottiglia, o davanti ai gessi grigiastri che l’attenzione si concentrava, ma piuttosto durante le ore più numerose delle lezioni di storia naturale. Che piacere disegnare le conchiglie fossili, gli ammoniti. L’occhio seguiva le volute che si dispiegavano con la crescita dell’animale. Mentre la mano correva sul foglio, il labirinto si chiariva; si indovinava a poco a poco lo sviluppo del nautilo, e infine come per miracolo le astrazioni più austere, come la legge di Fibonacci, prendevano corpo. Fatto notevole: non importava che il disegno fosse corretto. Non eravamo nel campo del mimetico, ma in quello del grafico. Disegnare una conchiglia non pertiene all’estetica ma all’euristica.
Tirare un tratto, estrarre un filo dalla matassa del visibile, è uno sforzo dell’intelletto, implica comprendere quel che abbiamo sotto gli occhi, elucidare, portare alla luce quel che non si era ancora mai visto, e quindi mai capito; disegno di osservazione, quindi, rivolto alla comprensione pura, leggibile come una scrittura, all’opposto della correttezza accademica. Una volta tracciato il primo tratto, gli altri seguono, come una matassa di cui si tira un filo. Questo intreccio suppone un equilibrio. L’intelligibilità pura del tracciato matematico, come la pura sensibilità del tracciato istintivo ne sono esclusi. L’occhio ha bisogno in ogni momento di nutrirsi della prova del reale, così come lo spirito deve continuamente verificare la validità del tratto. È questo fenomeno, dell’ordine della conoscenza come del piacere, docere et delectare, diceva l’Arte poetica di Orazio, che Goethe ha riassunto nella sua celebre frase: «Quel che non ho disegnato, non l’ho visto».
L’occhio da solo non può che registrare le impressioni, ma non le distingue ancora. Lo sforzo di distinzione, di discriminazione, che è uno sforzo dell’intelletto, è la mina della matita, tra le dita, come lo scalpello del chirurgo, che lo guida.
Intelligere ed eligere sono prossimi. Eligere vuol dire scegliere, l’elezione è eleganza. Ma il francese choisir, scegliere, ricorda Littré, deriva da un termine germanico che significa vedere, scorgere, discernere. Scegliere nel senso di eleggere non appare che nel quattordicesimo secolo. Vedere, comprendere e distinguere sono quindi, come dimostra la lingua, una sola cosa. Intelligenza ed eleganza sono legate, nella lingua come nella pratica del disegno.
Ritorniamo all’ammonite: quando Cuvier, al Muséum, si confrontò con i primi fossili, si mise a disegnarli. In quelle forme schiacciate, incastrate l’un l’altra, ripiegate, frammentate, non vi era alcuna intelligenza che l’occhio potesse cogliere. Disegnare era già estrarre dal blocco di scisto o di marna, tracciare i tratti, le linee direttrici che permettevano di ricostituire le forme dell’animale fossile. E i disegni di Cuvier sono degli ammirevoli disegni naturalisti, di un’epoca in cui ciascuno era fiero di saper disegnare.
Un esempio contemporaneo del potere ermeneutico del disegno ci è fornito dal paleontologo americano Stephen Jay Gould, che racconta come i famosi fossili del sito dello scisto di Burgess sono stati reinterpretati a partire da una serie di disegni, creando uno sconvolgimento radicale delle conoscenze in paleontologia. Quel che le fotografie dei reperti non avevano potuto fare, dei semplici tratti sulla carta, dei disegni tracciati a mano libera erano riusciti a far apparire.
La fotografia in effetti, sotto l’apparente precisione del suo macchinario, è un’illusione, che ci induce a abbandonare la preda variegata del sensibile per inseguire l’ombra grigia del cliché. Nadar prima di fotografare i propri modelli non tralasciava mai di disegnarli. Era il disegno che gli permetteva di vedere il volto dei modelli; solo in seguito li poneva davanti all’obiettivo. Ed è stata la pratica assidua del disegno a partire dall’adolescenza, e mai abbandonata, che ha dato ad Henri Cartier-Bresson la sua straordinaria abilità di catturare il «momento decisivo».
Il neurologo spagnolo Santiago Ramón y Cajal che riceverà il Premio Nobel nel 1906 per la scoperta del neurone, è senza dubbio un esempio tra i più puri di uno scienziato che metteva l’occhio al servizio dello spirito. Abile disegnatore e infaticabile osservatore, di una curiosità visiva insaziabile, aveva dapprima pensato di fare l’artista, poi si interessò alla fotografia e mise a punto, prima dei fratelli Lumière, una tecnica di riproduzione in tricromia,. Ma è stato mentre disegnava quello che vedeva in un microscopio che riuscì a vedere quello che nessuno prima di lui aveva compreso. Nella matassa inestricabile della materia grigia del cervello che osservava al microscopio, colorata con i sali d’argento sviluppati da Golgi, disegno dopo disegno, schizzo dopo schizzo, fece apparire sul foglio di carta la figura del neurone, e la maniera che ciascuno ha di collegarsi con gli altri attraverso mille ramificazioni. Riuscì così a descrivere l’organizzazione della parte più complessa del corpo umano. Quelle «farfalle dell’anima», come aveva definito quei corpi aracnei, il cui battito d’ali è il volo del pensiero, nessuno prima di lui le aveva viste. I disegni di Ramón y Cajal, nella loro fragilità grafica e cromatica, conservano la grazia del mito antico. Ma sono anche uno dei monumenti eretti al potere dell’intelligenza di districare, con l’esercizio della ragione e dell’occhio, l’intrico più complesso che esiste: nella corteccia, la sede stessa dell’intelligenza.
Altri articoli dell'autore
Dall’ultimo libro di Jean Clair, uscito da poche settimane in Francia e dedicato agli amici, pubblichiamo in anteprima il ritratto di Gianadda, scomparso lo scorso 3 dicembre
Era il decano dei galleristi francesi, vicino ai grandi del suo tempo: da Bacon a Balthus
Zeri aveva suggerito che «fare l’arte moderna è molto più difficile che fare l’arte antica», ma per il celebre saggista e accademico di Francia «i falsi sono molto più numerosi nell’arte moderna che nell’arte antica». Feticci creati dal mercato
«Il Borghese incoraggia le belle arti (...). La sua intima aspirazione è mettere il Bello a terra, al di sotto della peggiore immondizia, e in queste basse opere nessuno puo' superare i porci artisti» (Léon Bloy)