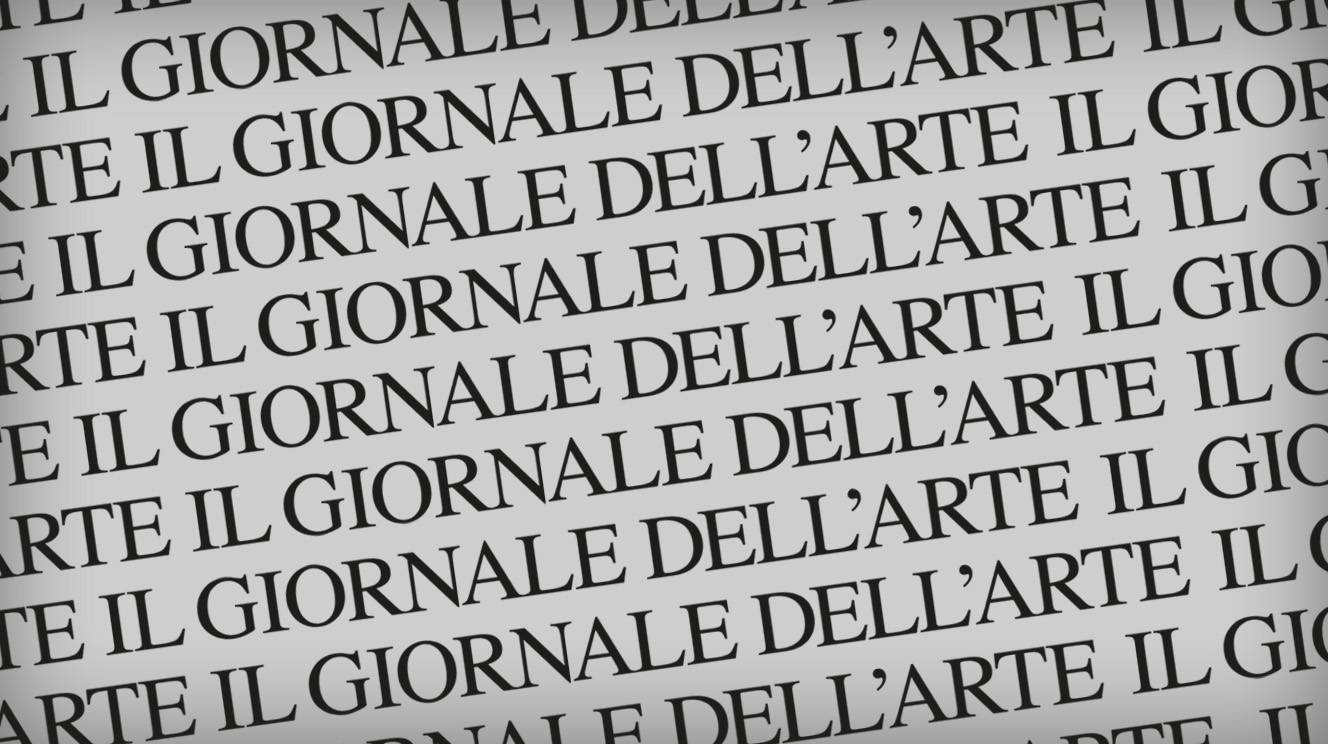Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fernando Mazzocca
Leggi i suoi articoliUna nuova retrospettiva di Francesco Hayez riporta d’attualità anche un corpus di suoi disegni che lo vedono protagonista di scatenate performance erotiche con la sua modella e allieva
Un angelo androgino o una Madonna in un paio di dipinti; una scatenata partner di acrobatiche performance erotiche in una serie di 19 (in origine erano 20) disegni aventi come protagonisti il loro autore, Francesco Hayez, e la sua modella, allieva, amante e poi collega Carolina Zucchi. Quei fogli tornano d’attualità ora che, sino al 21 febbraio, le Gallerie d’Italia - Piazza Scala a Milano, a cura di Fernando Mazzocca, ospitano 120 dipinti dell’artista (1791-1882) veneziano di nascita ma milanese d’adozione. I disegni sono stati pubblicati nel libro Hayez privato. Arte e passioni nella Milano romantica (edito da Umberto Allemandi & C. nel 1997), introdotti e commentati dallo stesso Mazzocca. Ripubblichiamo uno stralcio del suo saggio «I “modi” di Hayez e Giulio Romano al ballo Batthyany. Epilogo viscontiano».
Hayez ebbe in Carolina la straordinaria complice nella creazione di quadri sensuali e provocatori, davvero unici nel panorama del nostro Romanticismo, tutto manifestatosi, soprattutto in una letteratura dominata dal magistero manzoniano, sotto il segno di languori e reticenze sentimentali. Così questa serie di diciannove scene, tracciate con un segno deciso su diciotto fogli leggeri di carta semitrasparente, risulta la testimonianza più diretta di questa grande complicità.
Ne è base il sesso, un sesso consumato e improvvisato, ogni volta in modo nuovo, tra le pareti dell’atelier, in giacigli improvvisati, due cuscini su un cassone, una tavola posata su due cassette, un materasso buttato a terra, una poltrona, tra l’acuto odore delle vernici. La scena dei loro amori, questi amori che nella fantasia erotica davvero sfrenata dei due amanti diventano gli amori degli dèi, fu in realtà l’ambiente piuttosto dimesso, ma pervaso dalla presenza magnetica e dall’ardore di questo geniale creatore, descritto da Defendente Sacchi. (...) Se non gli interessava conservare memoria delle sue opere, volle invece consegnare all’eternità i gesti di quell’amore appassionato, di quel rapporto fatto di infinita disponibilità al reciproco godimento.
Lui veneziano, una città che aveva dato all’erotismo le migliori espressioni artistiche, intendeva forse con questi disegni, che sono dunque qualcosa di più di un diario privatissimo, proiettare, al di là dei limiti dell’esistenza terrena, l’eros e il proprio desiderio, così come Casanova e l’immortale Giorgio Baffo, il quale alla funerea lapide de «El mio cazzo xe morto e io non moro», opporrà l’invocazione escatologica: «Del mio cazzo me par sentir la vose / dai Campi Elisi a dirme che ’l m’aspeta».
Questi disegni che sembrano proprio tracciati con una matita affilata, sempre in erezione, senza mai staccare la punta dal foglio, con forza ma anche con infinita delicatezza tale da non lacerare il fragile supporto, sono un vero miracolo di naturalezza e a loro modo di innocenza. Rispetto ai casi precedenti, come quelli di Giulio Romano, Agostino Carracci, Füssli, o successivi, Beardsley, Klimt, Schiele, Picasso (meglio sorvolare sulla pornografia di Guttuso), rivelano l’assoluta mancanza di ogni filtro colto, di una qualsiasi allusività. Né sono, come accade soprattutto in Füssli, la proiezione di desideri inconfessabili e irrealizzabili o di pulsioni perverse. Tutto vi scorre solare, all’insegna di una perfetta intesa tra due anime affini e i loro corpi.
L’artista appare in perenne contemplazione, visiva e tattile, del sesso dell’amata, tanto da far pensare ai versi de Il Vaso di Pandora, una raccolta anonima di sonetti erotici pubblicata nel 1861: «Mi mostrava una potta tanto bella / che la bocca parea d’un angioletto!».
Si tratta di giochi amorosi basati sull’inventiva del momento, sollecitata da due amanti che conoscono molto bene i propri corpi e i desideri reciproci, in una consuetudine erotica dove l’intesa, la fantasia e probabilmente anche un grande amore sembrano consentire tutto. È un eros, senza sensi di colpa e reticenze, consumato lentamente e a luci accese. I due innamorati si guardano. Lui la fissa intensamente, premendole con la mano la testa, mentre lei gli lavora il cazzo con labbra esperte, o mentre la penetra o la sonda con le dita. Anche lei lo guarda e nel più bello dei disegni l’eccitazione viene esaltata da un doppio gioco di specchi. A volte sono nudi, altre appaiono ancora semivestiti. Ironica la notazione dei due disegni, l’uno in cui Carolina, completamente nuda, viene presa da dietro o avanza la sua potta verso la bocca del pittore, con i piedi ancora in ciabatte. Le ciabatte di Giulietta.
Nel foglio numerato 9 appaiono entrambi in calze e giarrettiera. I disegni, insieme ai due ritratti del 1822 e ad altri bei materiali hayeziani, passarono evidentemente da Hayez a Carolina e da questa, scomparsa ancora giovane, prima della moglie dell’artista, nel 1848, alla sorella Caterina Calderara. Del resto le altre opere, come una versione del «Bacio» del 1859 donato da Hayez a quella famiglia, dimostrano che i loro rapporti non furono interrotti dalla morte di Carolina e che tanto gli Zucchi quanto i Calderara erano a completa conoscenza della relazione che, pur nel riserbo delle mura domestiche, fu vissuta come un vanto e niente affatto un’onta.
Non si sa quando e per mano di chi i fogli vennero a un certo momento datati con una numerazione che va da uno a venti e che ci conferma la mancanza per ragioni sconosciute del disegno con il numero 3. Al di là di questa piccola mutilazione è significativo che i disegni di Hayez, affidati a una memoria familiare tanto gelosa quanto priva di pregiudizi, siano giunti senza quella damnatio che ha colpito tante produzioni, sia letterarie sia figurative, di questo genere.
Il caso più noto rimane quello dei cosiddetti «Modi» di Giulio Romano, una serie di disegni relativi alle differenti posizioni assunte da sedici coppie durante l’amplesso. Ora, trattandosi anche nel caso di Hayez di «modi», quello al pittore rinascimentale sembra il riferimento più legittimo. Anche se le immagini di Giulio Romano, tradotte verso il 1524 in incisioni da Marcantonio Raimondi per abbellire la stampa dei Sonetti lussuriosi dell’Aretino, furono oggetto di una vera e propria persecuzione, che le rese molto rare, certamente Hayez doveva esserne a conoscenza. (...)
Però va sottolineato che, nonostante l’evidente richiamo, in realtà i «modi» di Hayez, così realistici, non hanno nulla a che spartire con gli artifici contorsionistici delle «figure lascive», tracciate da Giulio Romano «per trastullo de l’ingegno», e, come è noto, ispirate non a un’esperienza vissuta, ma a una rara fonte antiquaria, le monete romane chiamate «spintriae», impiegate durante il primo secolo dopo Cristo come gettoni per l’ingresso nei bordelli, onde evitare, utilizzando monete di uso corrente, di profanare l’immagine degli imperatori. Se mai i disegni hayeziani sono più vicini in spirito proprio alla più franca licenziosità dei sonetti dell’Aretino, di cui il giovane pittore ottocentesco poteva benissimo condividere quello stupendo elogio del cazzo, che è del resto il vero protagonista dei disegni, e insieme tra le più esaltanti difese della libertà privata (...).
Stabilito che «I Modi» di Giulio Romano costituiscono non una fonte, ma un semplice precedente e una più che possibile suggestione per i disegni di Hayez, è molto probabile che l’idea gli sia venuta non tanto ammirando le stampe originali del Raimondi (i fogli di Giulio andarono presto perduti), che come sappiamo erano e sono rarissime, quanto la loro divulgazione più recente. Credo infatti che il giovane pittore veneziano nei suoi scandalosi anni romani abbia avuto più d’una occasione, data la frequentazione di quell’artista, d’avere sottomano la serie delle venti acqueforti intitolata la «Scuola di Priapo», incisa nel 1810 da Bartolomeo Pinelli e liberamente ispirata a «I Modi».
L’invenzione manierista era stata reinterpretata in un registro più realistico, se non francamente spinto, contemporaneo e popolareggiante. Come se quelle fonti classiche dell’immaginario erotico fossero passate attraverso la corrosiva oscenità della ispirazione dialettale del Belli. Come Porta, come lo stesso Hayez, che del resto egli dimostrò di apprezzare assai durante il soggiorno milanese del 1827, il poeta si vanta di una esuberanza virile illimitata, quando con la sua Teta «pe’ terra, in piedi, addoss’ar muro, a letto, / come c’ho trovo d’addoprà l’ordegno, / n’ho fatto stragge: e pe’ tutto, sii detto / senz’avantamme, ciò lassato er segno».
Altri articoli dell'autore
Fernando Mazzocca ricorda lo studioso, e amico, uno dei maggiori e originali conoscitori e storici della pittura veneta e lombarda tra Sette e Ottocento. Autore del catalogo dei dipinti del Piccio, lascia incompiuto il volume sui disegni
Era arrivato nella Ville Lumière senza soldi, ma in pochi anni l’artista pugliese conobbe uno strepitoso successo. Ora in Palazzo Reale a Milano si ricrea lo spirito della retrospettiva con cui nel 1886 la Galleria Bernheim Jeune aveva celebrato il pittore
Il curatore Francesco Mazzocca propone un approccio inedito all’opera dell’iniziatore del Romanticismo: il confronto tra importanti dipinti e i rispettivi disegni preparatori
Circa 200 opere per la prima mostra dedicata alla declinazione italiana del movimento. Il curatore Fernando Mazzocca la presenta in anteprima