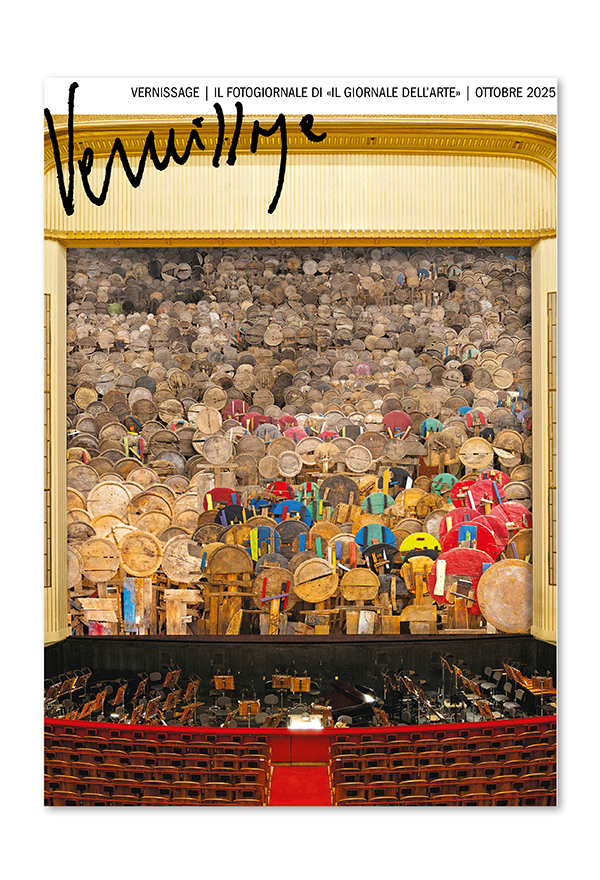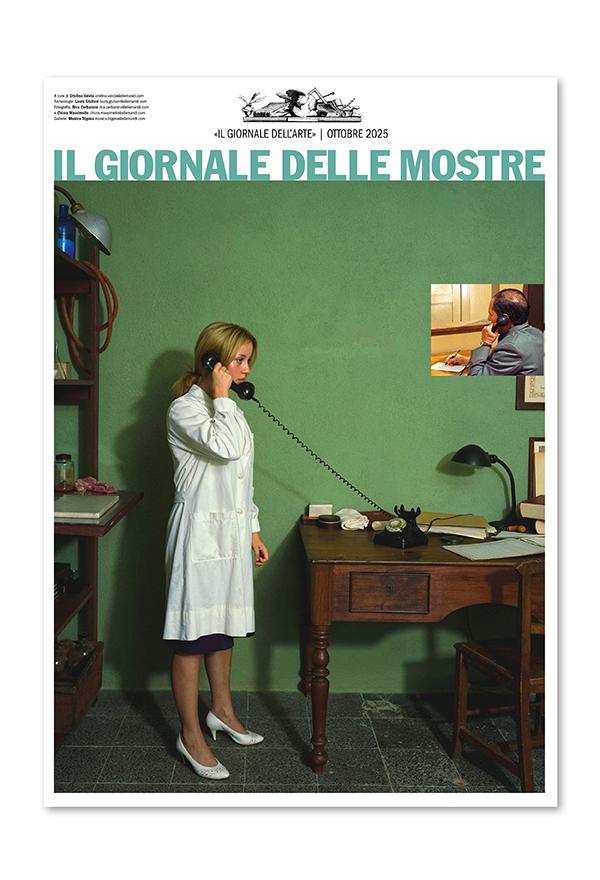Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Luana De Micco
Leggi i suoi articoliPer la prima volta a Artissima (31 ottobre-2 novembre), la galleria parigina Bremont Capela presenta le composizioni, tra astrazione e figurazione, di Madeline Peckenpaugh, giovane artista statunitense (nata nel 1991 nel Wisconsin), basata a New York, che è stata accolta in residenza per due mesi al palazzo Monti di Brescia. La Bremont Capela invece non ha participato a Art Basel Paris, tra le fiere d'arte contemporanea più attese in Europa «Abbiamo fatto una scelta sostenibile – spiega a «Il Giornale dell’Arte» Martin Bremont, co-fondatore della galleria parigina nel 2018, insieme a Julien Capela. «Ormai il modello delle fiere è cambiato. Prima erano incubatori per le giovani gallerie ma, anche a causa della crisi economica, questo ruolo è stato messo in discussione. Sempre più colleghi rinunciano alle grandi fiere internazionali che implicano costi enormi, impossibili da affrontare per gallerie emergenti come la nostra, e il trasferimento spesso in aereo delle opere, con un impatto ambientale importante. Artissima è una fiera a taglia umana, dai costi contenuti e le tele di Madeline Peckenpaugh, con la quale stiamo realizzando un progetto artistico sul lungo termine, fanno un semplice viaggio in camion da Brescia e Torino. Ritengo che le grandi fiere mettano in pericolo tutto l’ecosistema». Quando Martin Bremont ci ha fatto visitare la galleria, a ottobre, era allestita una mostra di Sofia Salazar Rosales, artista ecuadoriana, classe 1999, che ha ricevuto di recente l’Art Basel Awards.
Con le sue sculture, che includono oggetti della tradizione e delle credenze dell’Ecuador, l’artista, basata a Parigi da alcuni anni, riflette sui temi della mondializzazione e dello sradicamento. Attualmente, e fino al 22 novembre, la galleria ospita i lavori di Louise Vo Tan, artista franco-vietnamita, che lavora sui luoghi «spazzatura» del mondo e il tema del riciclaggio, e di Blake Daniels, artista queer americano che si interroga sull'identità. Tra gli altri artisti rappresentati ci sono l’americana Betty Tompkins, artista femminista di 85 anni, che riflette sulla oggettivazione dei corpi, o ancora Nadia Ayari, Emmanuel Massillon, Erin M. Riley. La galleria difende un approccio «sociologico» all’arte e cavalca i temi di società che interessano i giovani. Siamo al 13 rue Béranger, alle porte del quartiere del Marais, quartiere tradizionalmente noto per le sue gallerie d’arte. A due passi da lì, del resto si trovano gli spazi di Thaddaeus Ropac. Martin Bremont ha dieci anni di esperienza in due grandi gallerie francesi, Almine Rech e Perrotin. Prima ancora ha lavorato per Art Price, leader delle banche dati sulle quotazioni e gli indici dell’arte. Ha studiato scienze politiche a Firenze e ottenuto un master in economia della Cultura alla Sorbona di Parigi.
Che sfide devono affrontare oggi le gallerie emergenti?
L’epoca fantastica dei Perrotin, White Cube e gli altri grandi galleristi, che hanno trasformato per sempre il mercato dell'arte e verso i quali ho una profonda ammirazione, sta finendo. Appartengo ad una generazione di galleristi, e lo vedo confrontandomi con i miei colleghi, i cui obiettivi sono cambiati. Le gallerie emergenti, come la nostra, non aspirano più a diventare grandi e a aprire sedi in tutto il mondo. A Parigi c'è una rete di relazioni sufficiente per diventare visibili e per sviluppare collaborazioni con le gallerie all'estero. Nessuno di noi ha più l'ambizione di correre in aereo in giro il mondo tra New York e Hong Kong. In assoluto, non mi dispiacerebbe aprire una sede in Italia, dove il mercato dell'arte va molto bene, ma soprattutto per un interesse personale, Penso che la sfida maggiore è riuscire a fare della galleria un luogo di scambi e di incontri.
Negli ultimi anni, Parigi ha conosciuto una rinascita come capitale europea del mercato dell’arte contemporanea, soprattutto dopo la Brexit. Come percepisce questo cambiamento dall’interno?
Nessuno si precipita più a Londra. Ormai le gallerie stanno chiudendo. Personalmente, non riesco a capire questa strategia britannica post-Brexit di rendere complicati gli spostamenti e le procedure. Ma, diciamoci la verità. Ciò che rende Parigi attraente è innanzi tutto Parigi. Rispetto a Londra, Parigi è una città piacevole, ricca di musei, di begli alberghi, di ristoranti dove si mangia bene. I collezionisti da New York e Pechino preferiscono venire qui che andare a Londra.
Quali sono i punti di forza e i limiti del mercato parigino rispetto ad altre piazze?
Come dicevo prima, la forza di Parigi è Parigi. È una splendida vetrina per tutti, artisti, galleristi e mercanti d'arte. La strategia di Art Basel è chiara: se Parigi non sostituirà mai Basilea in termini di volumi di commercio, è però molto più attraente e richiama collezionisti da tutto il mondo. Il punto debole della piazza parigina, invece, è che non c'è un rinnovamento generazionale di galleristi. Qui a Parigi, collezionisti di meno di 45-50 anni quasi non ci sono più. La fiera d'arte contemporanea più grande, Art Basel Paris, non è parigina. La seconda, Paris Internationale, conta una sola galleria parigina nel consiglio di selezione. In Italia, le misure prese per alleggerire la fiscalità dei più ricchi hanno permesso di interessarsi di più al mercato dell'arte in Italia e a dei collezionisti di installarsi nelle grandi città, come Milano. Ma non penso che una fiscalità diversa potrebbe cambiare davvero qualcosa in Francia. Lo Stato sostiene molto l'arte. Gli artisti godono di diverse agevolazioni ed ecco perché in tanti si trasferiscono qui per lavorare. Ma non è il solo motivo. È da Parigi che passano i grandi collezionisti di tutto il mondo.
Come è cambiato allora il profilo del collezionista?
Il collezionista parigino «storico» è più maturo e istruito sull’arte e, poiché ha le risorse economiche, è cliente delle grandi gallerie della rue Saint Honoré. Non cerca artisti emergenti. Oggi i giovani preferiscono la campagna alla città, dove la vita è più cara, e vengono a Parigi o viaggiano all'estero più per vivere un'esperienza che per possedere tanti oggetti. Il ruolo delle gallerie emergenti come la nostra è di accompagnare questi nuovi potenziali collezionisti e farli incontrare con gli artisti che parlano alla nostra epoca. In galleria proponiamo molte opere al di sotto dei 10mila euro.
Cosa ha portato con sé, nel fondare la sua galleria, dall’esperienza con Almine Rech e Perrotin?
Da Emmanuel Perrotin ho imparato il rigore, la strategia, come si sviluppa il mercato di un artista. Da Almine Rech, dove sono stato dal 2020 al 2024, ho imparato invece ciò che non si deve e per questo la ringrazio. Dopo la crisi sanitaria del Covid, il mercato dell'arte è esploso. Di fronte alla domanda, alcune gallerie, come quella di Almine, hanno stimolato la produzione delle opere e aumentato i prezzi. In questo periodo, dunque, la quotazione di tanti giovani artisti è cresciuta. Il mercato digeriva tutto. Ma secondo me è stato un errore. Rari sono stati gli artisti come Claire Tabouret che hanno avuto l'intelligenza di non cadere nella sovrapproduzione e nel guadagno facile, preferendo appoggiarsi alle grandi istituzioni e facendo mostre nei musei. È a quel punto che ho deciso di fondare la mia galleria. Avevo voglia di applicare la mia strategia: secondo me, i giovani artisti non devono essere prigionieri del mercato. Voglio che qui possano esprimersi liberamente.
Quando è nata la passione per l’arte?
A Firenze. Durante i miei studi, mi ha affascinato il rapporto tra gli artisti e i mecenati. Senza famiglie come i Medici, non ci sarebbe stato il Rinascimento. Ero curioso di capire i legami tra arte e mercato, un mondo opaco, senza razionalità, dove i prezzi delle opere sfuggono a tutte le regole della trasparenza. Ho imparato che la storia dell'arte e il mercato dell'arte sono due mondi paralleli che ogni tanto, e sempre più spesso oggi, si incrociano. Sono le grandi gallerie, le Maison d'asta, i collezionisti a fare il mercato e che hanno deciso oggi che Jeff Koons doveva essere l'artista vivente più caro. Per la storia dell'arte è cosi? Personalmente non credo. Può dar fastidio, si può non essere d'accordo, ma di fatto è cosi. È un mondo affasciante.
Come si proietta tra dieci anni?
Già sarebbe bello restare in vita.
Altri articoli dell'autore
Tra spiritualità queer e tradizione nativa, l’artista nativo americano porta a Parigi, da Hauser & Wirth, la forza poetica del corpo politico
Nel centenario della morte, al Mcba oltre 300 opere ricostruiscono l’intero percorso, dalla formazione alla maturità, del pittore, incisore e scrittore
Il 25 ottobre inaugura la nuova sede in place du Palais-Royal progettata dall’architetto Jean Nouvel: l’ex Louvre des Antiquaires, un palazzo dell’800 haussmanniano
Ai Beaux-Arts de Paris una cinquantina di disegni e stampe illustrano l’impresa decorativa del castello di Francesco I