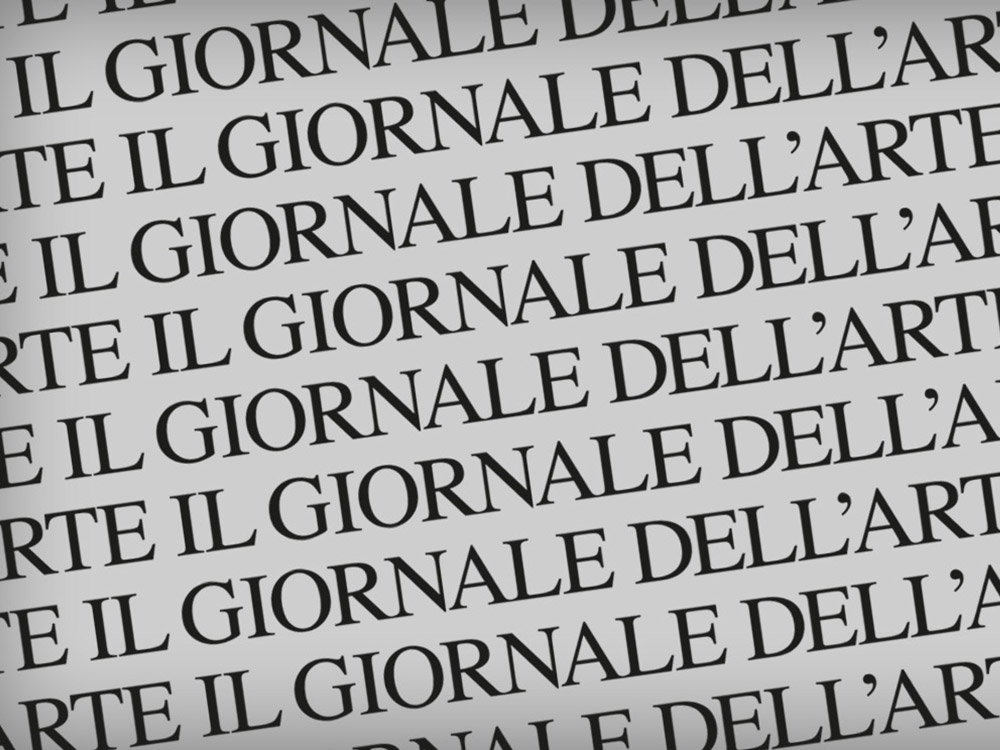Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Andrea Merlotti
Leggi i suoi articoliPer comprendere le ragioni e il senso di questa nuova rassegna, organizzata dalla Reggia e curata da chi scrive con Silvia Ghisotti, è necessario guardare a quella di dieci anni fa. Non tanto perché fra le due esista un dichiarato rapporto sul terreno narrativo (cronologicamente questa inizia là dove quella terminava), ma perché entrambe rispondono a una comune necessità di rinnovamento, da più parti avvertita.
Nel 2007 l’intento dei curatori era duplice. Da un lato, raccontare al pubblico la storia di una Reggia che usciva da un restauro decennale e, prima ancora, da un oblio di quasi due secoli, durante i quali la natura di residenza reale era stata progressivamente dimenticata, piegata a destinazioni d’uso che avevano finito col porne a rischio l’esistenza stessa. Dall’altro lato, ripresentare a questo stesso pubblico una storia, quella dei Savoia fra Cinque e Settecento, che era stata prima ricoperta dalle incrostazioni del nazionalismo, e poi, per ovvia reazione, da un anti sabaudismo che da rilettura critica delle vicende otto-novecentesche s’era presto tramutato in una visione negativa dell’intera storia dinastica. Non a caso, al catalogo della mostra si era affiancata la pubblicazione presso Einaudi, di un volume, affidato alla cura di Walter Barberis, che riuniva storici di diverse nazioni e formazioni e che presentava i risultati d’una storiografia che stava mutando la percezione della storia dei Savoia in età moderna. Il sottotitolo del libro I secoli d’oro di una dinastia europea era quanto mai chiaro nell’indicare la tesi di fondo del volume, della mostra e del catalogo di questa. A distanza di dieci anni si può dire che il progetto di allora abbia avuto un esito nel complesso positivo. La Reggia di Venaria si è presto posizionata fra i poli di turismo culturale più visitati d’Italia e la storia dei Savoia in età moderna è oggi letta in modo più maturo. Un risultato, questo, cui ha contributo un rinnovato interesse europeo per la storia degli Stati sabaudi.
Nel 2017 è sembrato opportuno che, in occasione del suo decennale, la Reggia di Venaria, partendo dalla sua natura di residenza reale, affrontasse un tema più ampio: quello delle regge del Regno d’Italia e della loro identità, passata e presente. Negli ultimi anni in tutta Europa si è iniziato a discutere sulle vicende novecentesche dei palazzi reali. Nel corso di un secolo, infatti, la maggior parte di essi si è trasformata da luoghi del potere, da contestare o da difendere, in luoghi identitari, avvertiti come tali da gran parte della popolazione. Per tutti i francesi, per esempio, Versailles è un simbolo della propria cultura nazionale, anche se questo non implica che si voglia mettere in discussione le conquiste della Rivoluzione. Quanto sia oggi forte il ruolo degli antichi palazzi reali nelle diverse identità nazionali è ben verificabile anche in diversi Paesi dell’Europa orientale, dove nell’ultimo ventennio regge e palazzi sono state oggetto di progetti di restauro e di riutilizzazione, di cui spesso è stato esplicito il senso politico (si pensi, per esempio, alla ricostruzione del Castello di Vilnius o agli attuali progetti del governo ungherese sul Palazzo reale di Budapest). Il 2018, primo centenario di quel 1918 che aveva visto cadere numerose monarchie in Europa iniziando a porre il problema del destino dei palazzi che queste avevano abitato, sarà certo l’occasione per riflettere sull’identità novecentesca delle regge. Si tratta d’un tema su cui diversi luoghi, da Versailles a Berlino, hanno aperto appositi tavoli di lavoro, come è emerso nelle riunioni dell’Association des Résidences Royales Européennes (Arre), che unisce le principali regge europee e di cui Venaria è parte attiva.
Per quanto riguarda l’Italia, se la storia delle residenze delle diverse dinastie è da tempo un fecondo terreno di studi (si pensi a quanto si è scritto e si scrive sulle residenze sabaude, toscane, napoletane, con particolare attenzione sia alle vicende artistiche e architettoniche, sia alla storia delle corti che le ebbero come scenario della politica), lo stesso non può dirsi per quella delle residenze reali nel Regno d’Italia. Un terreno, questo, ancora per larga parte inesplorato. Lo scopo della nuova mostra di Venaria è, quindi, quello di iniziare a restituire un tratto, breve, certo, ma assai importante, della storia di palazzi e residenze della Penisola. Si tratta di ricostruirne il sistema durante una lunga parte del Regno d’Italia, e, insieme, di comprendere sia il loro ruolo politico nella rappresentazione della regalità italiana della dinastia sia il gusto artistico e architettonico di cui esse furono allora espressione. Il fatto che tutte le principali regge di allora, dal Palazzo del Quirinale a Palazzo Pitti, dal Palazzo Reale di Napoli alla Reggia di Caserta, dal Palazzo Reale di Torino al Castello di Racconigi, abbiano accettato di partecipare alla mostra con prestiti di grande qualità e rilievo dimostra che di questa esposizione si sentiva il bisogno. Non al passato, tuttavia, o non solo, intende rivolgersi la mostra. Suo termine ad quem è il 1920, anno in cui Vittorio Emanuele III, realizzando un progetto cui pensava da tempo, cedette allo Stato italiano la maggior parte delle regge: un atto che Ugo Ojetti definì «l’evento più importante e anche più clamoroso» nella storia dei monumenti italiani dopo l’Unità. Ai nostri occhi, un secolo più tardi, le parole del giornalista appaiono vere non tanto (o non solo) per l’atto in sé (in cui, peraltro, erano presenti elementi di convenienza politica ed economica per la Real Casa, che la storiografia ha oggi ben messo in evidenza), quanto perché tale decisione aprì un dibattito tutt’altro che banale sull’uso dei beni culturali, le cui conseguenze sono ancora vive a un secolo di distanza. Una mostra, quindi, si propone come una riflessione sia sul passato (recente) sia sul presente d’una parte tutt’altro che secondaria del nostro ingente patrimonio artistico.
Altri articoli dell'autore
Un convegno per fare il punto delle ricerche sui mobili dispersi delle ex regge di Milano e Monza
Nonostante gli storici abbiano da tempo fatto luce, almeno in parte, sulle forme della costruzione del suo mito, quest’ultimo pare resistere alle critiche, inossidabile
Opere lusitane nelle regge di Sintra, Queluz e Pena
I Palazzi Reali italiani si sono ritrovati in convegno a Napoli per discutere di conservazione preventiva