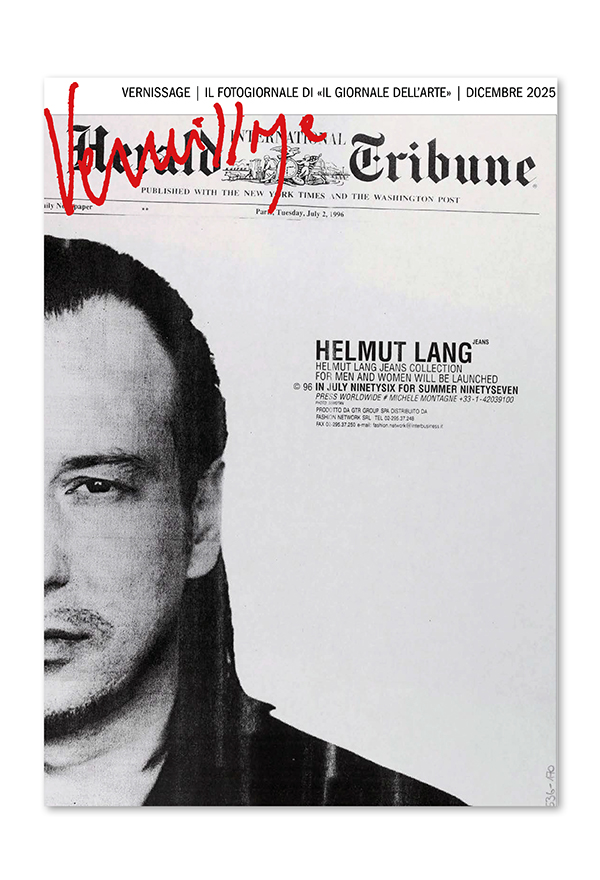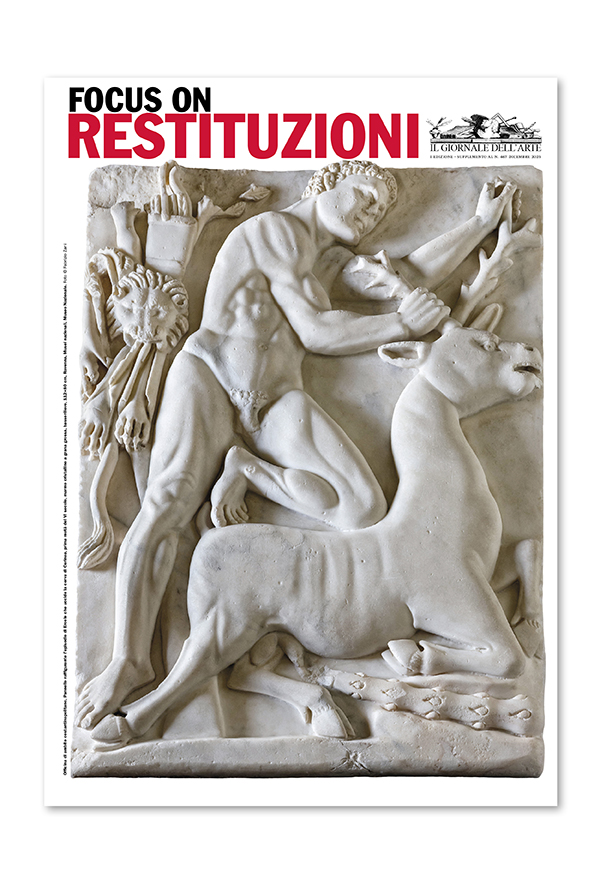Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Pac Pobric
Leggi i suoi articoliFrank Stella, 79 anni, fa parte di una generazione di artisti che non hanno paura di come verrà accolta la loro arte. La sua frase più famosa sul suo lavoro, «Quello che vedete è quello che vedete», risale al 1964. «Non resta molto da dire dopo, le pare?», gli chiese Bruce Glaser, che all’epoca lo intervistò. «Non so cos’altro ci sia», fu la risposta dell’artista. Ma quando gli abbiamo parlato, alla vigilia della sua retrospettiva aperta al Whitney Museum of American Art sino al 7 febbraio, era loquace e sereno.
Per un artista, che cosa significa allestire una mostra così vasta?
È un gran lavoro, ma divertente. Dopo che gli organizzatori ti hanno detto che cosa vogliono fare, devi correggere il tiro e inserire le cose che mancano. E io non voglio accanirmi su questo punto, ma non è stata un’indea mia che fosse una retrospettiva. Una volta stabilito così, devi riprendere il lavoro di cinquant’anni e questo crea naturalmente dei problemi. Non difficili da risolvere ma c’è davvero molto da fare.
È riuscito però a convincere i curatori a non allestire la mostra cronologicamente...
Sì, ma non è stato facile. Non è strettamente cronologica, ma ci sono diversi spazi dove vedere il lavoro più recente e intorno ci sono opere di anni precedenti. Ma penso che l’idea sia di instaurare un rapporto tra le opere. I quadri della serie «Irregular Paintings» (1965-66) ad esempio hanno qualcosa a che fare con quelli della serie «Polish Village» (1970-74). Non sono così diversi. Dare un’impostazione prettamente cronologica rende il tutto molto artificiale. Sarebbe possibile, immagino, in un museo convenzionale, ma qui si tratta di un open space. Perciò serve una sorta di sentiero, di movimento tra le opere, per non perdere la continuità. Non che sia così facile da realizzare, ma dev’essere ben fatto. Nessuno vuole uscire dall’ascensore e trovarsi intrappolato in un corridoio di quadri neri!
La sua opera è cambiata molto dai «Black Paintings» (1959-60). Ma la tesi centrale suggerita dal curatore Michael Auping nel catalogo della mostra è che esista una visione trasversale a tutto il suo lavoro. Lei è d’accordo?
Non posso garantirlo. Di solito di un artista si dice abbia uno stile o un tratto caratteristici. Si può seguire la sua mano o capire il modo in cui pensa. Credo valga anche per me, ma la cosa fondamentale è che, anche nei miei primi quadri, la struttura è piuttosto importante. Quei quadri cercano di trovare un modo per organizzarsi e sento che questo è sempre alla base di quello che faccio. Non sono davvero capace di abbandonare quel tipo di struttura. Non so se volete chiamarla coerenza pittorica ma, di qualsiasi cosa si tratti, qualunque siano i punti di partenza, salta sempre fuori.
È interessato alla bellezza?
Nessuno, nemmeno quando dice di farlo intenzionalmente, vuole di proposito creare quadri brutti. Penso ci sia un senso innato del tocco e forse una specie di gusto. A me sembra che nella mia pittura il colore sia sempre lo stesso. Fa parte dello stile. Ognuno ha uno stile in qualche misura, che resta quello anche se cambia l’organizzazione delle cose.
I titoli delle sue opere spesso suggeriscono allusioni letterarie o storiche. Come le vengono in mente e qual è il loro significato?
In linea di massima è per poterli identificare. A volte sembra funzionare davvero, altre è marginale. Non ci si può impantanare con il titolo. Non devo essere illustrativo. Penso che la serie «Moby Dick« (1986-87) sia stata una svolta. Ero un po’ spaventato, e forse lo sono ancora, da Moby Dick, ma i quadri sono essenzialmente superfici curve. Iniziano davvero a muoversi e il romanzo si muove, giri il mondo, è umido, ci sono molte onde e movimento. Credo che l’idea sia diretta. L’ho detto molte volte: l’astrazione può essere molte cose. Può, in un certo senso, raccontare una storia anche se alla fine si tratta di una storia pittorica.
Lei lavora molto velocemente. La sua serie «Polish Village» è stata fatta dal 1970 al 1973. Come regge questo ritmo?
A me non sembra così veloce. Tutto quello che riesco a ricordare sono gli aspetti che mi rallentano. Onestamente non ci penso. Sicuramente ho un piano d’azione. Fino a poco tempo fa, negli ultimi vent’anni circa, ho sempre fatto disegni per tutto.
Ha mai avuto momenti di crisi?
Lo so che tutti cercano le crisi. Sicuramente ci sono, ma non so se meritano di essere considerate vere e proprie «crisi». Parlerei piuttosto di malinconia, quando sai che non stai andando da nessuna parte. Ma non ci si può fare molto.
Non si definirebbe un romantico.
Non è del tutto vero. È più un luogo comune. Fa parte dell’essere in grado di fare un’opera d’arte, ma alla fine non penso che ci si prenderebbe la briga di dipingere se non si fosse romantici. Non conosco né ho mai visto qualcosa di puramente analitico-estetico.
Qual è per lei oggi la cosa più importante?
Respirare. È al primo posto.
In tutti i sensi?
Intendo in senso letterale. Banale ma vero. Mi piace vedere le cose. Sembra così scontato ma l’unica cosa che non è positiva del poter viaggiare così tanto è che per me è difficile fare due passi a Chelsea. Vorrei andare in tutte le gallerie, non importa cosa espongono, che è quello che facevo un tempo. Ma non posso farlo più. Sono un po’ tagliato fuori da quello che succede nella realtà.
Che cosa fa invece?
Ho sempre avuto la sensazione che il Settecento mi sfuggisse. Per questo sto leggendo un libro sull’arte di questo secolo, From Rococo to Revolution di Michael Levy. Lo trovo molto rilassante. L’autore è spesso piuttosto severo con gli artisti di cui tesse le lodi. Considerato quello che si dice oggi degli artisti, ha la lingua tagliente. Ho visto molti quadri, ma nei musei sono passato davanti senza soffermarmi a molti più dipinti del Settecento che di qualsiasi altro periodo e mi spiace. Una delle cose che dice Levy, ed è meraviglioso, è che nel XVIII secolo il piacere era un’occupazione. È una frase molto bella. Ora mi accontenterei di quell’occupazione.
Altri articoli dell'autore
Populismo, povertà, razzismo e totalitarismo: tre mostre a New York e San Francisco confermano inquietanti analogie
Al Gemeentemuseum un’imponente retrospettiva