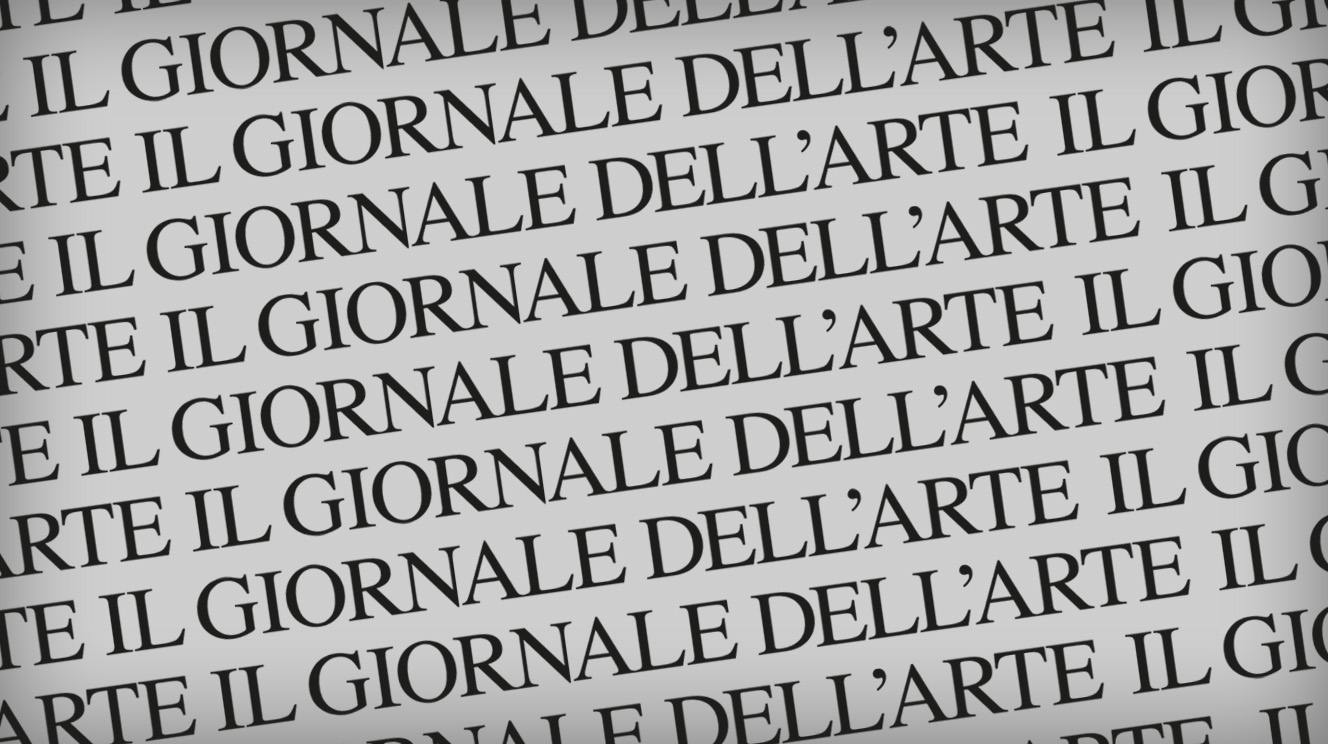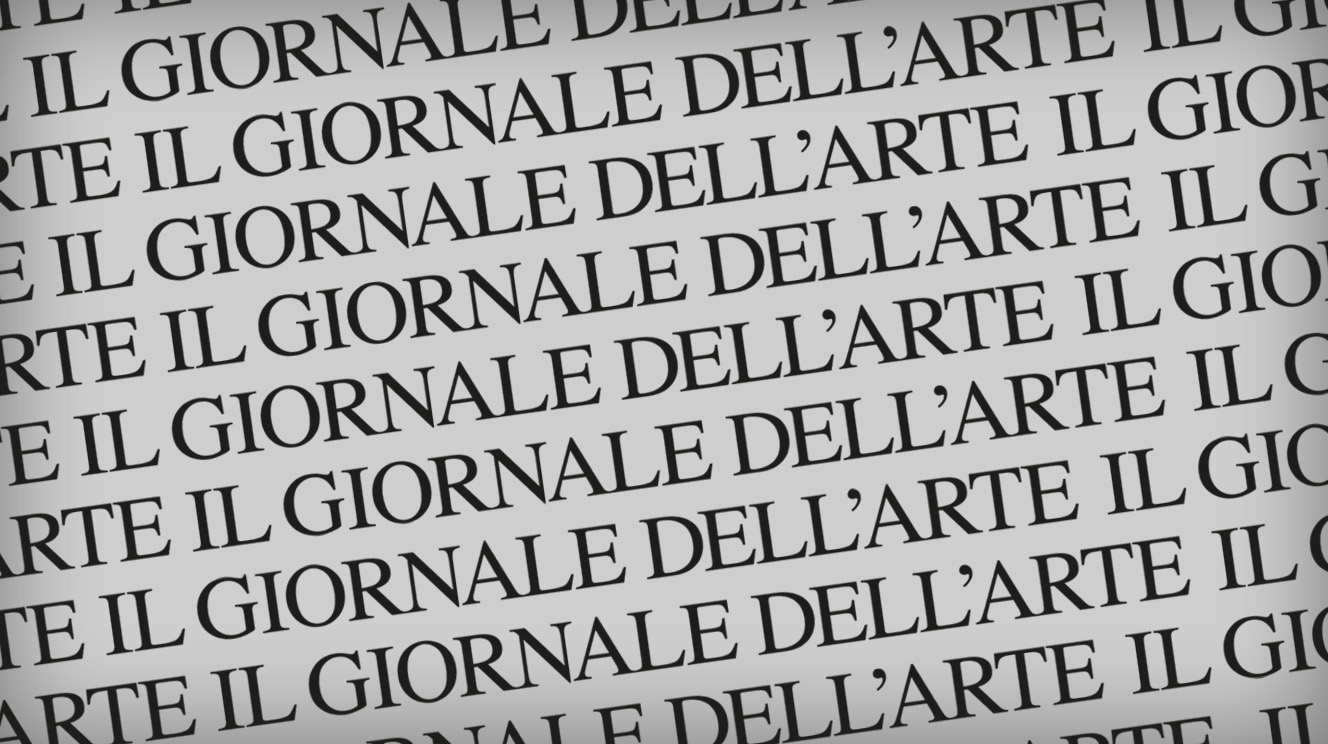Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Myriam Zerbi
Leggi i suoi articoliVenezia. A Palazzo Ducale, una mostra traccia i contorni della figura artistica di Henri Rousseau (Laval, 1844-Parigi, 1910). Detto il Doganiere per il suo lavoro negli uffici del dazio di Parigi, impiego che ottiene dopo anni di vita militare e varie disavventure, nel suo breve arco creativo, racchiuso tra il 1886 e il 1910, il pittore francese inventò paesaggi fiabeschi, giungle rigogliose e primordiali con grandi figure femminili arcaiche, fissò gruppi familiari e scene campestri con immagini frontali e composizioni prive di prospettiva che sembrano recuperare l’incantata genuinità dell’infanzia. La rassegna, allestita dal 6 marzo al 5 luglio nell’appartamento del Doge, è organizzata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, in collaborazione con il Musée d’Orsay di Parigi, il patrocinio della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, e prodotta da 24 Ore Cultura-Gruppo 24 Ore. «È la prima importante retrospettiva italiana dedicata a questo artista, spiega Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici e curatrice dell’esposizione con Guy Cogeval, sul quale ha a lungo pesato il giudizio critico di pittore naïf, ingenuo, incolto. Anche i contemporanei prima lo dileggiano, poi ne apprezzano il valore. L’intento della mostra è offrire una rilettura del suo lavoro alla luce del ritorno a modelli primitivi, tendenza sempre presente, a fasi alterne, nei percorsi della storia dell’arte». Il titolo «Candore arcaico» è anche quello del libro catalogo firmato dai due curatori, punto d’arrivo di un itinerario di studi che ha portato a rivalutare la centralità di Rousseau come riferimento dei protagonisti delle avanguardie, da Apollinaire a Jarry e da Kandinskij a Picasso. Quest’utlimo ne acquistò alcune opere e organizzò in suo onore un banchetto, rimasto celebre, al Bateau-Lavoir. «Rousseau rappresenta un modello di verginità intellettuale e purismo formale a cui guardano in molti, dai maestri dell’avanguardia fino ai pittori neorealisti della Nuova Oggettività», prosegue la Belli.
Tra i suoi estimatori c’era il mercante e critico tedesco Wilhelm Uhde, suo collezionista e autore, nel 1911, della prima monografia dedicata al Doganiere, mentre Ardengo Soffici su «La Voce» propose un parallelismo con Paolo Uccello.
Rousseau si nutriva degli incoraggiamenti dei pittori accademici Gérôme e Clément, al Louvre copiava e studiava i maestri, insegnava privatamente pittura, dava lezioni di musica e scriveva testi teatrali. «Può essere definito un autodidatta accademico? La sua pittura, continua la curatrice, non nasce dal nulla; Rousseau intercetta una linea arcaica anticlassica che parte dai Primitivi italiani, passa attraverso la visione di autori seicenteschi come l’olandese Frans Prost e l’arte popolare, per giungere alle realizzazioni Biedermeier. L’aspirazione di Rousseau alla sintesi formale, letta da Kandinskij come ritorno alla spiritualità (ne parla nel suo saggio Lo spirituale nell’arte) lo lega sia ad artisti del passato, quali Liberale da Verona (inizio XVI secolo), sia a figure come Cézanne, Klee, Carrà, Frida Kahlo, Morandi, autori pure rappresentati in mostra, e ne fa un originale spartiacque tra passato e futuro». Una quarantina le opere scelte da una produzione tutt’altro che copiosa, molte delle quali vere icone di un artista che Félix Vallotton considerava «l’alfa e l’omega della pittura»: dipinti quali «Guerra», «Autoritratto come pittore» (il famoso ritratto-paesaggio, come lo definiva l’autore), «Incantatrice di serpenti», «Zingara addormentata», «Transatlantico in tempesta» cui, nel segno dell’arcaismo, si affiancano altre sessanta opere di artisti di secoli e ambiti culturali differenti.
http://www.mostrarousseau.it/
Altri articoli dell'autore
«Maktub» («è scritto») in arabo, «scripta manent» in latino
Una mostra al Castello di Miramare di Trieste celebra l'artista bellunese, inventore di spettacolari notturni