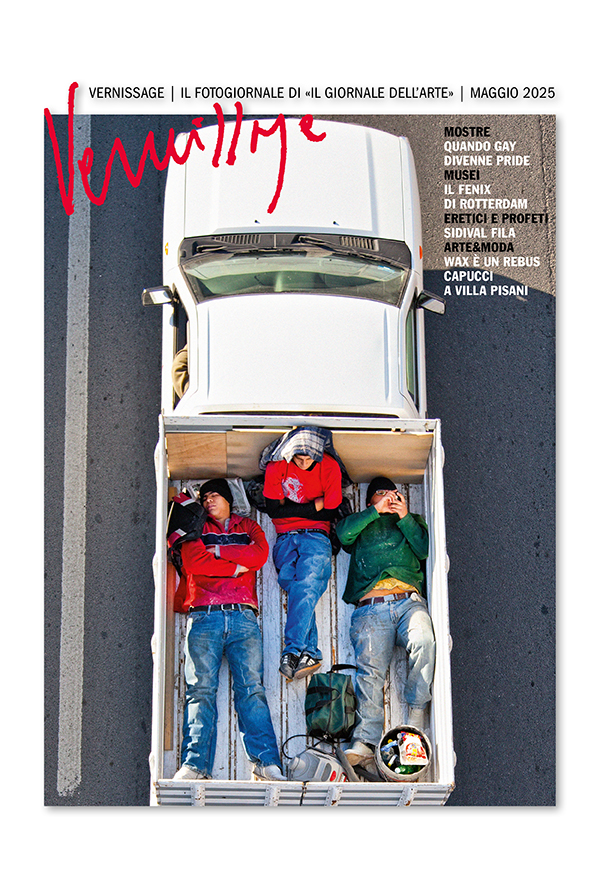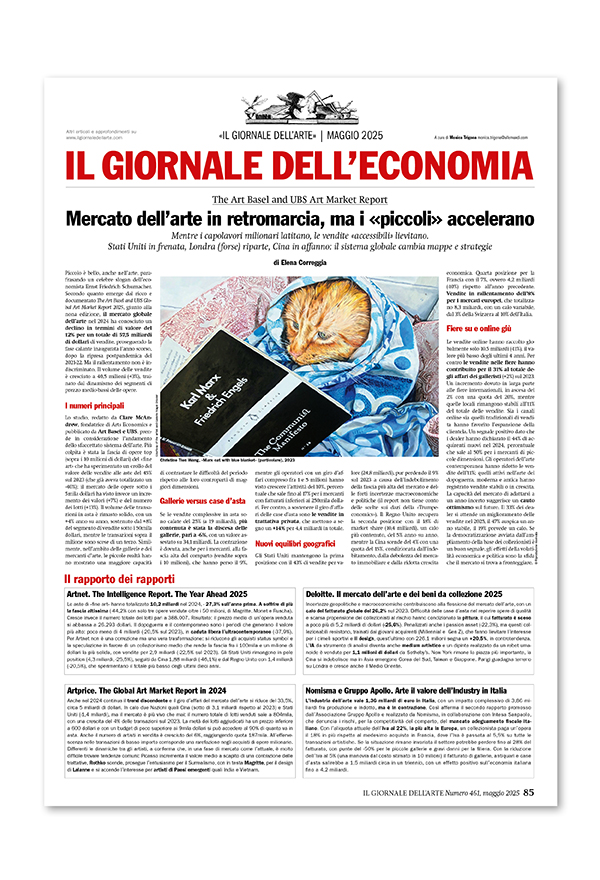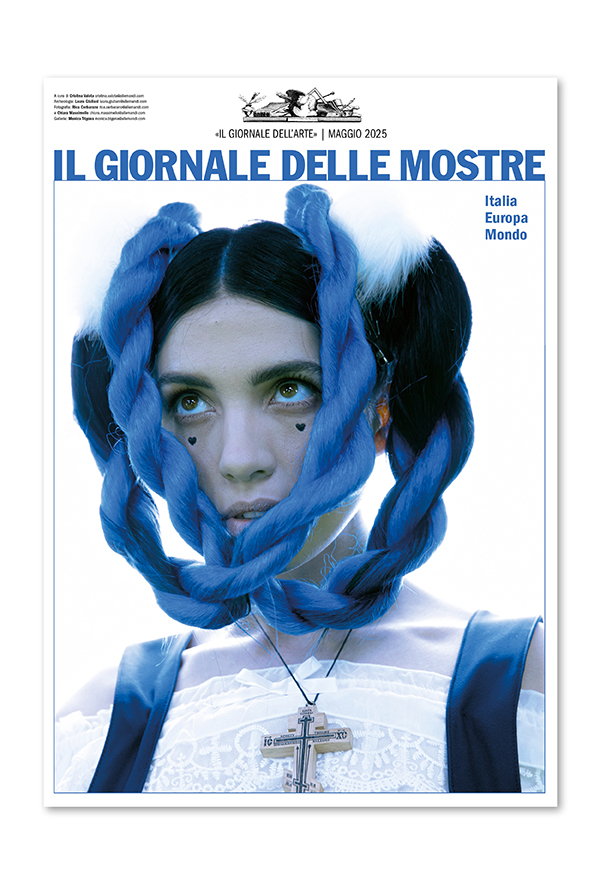Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Antonio Bisaccia
Leggi i suoi articoliAntonio Bisaccia, presidente della Conferenza nazionale dei direttori, riassume i problemi delle Accademie di Belle Arti.
L’Afam (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) consta di 155 istituzioni, tra cui 20 Accademie di Belle Arti statali, 59 Conservatori di musica statali (comprese le 4 sezioni distaccate), 18 ex Istituti musicali pareggiati, 5 Istituti superiori per le industrie artistiche, 19 Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute (comprese le pubbliche non statali storiche come Genova, Verona, Perugia, Bergamo e Ravenna), un’Accademia nazionale di Arte drammatica, un’Accademia nazionale di Danza e 32 altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli (art. 11 del Dpr 212/2005).
L’Afam ha circa 76mila iscritti (di cui 12.550 stranieri) e circa 15mila docenti tra quelli di ruolo, i precari e i contrattisti. Offre circa 5mila corsi di studio attivi tra trienni di I livello e bienni di II livello (più 30% negli ultimi anni). Impiega più di 3mila unità di personale non docente. Il presidente Mattarella ha scritto nel 2016 che «l’Italia si identifica anche con i suoi tesori impareggiabili, con la storia che li ha plasmati e che essi manifestano e che compone il Dna delle nostre città e del nostro popolo, con l’osmosi tra la natura e l’opera dell’uomo che ha formato tessuti urbani, definito paesaggi, dato vita a un modello sociale e a una società».
Mentre sulla conservazione di opere del passato si investono giustamente molte risorse, sulla formazione artistica non s’investe nulla. Anzi si disinveste, senza valutare il danno che si sta procurando: i nostri artisti-ricercatori si muovono come pesci muti dentro una grande vasca d’acqua, ma senza acqua. In queste condizioni, la specie è destinata all’estinzione, tutt’al più alla sopravvivenza. L’acronimo Afam, usato e abusato in ogni sede politica, sindacale e giudiziaria, è rimasto il parente povero delle politiche pubbliche dell’istruzione in confronto a risorse destinate alla formazione universitaria e a quella scolastica.
Probabilmente la ragione di un tale sfavore deriva da una valutazione soltanto numerica: gli iscritti alle istituzioni Afam sono meno degli iscritti alle Università e molti meno degli iscritti delle scuole secondarie superiori. Tuttavia rimane necessario che stabilmente le istituzioni Afam possano svolgere attività di ricerca. Una rivoluzione normativa dovrà ridisegnare le norme che dovrebbero prendere il posto dell’asfittica legge di settore in vigore, ma non più in grado, dopo più di vent’anni, di portare a casa il suo disegno autonomista.
L’art. 2, al primo comma, della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, qualifica espressamente le istituzioni Afam quali «Istituti di Alta cultura cui l’art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi».
Quale significato attribuire alla locuzione «Istituti di Alta cultura»? Sono qualcosa di differente dalle Università? Il legislatore distingue tra Università e Istituzioni di Alta cultura tra le quali anche le Istituzioni Afam?
Non è senza significato che i titoli Afam siano rubricati col termine «Diploma» e i titoli universitari col termine «Laurea». E che il più alto titolo accademico nelle Università si chiami «dottorato di ricerca» e nelle Afam si chiami «corso accademico di formazione alla ricerca»: anche se, fino ad oggi, non esiste ancora un regolamento che permetterebbe a quest’ultimo di essere attivato.
Riformare la riforma
Per comprendere la portata della posta in gioco, prendiamo le mosse dal tema del reclutamento. Secondo la Corte di Cassazione (in una sentenza del 2018) i docenti Afam non hanno diritto allo stesso trattamento economico e contrattuale dei docenti universitari.
Questa osservazione sembra volta a estirpare una richiesta corporativa del corpo docenti di Accademie e Conservatori. Per la Suprema Corte la legge n. 508 del 1999, pur inquadrando le Afam tra le istituzioni di Alta cultura riconosciute dalla Carta e garantendone l’autonomia statutaria e organizzativa, affida la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti alla contrattazione collettiva (adesso comparto «Istruzione e Ricerca») e regola il conferimento degli incarichi di docenza secondo modalità diverse sia da quelle previste per gli insegnanti di scuola primaria e secondaria, sia da quelle proprie dei professori universitari (per i quali l’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha mantenuto lo statuto pubblicistico).
Una recente ordinanza della Cassazione (n. 303 del 10 gennaio 2020) sottolinea che per via amministrativa non è possibile giungere alla soluzione del problema. Già il 18 giugno 2003, l’ex ministro Letizia Moratti scrisse che «il problema richiederebbe uno specifico intervento legislativo, volto a modificare la 508/99».
Com’è noto, la distinzione fondamentale tra Scuole di istruzione secondaria superiore e Università degli studi risiede nel fatto che le prime «si limitano», per così dire, a trasmettere un sapere da altri elaborato e non a elaborarne, criticamente, uno nuovo; per converso, nelle università, come nelle istituzioni Afam, il sapere viene insegnato con metodo critico, e viene altresì formato attraverso l’attività di ricerca.
L’attività di ricerca delle istituzioni scolastiche non appare comparabile con quella degli istituti universitari e dell’Afam, per i quali essa costituisce invece la finalità primaria e istituzionale. Il legislatore della legge n. 508/99 considera le istituzioni Afam «sedi primarie di Alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale», che svolgono «correlate attività di produzione».
Senza ricerca non esiste Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ma senza ricerca non esiste neppure Università. L’art. 33 della Costituzione pone sullo stesso piano Università e Accademie (come Istituti di Alta cultura) senza formulare una gerarchia fra di esse. La legge 508/99 aveva già sancito da un punto di vista normativo la natura, legata alla ricerca, di queste istituzioni: ma per celebrare la Costituzione e superare gli ostacoli che si sono avvicendati in vent’anni è necessario riformare la riforma.
Un reclutamento sofista e fallace
La libertà di ricerca nelle istituzioni Afam passa necessariamente, a mio avviso, per una qualificazione della docenza nella progressione della carriera accademica. Il recente Dpr sul reclutamento Afam (n. 143 del 7 agosto 2019, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 16 dicembre 2019) ha invece costruito una serie di aberrazioni senza pari. Una sorta di manuale Cencelli.
Docenti, ministro, direttori, sindacati e, soprattutto, studenti ne hanno discusso per mesi e avevano da subito capito che si trattava dell’annuncio di un disastro, tanto che era stato, in un primo momento, ritirato dall’ex ministro Lorenzo Fioramonti. Tutti scontenti, dai precari storici a quelli meno storici fino a chi aspira a entrare nel sistema con concorsi per titoli ed esami, compresi i docenti di seconda fascia che, nell’applicazione pratica, vedranno purtroppo applicate solo piccole percentuali del budget programmato a loro riservato (10%).
Così ha destato stupore anche la non adozione della necessaria «Abilitazione artistica nazionale» analoga all’«Abilitazione scientifica nazionale» delle Università. Tutto ciò a costo zero. Se non si mette in campo il vitale, e non più procastinabile, ampliamento dell’organico il rischio è l’implosione di queste istituzioni. A fronte di un’enorme capacità attrattiva, anche di studenti stranieri, che in certi casi ha raddoppiato gli iscritti, il numero dei docenti è rimasto uguale a quello di 25 anni fa. Non si tratta di miopia ma di totale mancanza di visione.
Valutazione e programmazione
La valutazione delle istituzioni Afam dovrebbe essere direttamente proporzionale all’investimento in tema di ricerca e dei fondi per affrontarla. È quindi necessario rivedere e ampliare le determinazioni del Manuale di Frascati (che stabilisce la metodologia per raccogliere e utilizzare dati sulla ricerca e sviluppo nei Paesi membri dell’Ocse, Ndr) sulla ricerca artistica nel profilo «Ricerca & Sviluppo».
Bisognerà, inoltre, sterilizzare tutte le forme degenerative di autovalutazione e valutazione delle Università (si pensi, ad esempio, al triste fenomeno dell’autocitazionismo e dell’autoreferenzialità). Riguardo all’offerta formativa, di recente il Consiglio di Stato ha deciso che alle istituzioni private, già autorizzate a rilasciare titoli equivalenti a quelli delle istituzioni Afam, è richiesto null’altro che la sussistenza di adeguate risorse.
Appare evidente come l’autorizzazione a rilasciare titoli equivalenti a quelli rilasciati dalle istituzioni Afam sia ridotta alla stregua di una qualsiasi autorizzazione meramente commerciale. Uguale semplicità di procedure non è riconosciuta alle istituzioni statali. Esse sono tuttora in attesa di un regolamento sulla programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema e dunque scontano un ritardo importante rispetto al settore privato.
Questo è solo uno degli esempi che dimostra la parzialità e l’insufficienza del Dpr sul reclutamento da poco emanato e come sia disatteso l’articolo 9 della Costituzione per quanto concerne il rapporto sotteso con la formazione artistica.
L’Italia dovrebbe puntare a costruire un solido ponte tra istruzione, progettazione e produzione, per accudire il «nation branding» di cultura e arte che nel 2018 ha messo in moto, secondo Symbola-Unioncamere, circa 96 miliardi di euro, ovvero il 6,1 % del Pil, e dato lavoro a un milione e mezzo di persone.
Né ignorare il valore aggiunto dovuto all’effetto moltiplicatore (equivalente a 1,8) del sistema produttivo legato alla cultura, all’arte e alla creatività. Come riusciremo a creare strategie che possano indurre (o costringere) la classe politica a fare i passi capaci di trasformare, con misure concrete, l’istruzione in un reale coefficiente di crescita?
Altri articoli dell'autore
Il processo di trasformazione dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Il Ministero dell’Università e della Ricerca apre alla possibilità per Accademie e Conservatori di accedere ai finanziamenti statali per progetti culturali e artistici