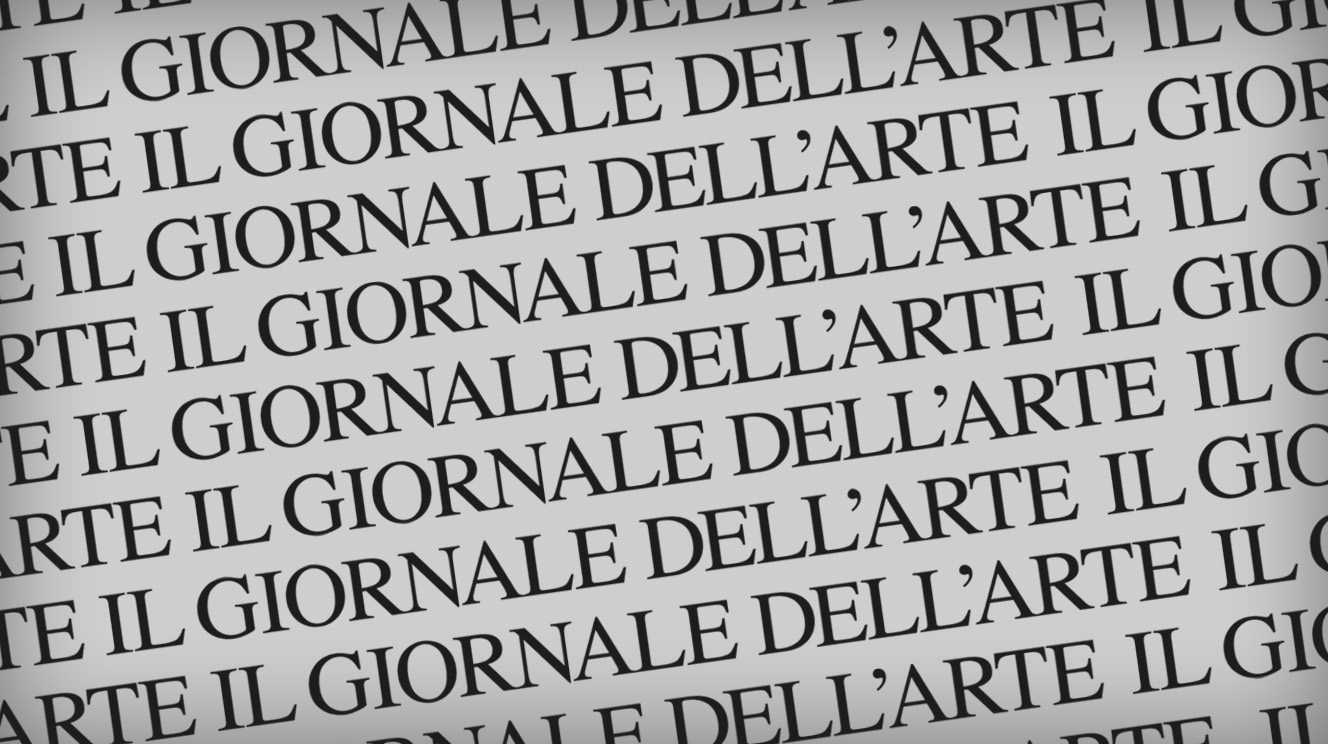Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Valeria Fichera Lo Savio
Leggi i suoi articoliL’estate dell’archeologia italiana in Grecia ha inizio ad Atene: le missioni archeologiche delle varie università italiane, salvo che in sporadici casi, sono in stretta collaborazione con la Scuola archeologica italiana di Atene (Saia) che dal 1909, anno della fondazione con regio decreto, viene riconosciuta come base per le missioni archeologiche italiane in Grecia e nel Mediterraneo orientale nonché come interlocutrice qualificata di riferimento per l’Italia. Recentemente la Saia ha lanciato un appello alla contribuzione volontaria per poter mantenere il necessario e continuo aggiornamento delle attività scientifiche e della Biblioteca.
La collaborazione tra Italia e Grecia in questo campo è ininterrotta dalla fine dell’Ottocento, dal tempo della scoperta dell’iscrizione bustrofedica con le leggi di Gortyna, a Creta, dove attraverso i rapporti tra Federico Halberr e il sillogo culturale di Heraklion e attraverso le scoperte italiane, in tempi di lotta per l’indipendenza da ciò che restava dell’impero ottomano, si riaffermava l’importante ruolo mediterraneo dell’isola nonché la sua sempre più indiscutibile «grecità». Creta e in particolare la Messarà, la pianura meridionale, è stata e resta territorio prediletto della ricerca archeologica italiana, con i siti di Festòs, Haghia Triada, Priniàs e Gortyna, dove si concentrano una decina di missioni italiane.
L’area del territorio di Festòs sarà oggetto della missione dell’Università di Salerno,sotto la direzione di Fausto Longo, con il fine di redigere la carta archeologica della città antica attraverso l’utilizzo di diversi strumenti e tecnologie digitali e con analisi preventive in grado di valutare la complessità archeologica del territorio attraverso l’utilizzo dei rilievi aerofotografici, dei dati da laser scanner, delle riprese fotografiche effettuate da droni, delle prospezioni geofisiche e dell’analisi multispettrale delle immagini da satellite, la costruzione di una rete topografica con le strutture archeologiche dell’abitato e del territorio georiferite, una cartografia nuova del territorio oggetto di indagine, un Dtm ((Digital Terrain Model) e un Gis (Geographic Information System).
Il Progetto Phaistos, un progetto multidisciplinare promosso direttamente dalla Saia e portato avanti in sinergia dall’Università di Salerno e dall’Eforia di Hiraklion, iniziato nel 2007, è adesso nel secondo quinquennio di studio e ricerca (2013-17). Sulla natura del palazzo minoico di Festòs come centro di potere e delle trasformazioni da esso subite, dalla nascita fino all’Età del Bronzo e in relazione con il territorio circostante, si concentra la missione dell’Università di Catania sotto la guida di Pietro Militello con indagini e analisi dei materiali, analisi storica, creazione di una banca dati e restituzione grafica 3D delle strutture rilevate.
A Gortyna, la missione dell’Università di Palermo guidata da Nunzio Allegro prosegue lo studio della collina di Profitis Ilias, dove negli anni è emerso un quartiere di epoca alto arcaica di elevato interesse dal punto di vista della sua urbanistica, con attività di restauro e studio dei materiali. Della Gortyna di epoca ellenistica sotto egida tolemaica, si occupa la missione dell’Università di Roma La Sapienza sotto la direzione di Enzo Lippolis attraverso lo studio delle trasformazioni architettoniche e urbanistiche in senso monumentale intorno all’area del tempio di Apollo Pythion.
La revisione degli scavi finora effettuati nell’area del santuario del Pythion è l’oggetto della missione di Jacopo Bonetto dell’Università di Padova, a seguito dell’indagine del teatro effettuata a partire dal 2002. La ricostruzione delle ultime fasi di vita della città di Gortyna nell’importante quartiere urbano del Pythion attraverso la documentazione e lo studio dei contesti archeologici del quartiere bizantino, scavati dal 2001 al 2014, sarà l’obiettivo dell’Università di Siena sotto la guida del direttore Enrico Zanini. Sempre a Gortyna, nell’area delle terme tardoromane e protobizantine a sud del Pretorio, Giorgio Bejor e Claudia Lambrugo dell’Università di Milano continueranno le indagini nell’area del frigidarium e il restauro di quanto emerso. A ovest del Pretorio, nel quartiere protobizantino, la missione di Roberto Perna dell’Università di Macerata completerà le indagini di un grande edificio già parzialmente scavato per l’edizione degli scavi.
Non meno importante l’esplorazione della parte nord-orientale dell’isola di Lemnos con i siti di Poliochni, Efestia, e Chloi. A Hephaestia, Emanuele Greco, direttore della Saia dal 2000, porta avanti l’individuazione dell’impianto urbanistico della città, scavata per la prima volta da Alessandro Della Seta nel 1925. Non lontanto dal porto della città, il santuario extramoenia dei Cabiri a Chloi, anch’esso terreno di indagine della Scuola Archeologica.
Nell’insediamento preistorico di Poliochni si portano avanti attività di consolidamento e protezione delle strutture. Infine, l’Università di Salerno, sotto la direzione di Angela Pontrandolfo e in collaborazione con la VI Eforia di Patrasso, prosegue le prospezioni archeologiche nella valle del Krios, in Acaia orientale. Un lavoro di ricerca sul terreno, con indagini archeologiche intrasito e analisi geofisiche e archeobotaniche, volto a investigare forme e modalità del popolamento antico e in particolare le dinamiche legate ai fenomeni di strutturazione socio-politica, che il direttore Greco definisce «metodologicamente esemplare, anche come modello di collaborazione tra studiosi italiani e greci». Sempre in Acaia, la missione di Elisabetta Borgna dell’Università di Udine.
Altri articoli dell'autore
La Scuola Archeologica Italiana di Atene (Saia) ha un nuovo direttore
Gioielli provenienti dalle Cicladi dall'epoca neolitica al XX secolo
Il Museo Archeologico Nazionale dotato di opere eccezionali celebra il secolo e mezzo con la mostra «Odissee»