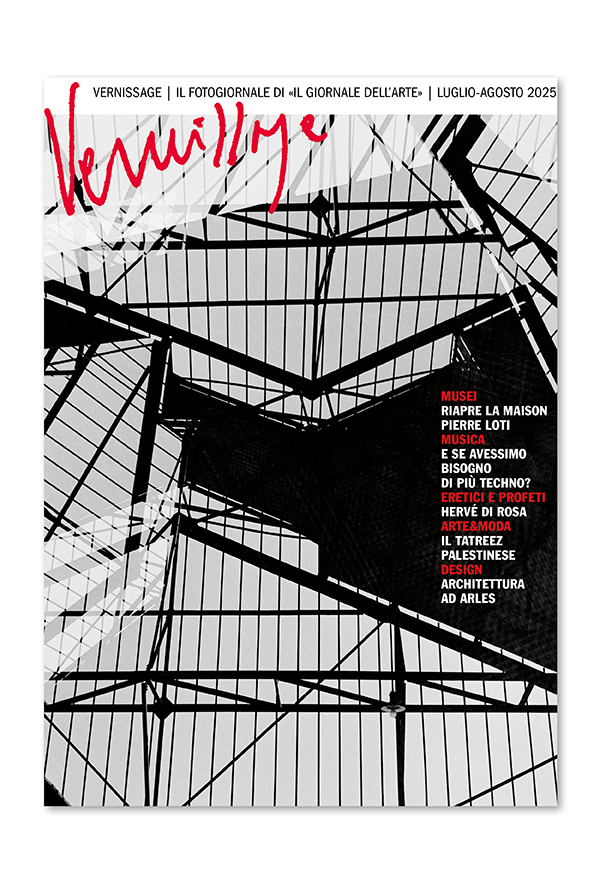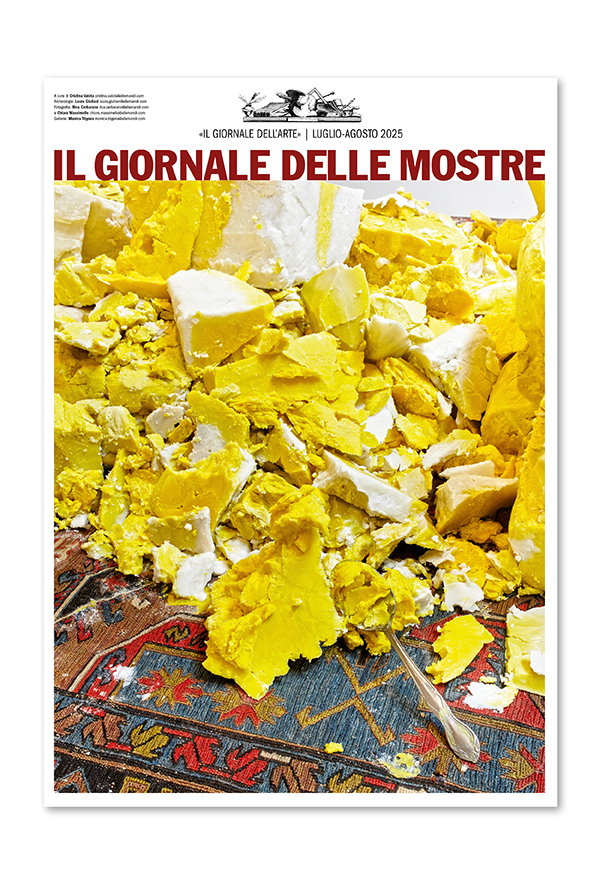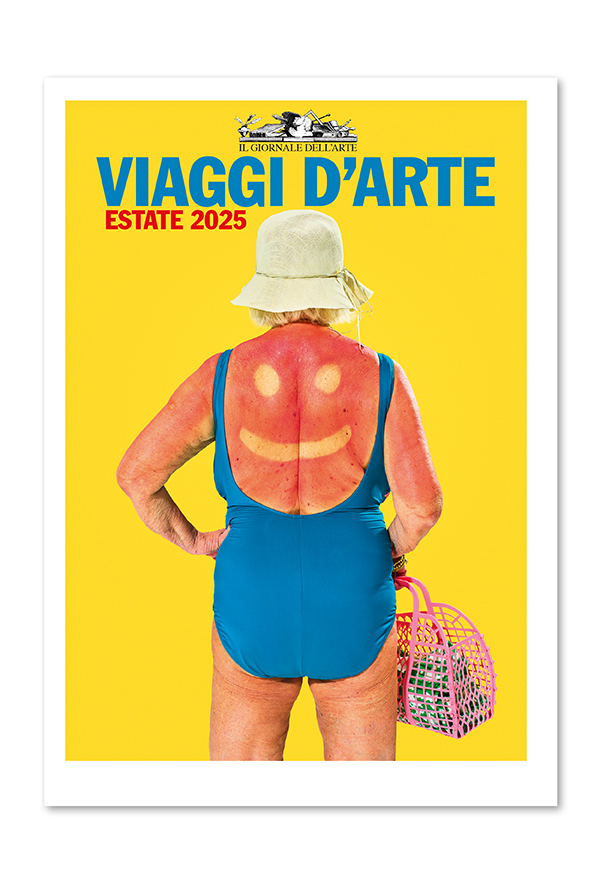Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Francesca Romana Morelli
Leggi i suoi articoliNel mondo antico, il poeta latino Ovidio rimane il più grande cantore dell’amore e della sua forza di seduzione e di piacere. La fama del poeta, che dal Medioevo giunge fino al Rinascimento, per affievolirsi a tratti soltanto in epoca moderna, è legata essenzialmente all’Ars amatoria e alle Metamorfosi. Verseggiatore straordinario, animato da un’immaginazione seducente, da un’intelligenza sottile e complessa, Ovidio coglie nel profondo l’indole della società romana che, sotto l’abile governo di Augusto, preferisce godersi la pace, il lusso e i piaceri della vita e quindi una poesia di evasione.
Al centro della sua opera è l’amore sensuale, che in epoca giovanile sente come puro piacere, sorgente di libertà e di felicità, mentre in epoca adulta si manifesta in una grandissima violenza fisica (eppure è uno straordinario interprete dell’animo femminile). Nell’ambito delle celebrazioni per il bimillenario della sua morte, le Scuderie del Quirinale gli dedicano, dal 17 ottobre al 20 gennaio, la mostra «Ovidio. Amori, miti e altre storie», curata da Francesca Ghedini, archeologa e docente dell’Università di Padova, che ha cercato di restituire la «capacità immaginifica» di Ovidio e l’assoluta modernità di rappresentare l’amore nelle sue labirintiche sfaccettature.
Sono esposte oltre duecento opere, dall’epoca greco-romana fino al Settecento, tra cui sculture, affreschi pompeiani, gemme intagliate, monete, oggetti d’arredo, codici miniati, dipinti. Poco si sa della concezione della mostra, perché le Scuderie hanno scelto di mantenere la riservatezza sul progetto espositivo.
Siamo comunque riusciti a intervistare la curatrice, che ha individuato le linee guida della mostra nel restituire in tutta la loro suggestione visiva i versi ovidiani, mettendo in gioco concetti come «bellezza» ed «eros»: «Da oltre dieci anni il poeta di Sulmona è al centro di un progetto di ricerca da me coordinato con l’aiuto di Isabella Colpo e Giulia Salvo, nato all’interno dell’ateneo di Padova, al quale hanno collaborato colleghi, dottorandi, studenti. Abbiamo indagato la sua feconda produzione letteraria, non soltanto come strumento per ricostruire la cultura e l’epoca in cui viveva, ma anche le ragioni della sua fortuna dall’antichità a oggi. Dopo convegni, seminari e pubblicazioni innumerevoli (credo che abbiamo superato le duecento unità di contributi a stampa) mancava una mostra».
Publio Ovidio Nasone (43 a.C.-17 d.C.) si stabilì giovanissimo a Roma, dove frequentò i letterati, tra i quali Orazio, e la corte di Augusto. Dopo aver esercitato magistrature minori, viaggiato ed essersi sposato tre volte (soltanto il terzo matrimonio lo renderà felice), divenne famoso con l’Ars amatoria, pubblicata nei primi anni dell’era volgare.
Le Metamorfosi sono un poema di maggiore respiro, ma nel momento in cui stava componendo i Fasti sui miti legati al calendario romano, nell’8 d.C. gli fu imposto l’irrevocabile esilio a Tomi (odierna Costanza) sul Mar Nero, dove finirà i suoi giorni. «Le ragioni dell’allontanamento di Ovidio da Roma sono piuttosto ambigue, in qualche modo concorre uno scontro con Augusto, spiega Ghedini, è possibile che l’imperatore condanni la maniera dissacrante con cui Ovidio tratta gli dei, spesso come divinità dalle pulsioni erotiche esternate sotto forma di stupri».
Tra le più straordinarie opere in mostra c’è il sensuale marmo della Venere «callipigia» (Museo Archeologico Nazionale, Napoli), il ritratto di Marcello della collezione della Fondazione Sorgente Group, trenta codici miniati, selezionati da Federica Toniolo, tra cui il primo di soggetto ovidiano (Biblioteca Nazionale, Napoli), che fanno da cerniera tra l’epoca antica e il resto delle sezioni della mostra. Diverse sale illustreranno quindici miti delle Metamorfosi. Infine una sorta di straordinaria apertura sull’arte moderna.

«Venere callipigia» II secolo d.C. Collezione Farnese, Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Foto: Wikipedia

«Venere callipigia» II secolo d.C. Collezione Farnese, Napoli, Museo Archeologico Nazionale