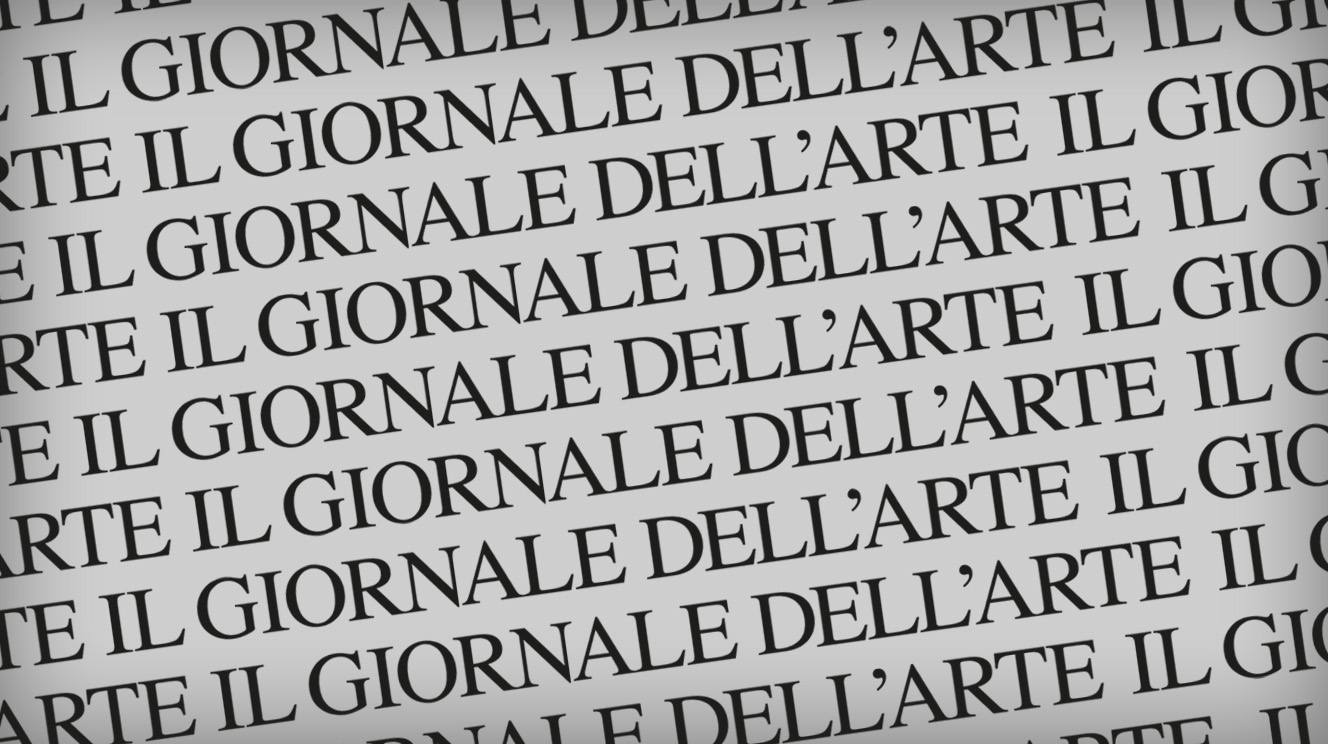Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Lemme
Leggi i suoi articoliL’esasperazione della tutela viola la legalità e, soprattutto, danneggia la cultura
L’articolo 72 del decreto legislativo 42/04 (cosiddetto Codice dei Beni Culturali) prevede, tra le varie forme di circolazione internazionale dei beni culturali, anche la temporanea importazione. In virtù di tale istituto, un bene entra in Italia dall’estero (Paesi della Comunità Europea o terzi) in via temporanea.
Al momento dell’introduzione nel territorio nazionale, l’Amministrazione italiana (Uffici Esportazione) accerta, preventivamente, che il bene non sia uscito clandestinamente dall’Italia: è un classico, messo normalmente in atto da trafficanti senza scrupoli, quello di far uscire clandestinamente dall’Italia un bene culturale, per poi riportarlo in patria con una certificazione di temporanea importazione.
In tal modo, si raggiunge il duplice scopo di poter commercializzare il bene dall’Italia e di poterlo riesportare al momento in cui venga trovato un acquirente estero.
Ove l’accertamento dia esito positivo, il bene è addirittura confiscabile, in quanto oggetto di esportazione clandestina; ove sia negativo, viene rilasciato il documento attestante l’introduzione temporanea. Esso ha durata di anni cinque ed è rinnovabile prima della scadenza.
Ci si chiede, a questo punto, se l’opera, temporaneamente importata in Italia, faccia parte del patrimonio storico-artistico nazionale e possa, in quanto tale, formare oggetto di provvedimenti di tutela (dichiarazione di interesse storico-artistico particolarmente importante, con il conseguente divieto di esportazione, ai sensi dell’art. 65/1 decreto legislativo 42/04).
Ora, al riguardo, la risposta è certamente negativa. Il bene temporaneamente introdotto in Italia non è suscettibile di tutela, in quanto la sua permanenza precaria nel territorio nazionale lo sottrae alla nozione di «patrimonio storico-artistico tutelabile», come definito dall’articolo 9 della Costituzione. In altri termini, il proprietario di un bene acquistato all’estero può, a suo piacimento, lasciare il bene all’estero o introdurlo in Italia, con l’assoluta libertà di riesportarlo, facendo solo accertare l’identità di quanto introdotto temporaneamente con quanto oggetto di riesportazione. Egualmente, il proprietario straniero di un bene culturale può esporlo in una mostra in Italia, ovviamente riportandolo nel suo Paese di origine, alla fine dell’evento espositivo.
Non è chi non veda il giustificato favore verso l’introduzione in Italia, sia pure in via temporanea, di beni di provenienza estera. Infatti:
- è interesse dell’Amministrazione che il soggetto italiano, acquirente all’estero di un bene culturale, lo introduca temporaneamente in Italia, per farne oggetto di consultazioni, discussioni, fruizioni sul piano del dibattito delle idee. Se l’introduzione in Italia fosse accompagnata dalla possibilità della tutela e del conseguente veto di riesportazione, nessuno più porterebbe in Italia beni acquistati all’estero, con un conseguente effetto di impoverimento della cultura in generale;
- egualmente, se uno straniero che importa in Italia un bene culturale per un evento espositivo fosse poi soggetto al divieto di riesportare il bene, esaurito l’evento, nessuna mostra potrebbe aver luogo in Italia con beni di provenienza estera e il Paese sarebbe condannato a un autentico embargo culturale.
Rammento al riguardo una sentenza che il Tar del Lazio ha pronunziato nel 1999, in una vicenda da me curata (sentenza TAR del Lazio, Sezione II, 19.5.1999 n. 1351, Foro Amministrativo, 2000, 1020).
Si trattava di un sarcofago romano introdotto in Italia in regime di temporanea importazione e per il quale l’Amministrazione aveva apposto il veto in sede di richiesta della «licenza di riesportazione». Il regime allora vigente era quello della legge 1089/1939, sostanzialmente coincidente, in materia, con l’attuale. Il Tar del Lazio, con una sentenza che è ancora citata nei manuali come riferimento sulla materia, osservò che «nei casi di importazione temporanea, stante il carattere solo provvisorio della presenza del bene nel territorio dello Stato, che corrisponde a peculiari e provvisorie esigenze del proprietario o detentore (temporanea residenza in Italia dello straniero; necessità di restauro della cosa a cura di soggetti particolarmente qualificati; esposizione o comodato in favore di terzi)» le stesse esigenze «verrebbero pregiudicate, con ingiustificata compressione della sfera delle libertà individuali, a fronte del possibile veto di riesportazione», oggi sussistente indiscriminatamente per tutti i beni dei quali sia stato dichiarato l’interesse storico artistico particolarmente importante (art. 65/1 D.lgs. 42/04).
Pertanto, la presenza del bene in Italia in regime di temporanea importazione impedisce l’adozione di provvedimenti di tutela, che si traducono nella successiva impossibilità di riesportazione del bene, come nel caso della dichiarazione dell’interesse storico-artistico particolarmente importante. E le forme d’uso che assume la temporanea importazione possono consistere, anche, nel rilascio di un certificato di libera esportazione, della durata di anni cinque e rinnovabile alla scadenza, senza limiti temporali.
Gli uffici dell’Amministrazione dei Beni Culturali che, nella esasperazione della tutela, dimenticano questi fondamentali principi, non sono da encomiare ma da biasimare. Essi non solo violano la legalità ma vanno contro gli stessi interessi culturali di quell’Amministrazione che intendono oltranzisticamente difendere.
Rammento che molti anni orsono un notissimo mercante inglese aveva prestato, per una mostra in Italia, alcuni importanti dipinti veneti, pacificamente circolanti all’estero. Alla fine della mostra, il solito funzionario zelante si rifiutò di farli ritornare nel luogo da dove provenivano: ne venne fuori uno scandalo perché il mercante minacciò di bruciare pubblicamente le sue opere, se il diniego fosse persistito. Il gesto clamoroso ebbe effetto e i dipinti poterono tornare all’estero. Ma, ci domandiamo allora: è mai possibile che in questo strambo Paese si riesca ad aver ragione solo ricorrendo a manifestazioni plateali? Lasciamo la risposta ai «solerti funzionari».
Altri articoli dell'autore
I beni culturali possono essere dichiarati di particolare interesse solo se la loro esecuzione risalga ad almeno cinquant’anni
La capacità (e l’obbligo) di correggersi della Pubblica Amministrazione
Va introdotta una distinzione tra ricerca significativa e ricerca inutile: la prima aggiunge qualcosa alle conoscenze già acquisite, la seconda si limita a riproporre il «déjà dit»
Il conflitto tra Russia e Ucraina mette in luce un relativismo che parte da Giovanni Battista Vico