
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Silvia Mazza
Leggi i suoi articoliPalermo. C’è un crinale nella storia del Centro per la Progettazione e il Restauro (Crpr), un prima e dopo, che può essere letto come cartina al tornasole per la nuova riforma Franceschini dei musei, e in Sicilia stessa per gli istituendi Parchi archeologici. È l’esempio di come autonomia gestionale e finanziaria, di cui saranno dotati entrambi, non siano sufficienti a garantire successo se a capo degli Istituti che ne godranno non andranno direttori all’altezza dei loro compiti istituzionali. Poi, certo, si potrà discutere anche di come pesanti tagli ai fondi e carenza di personale qualificato per il blocco del turn over abbiano contribuito a disegnare la parabola discendente dell’Istituto palermitano, organismo tecnico-scientifico dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Aveva avuto la sua stagione d’oro durante i nove anni (2001-2010) della gestione di Guido Meli, quando per importanza dei progetti, convegni e iniziative scientifiche era salito alla ribalta anche internazionale. Oggi in pensione (cfr. n. 347, nov. 14, p. 10), l’architetto aveva lasciato il Centro nell’ottobre 2010 per andare a dirigere il Parco della Villa romana del Casale di Piazza Armerina. Da quel momento in poi, a poco è servita, appunto, quell’autonomia gestionale di cui il Crpr è dotato sin dalle origini (1989). Scelta precorritrice in Italia: l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per esempio, può vantarla solo dal 2008.
Goderne significa disporre di un budget complessivo all’inizio di ogni esercizio finanziario sul quale far gravare le spese per una corretta gestione, spese che, per soprintendenze, musei o parchi archeologici (questi ultimi non ancora dotati di autonomia contabile) trovano copertura, invece, nel calderone dei diversi capitoli del bilancio regionale, soggetti al controllo, anche politico, del potere centrale. Goderne significa, quindi, avere consentita una vera programmazione, diversamente si spiega perché, per esempio, possano rimanere non spesi fondi consistenti come quelli europei: le richieste di finanziamento vengono prodotte e approvate con molto ritardo, trasformandosi inesorabilmente in residui passivi.
È recente la critica (Settis) alle competenze esclusive in materia di Beni Culturali che lo Statuto speciale, approvato quasi settanta anni fa, assegna alla Regione. Quello che si paga è il prezzo di un contesto normativo come quello siciliano e in uno scenario attuale in cui la politica esercita una forte ingerenza. Ma occorre, pure, non dimenticare che la Sicilia era stata, anche qui, precursore quando nel 1982 si era dotata di un proprio istituto per il restauro, proprio grazie a quella competenza esclusiva, anche legislativa. Era, in qualche modo, la prima risposta alla visione con cui Cesare Brandi nel ’39 fondò a Roma l’allora Icr, che in quel «centrale» della sua originaria denominazione, venuto meno con quella nuova di Istituto «superiore» per la conservazione e il restauro, conteneva implicitamente la previsione (rimasta inattuata) di una successiva filiazione di «sezioni» regionali.
Dipendente dalla Regione siciliana e non, naturalmente, dall’Istituto romano, il Crpr ha proprio tra i suoi compiti istituzionali la collaborazione con quest’ultimo.
Mentre, dunque, a livello ministeriale è stata indetta una selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore che dovrà confrontarsi con la prova di autonomia di venti eccellenze museali del Bel Paese, in Sicilia, dopo la poco significativa gestione di Adele Mormino (ottobre 2010–aprile 2013, cfr. n. 321, ‘giu. ’12, pp. 56 e 57), nel luglio 2013, alla direzione del Centro è stata spedita una dirigente «discussa», Enza Cilia, fresca di nomina a capo di Gabinetto di Crocetta e prontamente trasferita ad altro incarico (anche se il Governatore dichiarava: «Io ho piena fiducia in Enza Cilia») dopo un articolo al vetriolo sul settimanale «Centonove» (23 novembre 2012), in cui il giornalista Enzo Basso riporta le dichiarazioni rese nel corso di un processo abbreviato dall’ex magistrato Silvio Raffiotta, titolare delle più importanti inchieste sui traffici illegali di reperti archeologici diretti attraverso la Svizzera negli Stati Uniti (su tutti, la Venere di Morgantina al Getty e gli Argenti al Met). L’allora procuratore della Repubblica di Enna aveva contato ben 19 procedimenti penali (per i quali si legga oltre), dal 1990 al ’99, a carico della Cilia, mentre era titolare della sezione archeologica della Soprintendenza di Enna e anche soprintendente facente funzione (tra il 1992 e il ’93).
Questa dirigente, con questi trascorsi, la si è piazzata a dirigere quello che avrebbe potuto essere il fiore all’occhiello dei Beni culturali targati Trinacria.
Il Crpr: la storia
Quando vi approdò Meli nel 2001 il Centro non vantava trascorsi gloriosi. Il dirigente generale dell’epoca gli diede, con inusuale spirito manageriale degno dei privati, «due anni di tempo, ricorda l’architetto, o riuscivo a farlo decollare o si sarebbe chiuso». «Fondato nel 1982 ai sensi della legge regionale 80/1977, ricostruisce per noi Meli, agli esordi, nella sede di Viale Strasburgo, aveva non un direttore, ma un commissario straordinario, Maria Teresa Currò, con solo due impiegati, uno dei quali Salvatore Mineo, memoria storica dell’Istituto, referente continuato per gli aspetti amministrativi ed economici fino a quel 2010. Con i concorsi degli anni ’80 il Centro acquisisce personale specializzato tecnico–scientifico, bibliotecari e archivisti ecc., e a cavallo dei primi anni ’90 vengono attivati i primi laboratori scientifici (chimica, biologia e fisica) e di restauro». Dall’88 al ’99 alla Currò succedono quattro funzionari facenti funzione, fino a quando con la L. 10/2000 viene prevista la nomina di un direttore, e designato, quindi, Meli nel 2001. È allora che il Centro viene trasferito nella sede attuale di Palazzo Montalbo e si riparte con una serie di progetti e programmi a pieno regime, mentre fino a quel momento la produzione scientifica era stata limitata e saltuaria (piccoli progetti pilota e interventi circoscritti a consulenze richieste dalle Soprintendenze). Sono quelli gli anni di restauri come dell’ala Settecentesca di Palazzo Abatellis per ampliarne lo spazio espositivo per i dipinti del Cinque e Seicento, o dell’intervento conservativo della Villa romana del Casale; di convegni internazionali, col Getty sul rischio sismico o e con l’Iccm sulla conservazione dei mosaici, o ancora il confronto con gli Istituti di restauro dell’area mediterranea; e la mutuazione di progetti nazionali come la Carta del Rischio del Patrimonio dell’allora Icr, ma anche del lancio di progetti originali coma I Luoghi della Memoria. Questi ultimi due sono gli unici progetti regionali di cui Alessandra Mottola Molfino abbia ritenuto di dover far menzione nel suo Viaggio nei musei della Sicilia (Kalòs, 2010).
Finanziamenti
La dotazione annuale fino al 2001 si aggirava intorno al milione di euro, una bella cifra per fare poco o niente, producendo avanzi d’amministrazione da capogiro, segno di cattiva gestione e di inefficienza: svariate centinaia di milioni non spesi negli anni precedenti recuperati e reinvestiti da Meli nei primi quattro anni e poi nei successivi. Nel suo ultimo anno il finanziamento si era dimezzato a 560mila euro e in quello dopo, nel 2011, sotto la Mormino era di 540mila, per precipitare con la Cilia, nel 2014, a 74mila. A queste cifre si devono sommare i 200mila accreditati per il Corso di Laurea a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali, istituito nel 2004 e abilitato nel gennaio 2012. Proprio per questo drastico taglio alle erogazioni ordinarie, e in assenza di canali di finanziamento da terzi, quali fondazioni o società private, vitale sarebbe stata la capacità di canalizzare, come in passato, i fondi europei per i «progetti speciali», progetti internazionali di cui il Centro è partner. Gli ultimi due avviati nel 2008, «Artea» sui teatri antichi nel Mediterraneo e «Lithos» in cooperazione con Malta per un centro internazionale di ricerca nel campo della stereotomia e dei materiali lapidei da costruzione , si sono conclusi nel 2011 e 2013 (Mormino). Più nulla in cantiere con la prossima chiusura anche di «Aper», afferente al Programma Italia-Tunisia, avviato nel 2012 per la ricerca diagnostica nei siti tunisini di Utica e Kerkouane.
Personale
Tra il 2001 e il 2010 il Centro aveva raddoppiato il personale, arrivando ad oltre 100 unità, poi passate a 80 sotto la Mormino, per conoscere poi una vera e propria diaspora all’arrivo della Cilia. «Quando è stata chiamata a dirigere il Crpr le richieste di trasferimento sono state tali da costringere a bloccarle per evitare che, un giorno o l’altro, l’archeologa si aprisse il portone da sola!», ironizza un fuoriuscito. Cosicché oggi ci sono 70 persone, di cui poco più di una ventina con mansioni tecniche, tra chimici, biologi, architetti, tecnici di laboratorio o fotografi, e 11 provenienti dal bacino Emergenza Palermo ex Pip: indigenti, disoccupati ed ex detenuti assunti per attività di supporto logistico (pulizie, trasporto pratiche, fotocopie ecc.), secondo un modello di sistema assistenzialista siciliano (e non solo) non toccato nemmeno dal Governatore «rivoluzionario».
Il restauratore, in un Centro che si chiama del Restauro, è uno solo: Lorella Pellegrino, entrata nel 1984, specializzata all’Opd in lapidei e mosaici e all’ex Icr in intonaci dipinti. Sotto le sue mani sono passati i pezzi più pregiati delle collezioni lapidee siciliane: dal busto di Eleonora d’Aragona di Palazzo Abatellis al Torso di Mozia del Salinas, dagli stucchi del Serpotta provenienti dall’Oratorio di Santa Cita e ricollocati nell’Oratorio dei Bianchi ai mosaici e affreschi della Villa romana del Casale. Un laboratorio, quello che dirige, a un certo punto pure fantasma. Con la rimodulazione dell’assetto organizzativo del Dipartimento dei Beni Culturali del 2010 non venne, infatti, singolarmente, riproposto uno dei suoi pilastri istituzionali: confermati i laboratori di diagnostica (chimica, fisica, biologia, microbiologia e bioarcheologia), scomparve sulla carta, non nella sua consistenza fisica, quello di restauro, dove, tra l’altro, si svolge attività didattica e di tirocinio con il Corso in Conservazione. Ci volle un decreto dell’anno dopo per riparare a questa anomalia. Adesso non c’è niente per il laboratorio «riabilitato» della Pellegrino: una statua lignea, un reliquiario, poco altro. Una presenza, la sua, quasi simbolica, in mancanza di altri restauratori per tipologie diverse di materiali. Una grave lacuna in organico per un Centro che intende dotarsi di nuovi spazi e attrezzature (cfr. oltre «Progetti»).
Non è solo una questione di numeri, dal 2010 si è assistito a una totale destrutturazione, con personale altamente qualificato che ricopriva ruoli chiave (su tutti, Roberto Garufi o Ermanno Cacciatore) trasferito, vuoi per le famigerate rotazioni siciliane con cadenza biennale, vuoi per inconciliabilità con l’opinabile programmazione dei due ultimi direttori, presso altri istituti del Dipartimento Beni culturali. Qui, insomma, con dirigenti e tecnici prossimi al pensionamento, non solo non si pensa a un ricambio generazionale, ma si è fatto in modo di disperdere le competenze acquisite.
Progetti
Il dato più macroscopico dell’attuale corso è la chiusura, dal periodo Mormino, del Sit (Sistema informativo territoriale) siciliano della Carta del Rischio, cartella clinica dei monumenti, che mette in correlazione la loro vulnerabilità con le pericolosità presenti nel territorio. Gettati alle ortiche 4 milioni di fondi europei che il Centro dal 2001 al 2008 ha gestito, speso e concluso. Sprechi che l’Ue non sembra più intenzionata a tollerare, se, come denunciato dall’eurodeputato Ignazio Corrao del M5s, «dei 300 milioni previsti per la programmazione precedente si arriverà al massimo a 100 milioni del nuovo programma di finanziamenti “Cultura e Sviluppo” 2014-2020».
Nel novembre 2009, quando era stata presentata la Carta, di cui era responsabile l’architetto Garufi, i beni censiti erano 10.178, 2.500 le schede di vulnerabilità, 99 i comuni oggetto del rilevamento, oltre a sei i volumi prodotti e due video didattici per le scuole (cfr. n. 293, dic. ’09, p. 12). Tra le varie calamità possibili, prendiamo, per esempio, il caso di un terremoto in una regione come la Sicilia con elevata sismicità: alla banca dati online operatori, Soprintendenze e Protezione civile potevano accedere dal sito www.cartadelrischio.sicilia.it; cliccando sopra l’epicentro si apriva un ventaglio spaziale in cui era possibile individuare immediatamente, consentendo quindi di intervenire in maniera mirata, i beni compresi all’interno della cosiddetta buffer zone di influenza sismica e stabilire le priorità. La Cilia ci riferisce che il Sit «sarà di nuovo disponibile al termine della revisione e aggiornamento». Sennonché, cosa singolare, in atto non c’è proprio nulla. E, intanto, perché «oscurarlo»? L’abbiamo chiesto all’assessore ai Beni culturali siciliani Antonino Purpura che ci dice di «problematiche connesse ad alcune criticità di natura tecnica rilevate in corso di funzionamento, quali l’aggiornamento del software e la necessità di procedere alla individuazione di più idonei locali ove allocare il relativo server». «Funzionante» sicuramente il Sistema lo era quando era stato presentato. Ad attestarlo è Carlo Cacace, responsabile della Carta del Rischio all’Iscr, che aveva collaborato, nell’ambito di un accordo tra i due Istituti, palermitano e romano, alla progettazione di quella siciliana, secondo gli schemi metodologici del sistema nazionale. «Trasmettemmo, ricorda Cacace, tutti i documenti tecnici della nostra architettura di sistema e anche i dati della Regione Sicilia già presenti nel nostro sistema. Il lavoro effettuato dal Crpr, dunque, è stato quello di realizzare la piattaforma informatica importando tutto quello che avevamo realizzato, i nostri algoritmi di calcolo, ma andarono anche oltre, affinando gli algoritmi in funzione della specificità territoriale siciliana, effettuando schedature sullo stato di conservazione dei beni culturali presenti e implementando anche altre forme di rilevamento dei beni di sicuro interesse».
Le criticità di cui parla l’assessore non risalgono sicuramente a quegli anni: «Durante le attività di realizzazione del sistema siciliano a cui ho partecipato questo era funzionante, le schede erano presenti», precisa Cacace. «Ovviamente, prosegue, il sistema realizzato deve prevedere spese per il suo mantenimento, per le necessarie manutenzioni evolutive che sono indispensabile per le corretta utilizzo a regime. Durante le attività di utilizzo emergono delle criticità normali che attraverso una manutenzione evolutiva possono essere corrette, così come è avvenuto per il sistema della Carta del rischio dell’Iscr».
Concluso il progetto, era previsto che la collaborazione proseguisse negli anni successivi «se si fossero realizzate le condizioni economiche per il centro Crpr per realizzare evoluzioni e/o aggiornamenti del sistema». Invece si è interrotta. Le «condizioni economiche», in realtà, non sarebbero mancate. Nel 2012, tra i progetti in attesa di finanziamento col Po Fesr 2007-2013, c’era proprio quello per «una riconversione dell’architettura di sistema della Carta» (639.980,00 euro, cfr. n. 321 cit.). Nella scheda descrittiva dell’intervento si leggeva anche: «l’esigenza di colloquiare con il sistema di gestione dei piani paesistici e dei dati catalografici dei beni culturali siciliani (…) comporta la realizzazione di una piattaforma di integrazione che, attraverso sistemi del tipo data warehouse e Etl, permetta il collegamento continuo e aggiornato con le altre banche dati in possesso del Dipartimento Beni culturali». Si prevedeva, inoltre, di estendere il sistema «in campo archeologico e paesaggistico, naturale e naturalistico». Che fine ha fatto questo progetto? Perché non è stato finanziato?
Alla questione nel suo complesso, che non era stata sollevata fino all’interrogativo posto da «Il Giornale dell’Arte», l’assessore pensa di rimediare ritentando la strada dei finanziamenti comunitari. Sta «valutando, ci ha detto, la possibilità di predisporre un progetto di aggiornamento e implementazione del Sistema, sfruttando anche i fondi della nuova programmazione europea 2014–2020, che contempla anche l’innovazione tecnologica tra le sue priorità».
Per il resto, i progetti che avevamo soltanto annunciato nel 2012, sempre grazie ai fondi del Po Fesr 2007–2013 (cfr. n. 321 cit.) sono al palo, se si eccettuano i lavori per la «Conservazione del patrimonio archeologico del Val di Mazara»: ancora da allestire, infatti, alcune sale di Palazzo Steri con strumenti musicali provenienti da 49 Paesi; e non acquistato il rudere adiacente a Palazzo Montalbo, destinato all’ampliamento dei Laboratori scientifici, grazie al quale il Centro sarebbe in grado di erogare, anche in via onerosa, le indagini diagnostiche.
Non si sa quando si ultimerà il restauro del Villino Florio (586mila del Po Fesr 2007-2013), altro progetto ereditato dall’attuale direttrice. Di «nuovo» c’è solo la ripresa (dal dicembre 2013) dei Luoghi della Memoria, progetto fermo durante gli anni Mormino, nato da una costola della Carta del Rischio e il cui primo censimento risale al 2008 con 700 elementi. Scopo: «individuare, salvaguardare, conservare, fruire in modo sostenibile gli spazi fisici legati ai culti, riti, eventi e personalità che hanno determinato tappe significative nella storia,nella cultura e nella tradizione dell’Isola». Attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali per una cultura condivisa della tutela.
Qualche segno di vita mostra ancora l’attività diagnostica per restauri e prevenzione sui Beni Culturali svolta dai laboratori di Biologia, Chimica e Fisica: sui dipinti del museo Abatellis, sul «crepidoma» del Tempio della Concordia, per il Duomo di Monreale e il Museo Arcivescovile, per il restauro e il recupero degli elementi lapidei del Giardino di Villa Trabia, oltre all’avvio del monitoraggio della Villa romana del Casale di Piazza Armerina, dopo l’ultimo importante intervento conservativo.
Convegni e pubblicazioni
Solo un ricordo del passato i convegni internazionali che ogni anno si tenevano in ottobre. L’ultimo è stato nel 2010, col Getty Museum sulla protezione dei beni culturali dal danno sismico. Prima si ricordano, nel 2008, la X Conferenza del Comitato internazionale per la conservazione del mosaico, con la presentazione in anteprima del restauro del mosaico della «Trasfigurazione» del Monastero di Santa Caterina nel Sinai; o nel 2007 «La Materia e i Segni della Storia», in cui si erano gettate le fondamenta di una rete mediterranea degli istituti che lavorano nell’ambito della conservazione col fine di elaborare una Carta del Rischio del patrimonio storico-artistico del Mare Nostrum, oltre ad offrire occasione a esperti di tutto il mondo di una irripetibile visione ravvicinata dei mosaici bizantini e dei “muqarnas” della Cappella palatina, grazie ai ponteggi del restauro allora in corso.
La rivista semestrale di informazione non si pubblica più dal 2009. Forme di pubblicizzazione di altro tenore corrono, piuttosto, sul sito del Centro. Fino a qualche mese fa nella homepage campeggiava non un progetto o un restauro, ma l’avviso di vendita di una «BMW berlina 318 D targata BZ 928 NT di proprietà del Centro». Auto di servizio, o se si vuole di rappresentanza. Quando ancora qualcosa il Crpr rappresentava.
Le ombre sulla direttrice del Centro
E poi c’è lei, Enza Cilia, una «nobile» dopo il suo matrimonio col marchese Giuseppe Platamone (scomparso nel 2008), discendente di uno dei casati siciliani più influenti nel Quattrocento e ancora a Trapani fino al secolo scorso. Archeologa, tra i suoi precedenti incarichi ci sono la direzione del museo Archeologico di Enna, quello di Gela, del Museo regionale della Ceramica di Caltagirone, la Soprintendenza di Enna e di Ragusa, dell’Ufficio Speciale per il Polo Museale di Catania e del Servizio Ispettivo dell’Assessorato.
È stata al centro di una pagina oscura dei Beni culturali siciliani, in una Enna tra gli anni Ottanta e Novanta epicentro di una sistematica spoliazione di reperti archeologici che alimentarono il traffico internazionale di reperti e in cui s’intrecciano vicende e personalità dense di ombre, e dove Vincenzo Cammarata ha messo su quella che è forse la più importante collezione privata (numismatica, soprattutto) in età contemporanea in Sicilia, posta sotto sequestro nel ’99 e ancora in custodia giudiziaria presso la Soprintendenza di Catania. In quegli anni l’attuale direttrice del Crpr risulta costantemente indagata. Come riportato nell’articolo di «Centonove», nel corso del processo «abbreviato» al Tribunale di Catania che vedeva sul banco degli imputati anche il procuratore Raffiotta (poi assolto) per le accuse di un pentito di mafia che lo voleva vicino ai trafficanti di reperti archeologici, chiamato anche a rispondere del reato di concussione contro la funzionaria, il magistrato riferì che la Cilia avrebbe autorizzato l’espianto di un noccioleto alle falde del monte Mangone, sopra la Villa romana del Casale, causandone la successiva «inondazione colposa» nellʼalluvione dellʼottobre ʼ91; «avrebbe fatto scavare, scrive Basso, un sito diverso da quello indicato dal professor Malcom Bell, sul luogo presunto del ritrovamento del Tesoro di Morgantina finito poi al Metropolitan Museum»; nel 1992, soprintendente facente funzioni, «avrebbe tollerato lavori di scavo delle imprese Rendo e Lodigiani nel sito archeologico di Ancipa, vicino alla diga, e per questo rimedia una denuncia per falso ideologico. Il procedimento verrà archiviato». Veniva anche accusata di mancata vigilanza sui depositi del museo di Aidone, dove erano avvenuti una serie di furti, sospesa quindi dai pubblici uffici, fu oggetto pure di un’ispezione dell’Assessorato; di aver apposto un vincolo nell’area archeologica di contrada Marcato, in quel di Valguarnera (Enna), ma in una zona dove giusto non c'erano resti archeologici ma uno sventramento di cava; o di aver autorizzato i lavori per la diga di Pietrarossa, dove si è rischiato che i resti di un villaggio di epoca romana fossero sepolti dall’acqua.
Protagonista Enza Cilia è stata pure di due pamphlet anonimi negli anni a cavallo del nuovo secolo, intitolati L’Avvocato e la Marchesa, firmati da tal Eliodoro&Ducezio, dossieraggio in chiave Wikipedia, concepito perché le informazioni riservate e scottanti fossero implementate via internet. Date e fatti, dagli anni Trenta fino al 2001, con l’obiettivo di destabilizzare non solo gli uffici dei Beni culturali, ma certi poteri forti siciliani.
Articoli correlati:
«Troppa improvvisazione e nessuna programmazione»
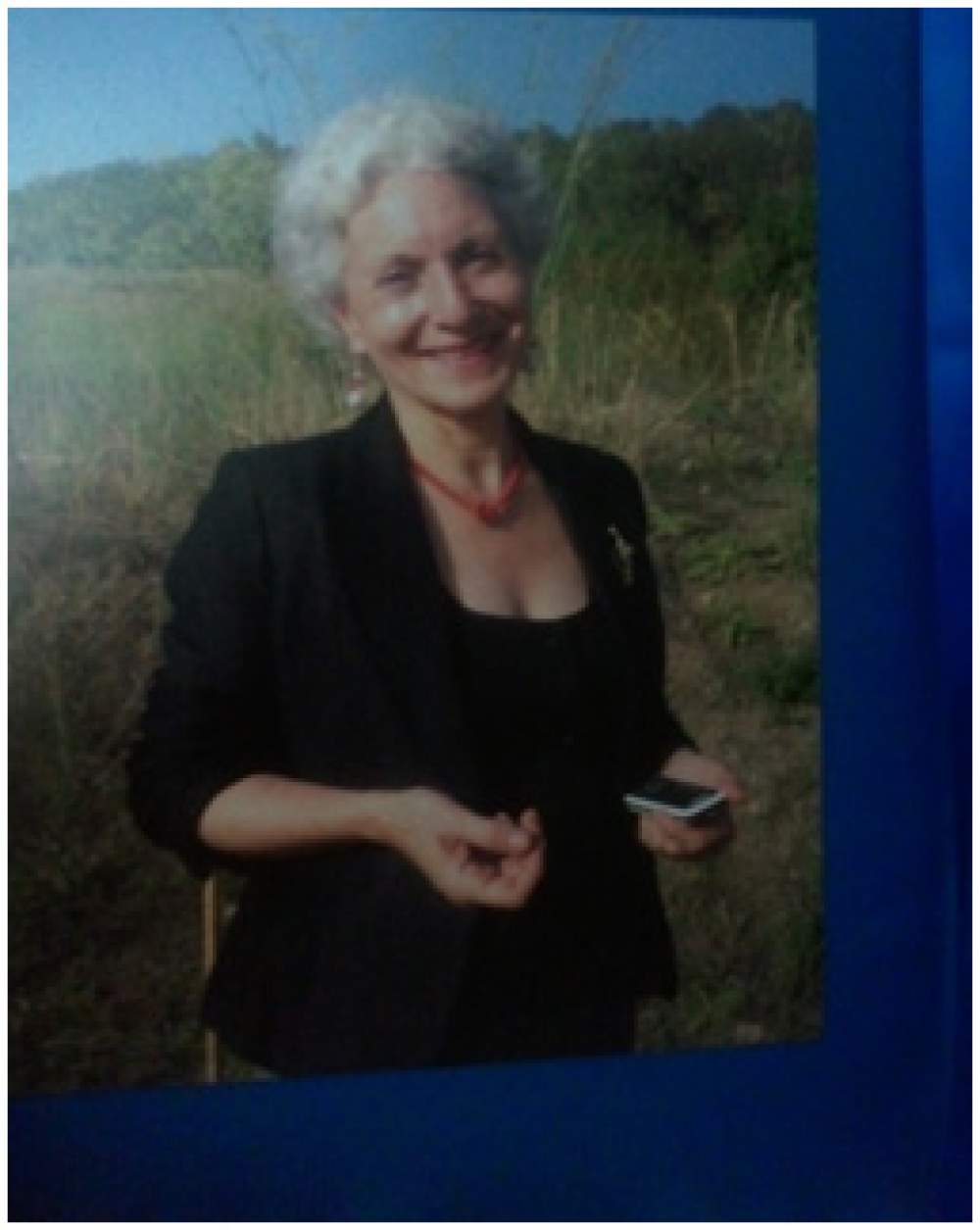
Enza Cilia

Guido Meli

Villa del Casale con la nuova copertura. Sala Absidata detta Diaeta di Orfeo. Statua di un Apollo Liceo

Adele Mormino
Altri articoli dell'autore
La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera
Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni
Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma
Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.



















