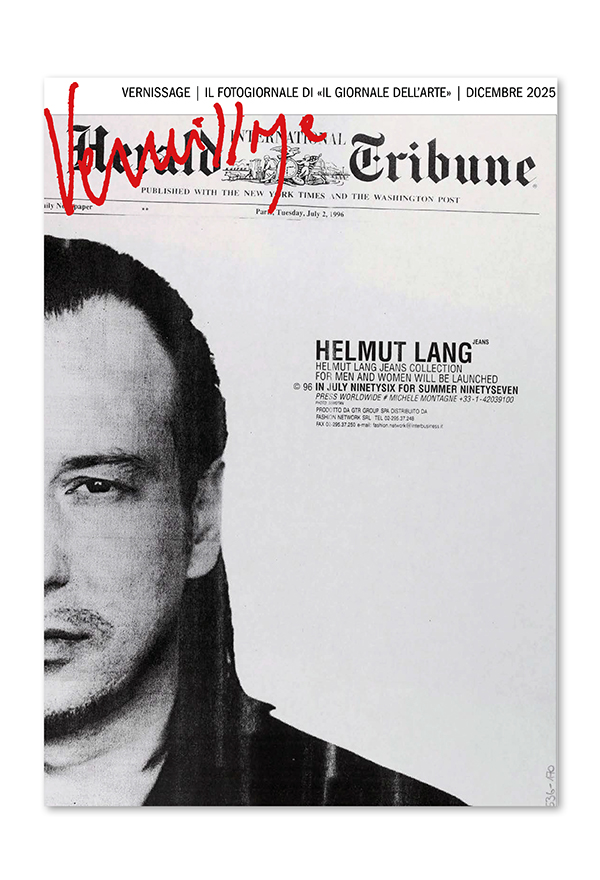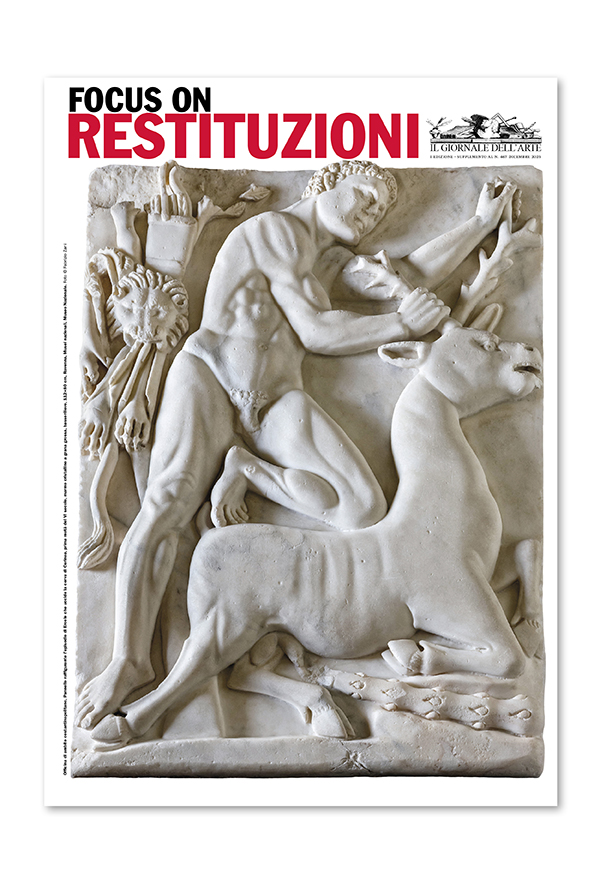Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Rica Cerbarano
Leggi i suoi articoliFrida Orupabo (Sarpsborg, Norvegia, 1986) è un nome che sentiremo sempre più spesso. Le sue opere sono incluse in numerose collezioni prestigiose, tra cui quelle della Tate, del Guggenheim Museum e del Lacma, e nelle ultime fiere del settore (in ottobre a Londra, a Frieze, e poi nell’ultima edizione di Paris Photo), l’artista di origini norvegese e nigeriane è sempre stata presente. Rappresentata da tre gallerie (Galerie Nordenhake, Stevenson Gallery e Modern Art Gallery), sta preparando per il 2025 ben due mostre personali: presso l’Astrup Fearnley Museum di Oslo e lo Sprengel Museum di Hannover. Ad averla portata sotto i riflettori è stato Arthur Jafa, scoprendo il suo lavoro su Instagram e invitandola, nel 2017, a prendere parte alla sua mostra «A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions» alle Serpentine Galleries di Londra. All’epoca infatti Orupabo lavorava nel sociale e pubblicava i suoi collage, immagini e video, sul proprio account @nemiepeba, mentre oggi le sue sono opere di grandi dimensioni, assemblaggi di carta fissati con semplici spilli o applicati su un supporto di alluminio.
Il suo lavoro ha tutte le caratteristiche per emergere nel marasma del mondo dell’arte: trasuda una potenza estetica impressionante, denuncia una questione politico-sociale ormai imprescindibile, ed è il frutto di un’esperienza autobiografica. Come tante artiste femministe che vedono nella pratica del collage una chiave di volta per esprimere la pluralità di prospettive che compongono la realtà, anche Orupabo si affida alla tecnica dell’assemblage. Nel suo caso, le immagini oggetto del suo «taglia e cuci» provengono da archivi coloniali, internet (eBay, Tumblr, Instagram) e riviste. Il linguaggio fotografico viene mescolato con quello della pittura, del cinema e della pornografia, dando vita a creature che sembrano uscite da un sogno, oppure da un incubo. Incollando tra di loro parti del corpo, vestiti, oggetti e animali, Orupabo mette in scena personaggi kafkiani, mai esistiti eppure tremendamente reali, così reali perché emergono da un’urgenza con cui l’artista ha convissuto per tutta la vita: quella di riconoscersi nelle immagini veicolate dai mass media, una necessità sempre mancata per la totale assenza di visibilità di donne nere nella cultura visiva occidentale. Il suo lavoro colma questo vuoto con una carica emotiva disarmante, soprattutto quando affronta l’erotismo femminile e l’oggettivazione sessuale dei corpi black. Davanti alle sue opere, è facile sentirsi osservati in maniera ostile: non a caso, gli occhi delle sue creature ipnotiche sono spesso puntati dritti sullo spettatore, con un piglio accusatorio. Ma è davvero così, o siamo noi a ritrarci di fronte a questi volti assertivi, insospettiti da una rappresentazione di cui non troviamo corrispettivo nel mondo in cui siamo cresciuti?
Abbiamo intervistato l’artista per scoprire di più sul suo lavoro.
Come si è evoluto il suo interesse per il collage?
Credo che il mio interesse per il collage sia nato abbastanza presto, mescolando elementi e materiali diversi senza avere una comprensione diretta di ciò che stavo facendo. Molto prima che iniziassi a fare collage digitali, in un periodo in cui principalmente disegnavo e dipingevo, ricordo di aver realizzato un dipinto e di avervi aggiunto una foto di mio padre e altri materiali, come stoffa e pezzi di carta da parati. Un paio di anni dopo, ho comprato uno scanner per diapositive e negativi, cosa che mi ha permesso di scansionare molte foto di famiglia, che poi ho rielaborato, manipolato e tagliato in Photoshop. Credo che quella sia stata la prima volta in cui ho usato intenzionalmente il collage. Oltre a essere piacevole, era necessario. Alcune parti dovevano essere rimosse e altre aggiunte per ottenere l’immagine o il soggetto che volevo. In seguito, quando ho iniziato a lavorare con immagini trovate, il collage ha avuto ancora più senso perché raramente trovavo quello che cercavo. Ad esempio, cercando «donna che riposa» o «madre con bambino» su eBay o Etsy, trovavo per lo più donne bianche che riposavano o donne bianche che si occupavano dei loro bambini. Dovevo quindi ritagliare e cambiare le loro braccia, teste, gambe e sostituirle con arti che assomigliassero ai miei. Credo di essermi avvicinata al collage proprio per questo motivo: noi donne nere non eravamo visibili da nessuna parte e, se eravamo visibili, spesso lo eravamo in modo molto disumanizzante. Il collage ha permesso di creare nuove verità e nuovi modi di vedere.
La tecnica del collage è ampiamente utilizzata nelle pratiche artistiche femministe. C’è qualche artista o «maestra» che la ispira?
Sì, ci sono molte artiste che mi vengono in mente e non penso solo alle donne che lavorano con il collage. Ho postato sul mio instagram (@nemiepeba) molti lavori di artiste che considero un’ispirazione, come quelli di Kara Walker, Nomusa Makhubu, Kenyatta a.c. Hinkle, Lotte Reiniger, Jeannette Ehlers, Nathalie Mba Bikoro, Lorna Simpson, Leah Gordon, Rehema Chachage, Lubaina Himid, Nontsikelelo Mutiti e Wangechi Mutu.

«A lil help» (2021) di Frida Orupabo. © Frida Orupabo. Cortesia dell’artista e Galerie Nordenhake
Molte delle sue immagini provengono da Internet. In che modo il web ha influenzato la sua prospettiva sulle immagini?
Non so dire come il web abbia influenzato la mia prospettiva sulle immagini, perché non ho un altro termine di paragone. Credo che Internet abbia aperto un nuovo mondo in termini di immagini. A un certo punto passavo intere giornate a cercare e scaricare immagini che poi avrei usato nel mio lavoro, alcune delle quali non sono mai state usate e mai lo saranno. Le immagini online sono più immediate di quelle contenute in libri, riviste o archivi fisici. Mi piace come si possa spaziare da 0 a 100 in termini di profondità o intensità.
Utilizza solo fotografie come materiale di partenza o incorpora anche altri tipi di immagini?
Ora utilizzo di tutto. Immagini di oggetti da eBay o Etsy, di archivi coloniali, di dipinti, disegni di mia figlia, e così via. Prima lavoravo prevalentemente con fotografie di archivio, il che poteva rendere più difficile capire se le diverse parti del collage fossero tratte da immagini diverse o meno. Credo che il cambiamento di prospettiva abbia reso i collage un po’ più surreali, più fumettistici e colorati (a volte).
Può descrivere il suo processo creativo? Immagina la forma finale di ogni opera fin dall’inizio o è qualcosa di più intuitivo?
È molto intuitivo. Non ho idea di dove andrò a finire quando comincio a creare un collage: inizio con una parte che trovo bella, può essere una forma astratta, una schiena o un volto. È lo stesso processo che uso quando colloco le opere in una mostra. Prima raccolgo i collage, poi li posiziono e costruisco una narrazione quando tutti i singoli pezzi sono pronti.
In una precedente intervista, lei ha detto: «Voglio che la mia arte sia complessa». Che cosa intende?
Complessa in un modo che ci fa mettere in discussione le nostre prospettive e i nostri valori, il nostro essere scontati. Parlo di complessità anche in relazione alle identità. Essere visti come un individuo complesso. Complessità come contrasto a un modo stereotipato e disumanizzante di vedere gli altri.
La sua arte è legata all’espressione di un bisogno individuale o ha piuttosto uno scopo di commento sociale?
È sia personale che politica, e credo che le due cose vadano di pari passo. Anche il piacere o la felicità individuale che l’opera mi dà può essere collegato a un commento sociale.
Quale impatto vuole che la sua arte abbia sulle persone? Come lavora per ottenere questo effetto?
Riuscire a creare qualcosa che commuova le persone è una bella sensazione. Inoltre, dico spesso che voglio che la gente si interroghi sulle cose che vede. Questo si ricollega alla domanda che mi ha posto sul desiderio di realizzare opere complesse. Ma va bene anche se tutto questo non accade. Continuo a creare lavori per me stessa, non penso tanto al pubblico. Mi interessa come ciò che faccio influisce sul modo in cui mi sento.
Quali sono i suoi prossimi passi? Come vede evolversi la sua arte?
Non ne sono sicura, non sono una persona che pensa molto ai prossimi passi. A volte le cose nascono da errori e ti portano su nuove strade. Credo di aver iniziato di recente a pensare più seriamente allo spazio in cui le mie opere saranno esposte e a come questo influisca sull’opera stessa. Questo ragionamento è sempre stato presente nella mia mente mentre lavoravo, ma è la prima volta che ho avuto l’energia e la volontà di pensare in modo più critico a ciò che uno spazio contiene, in termini di potenziale o di limiti, ed è qualcosa che mi piace molto.

Una veduta della mostra «All is broken in the night» (2024) di Frida Orupabo, Galerie Nordenhake Berlin. Cortesia dell’artista e Galerie Nordenhake Berlin/Stockholm/Mexico City, foto: Gerhard Kassner
Altri articoli dell'autore
Un progetto partecipativo realizzato in Emilia celebra la fotografia come esperienza collettiva
Alle Gallerie d’Italia-Torino 27 opere, dalle fotografie più importanti della fine degli anni Settanta a quelle più recenti, di uno dei più significativi e influenti fotografi contemporanei
Il direttore de Les Rencontres d’Arles, la rassegna dedicata all’ottava arte più longeva e prestigiosa del mondo, ci racconta il suo festival: artisti emergenti, grandi maestri e un legame forte con il territorio
Alla Bundeskunsthalle di Bonn una mostra ricca di immagini e spunti sulla vita di una delle voci più lucide del contemporaneo. Resta però in superficie l’analisi della sua riflessione sull’etica della fotografia