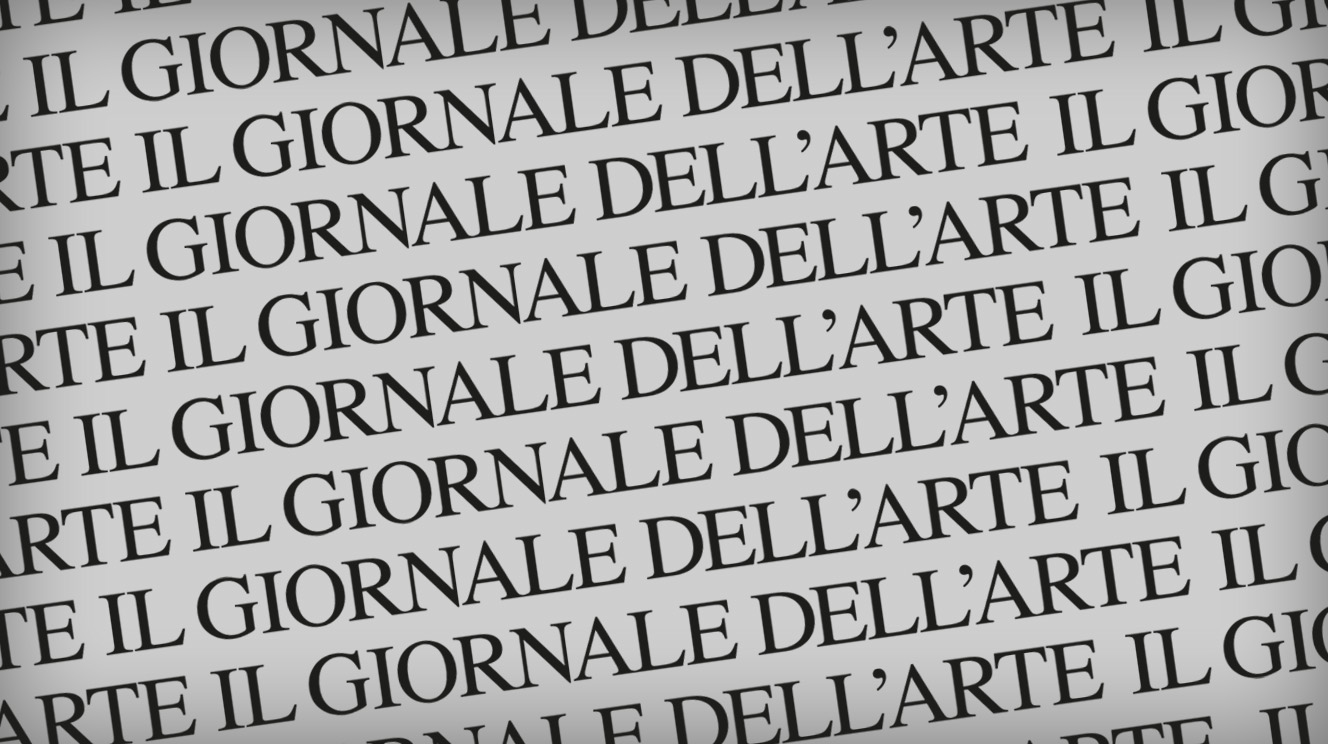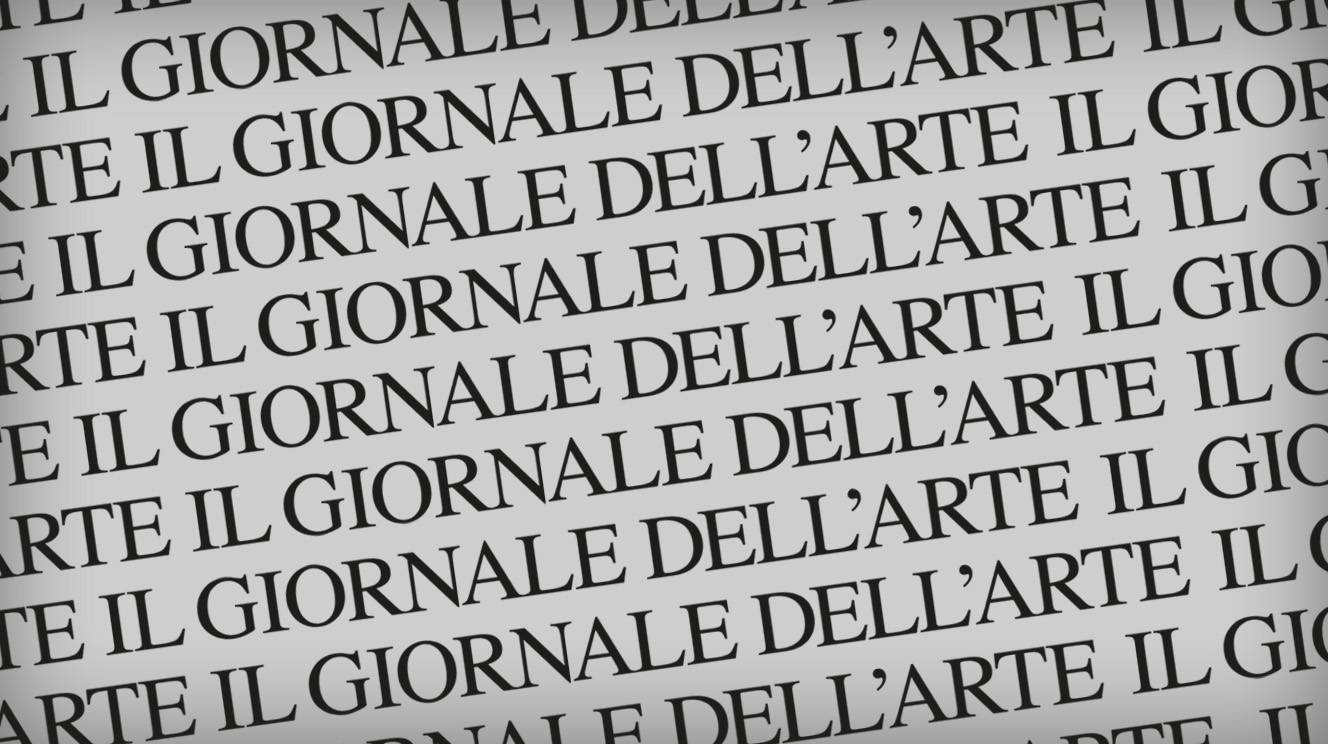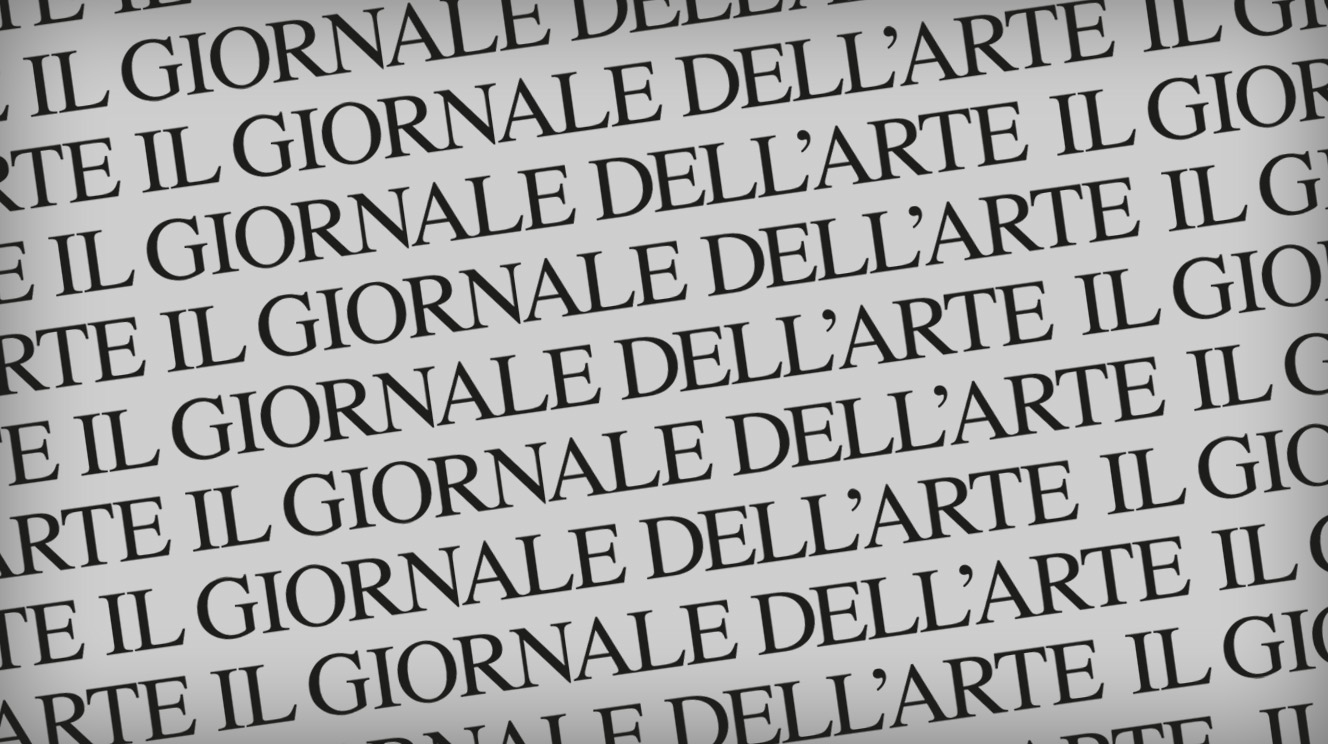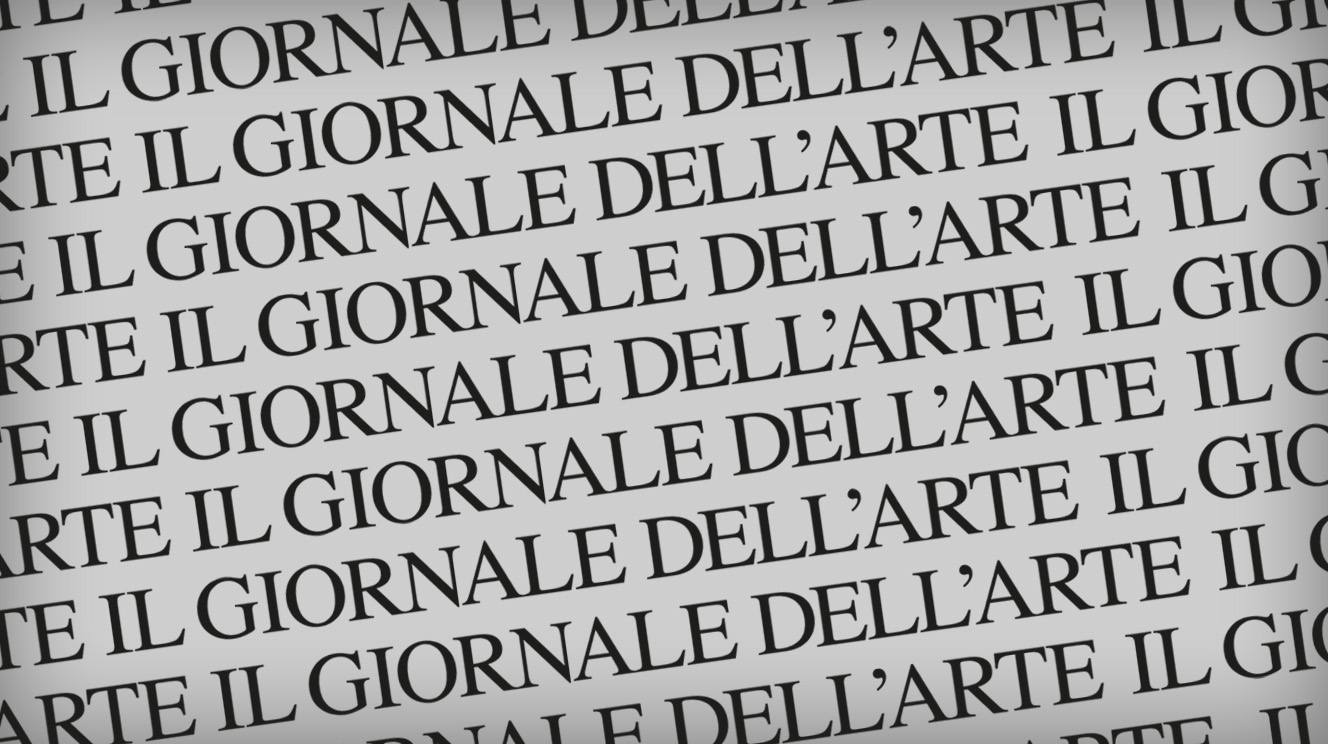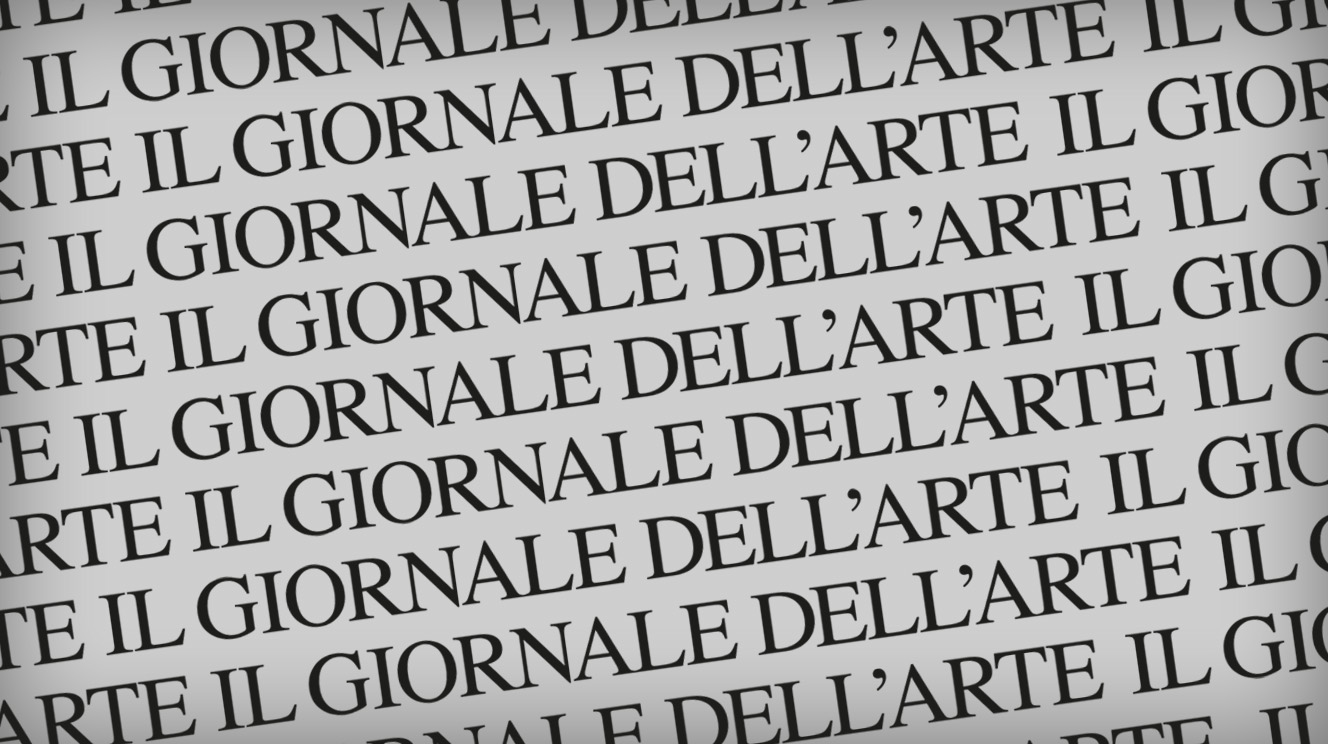Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Michele Dantini
Leggi i suoi articoliIl merito maggiore di De-tutela è nella pluralità delle posizioni accolte. Al netto della cerimoniale compostezza del discorso accademico, il volume raccoglie dissensi spesso aspri e divergenze non solo tecnico-scientifiche ma di cultura politica.
È una giusta osservazione di Andrea Emiliani, contenuta nell’ormai storico Una politica dei beni culturali (cfr. n. 348, dic. ’14, p. 26), quella secondo cui il dibattito sulle politiche di tutela non è mai riuscito, in Italia, a coinvolgere un più ampio numero di partecipanti perché troppo centrato su una cultura tecnico-giuridica. La circostanza non è certo mutata in anni recenti, al contrario. Una preclusione spesso dogmatica contro gli aspetti economici del «patrimonio», l’invocazione precritica dei «padri costituenti» o l’appello alle più retrive emozioni comunitaristiche ha distinto i sostenitori della tutela pubblica nella loro ossessiva polemica contro i «privatizzatori», accusati, peraltro non senza ragione, di sommarietà e rozzezza commerciale. Sono mancate le posizioni terze, o meglio: non hanno ricevuto sufficiente attenzione. Oggi viene forse il momento di sperimentare punti di vista innovativi e qualificati, aperti alla migliore ricerca internazionale, umanistica e non. Punti di vista soprattutto laici, capaci di adeguare la nostra cultura della tutela ai principi di una democrazia liberale.
Se consideriamo la questione «tutela» da punti di vista sufficientemente ampi e impersonali dobbiamo riconoscere che in Italia esistono difficoltà specifiche, talune destinate ad aggravarsi perché connesse alla scarsità di risorse. In primo luogo: la vastità del patrimonio pubblico, motivo di orgoglio e al tempo stesso ingente onere economico. In secondo luogo: l’inefficienza del Mibact e l’arretratezza ideologico-culturale di parte dell’infrastruttura pubblica della tutela. In terzo luogo: la forza e il radicamento territoriale di organizzazioni criminali che regnano su parti della penisola e prendendo parte attiva, con politici e imprenditori locali, alla distruzione del paesaggio e del patrimonio. In quarto luogo: il malfunzionamento delle istituzioni educative superiori (siamo certi, sotto questo profilo, che la comunità accademica degli storici dell’arte e degli archeologi italiani sia priva di responsabilità quanto alla progressiva erosione dei vincoli di «appartenenza»? L’opacità dei processi di reclutamento universitario ha allontanato nel tempo le componenti più vive delle giovani generazioni dalla ricerca umanistica e impedito loro di sentirsi parte di un’«eredità culturale» e di un «patrimonio» condivisi).
Infine: esiste il problema dell’informazione. Giornali e televisioni privilegiano, come già accennato, polemiche e stridule recriminazioni. Tra i compiti di chi fa ricerca a livello istituzionale sembrerebbe allora doversi annoverare anche quello di distaccarsi dalla mera cronaca, educare al ragionamento e praticare una costante, severa autoformazione. q Michele Dantini
De-tutela. Idee a confronto per la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico, a cura di Lorenzo Carletti e Cristiano Giometti, 172 pp., ill., Ets, Pisa 2014, € 15,00