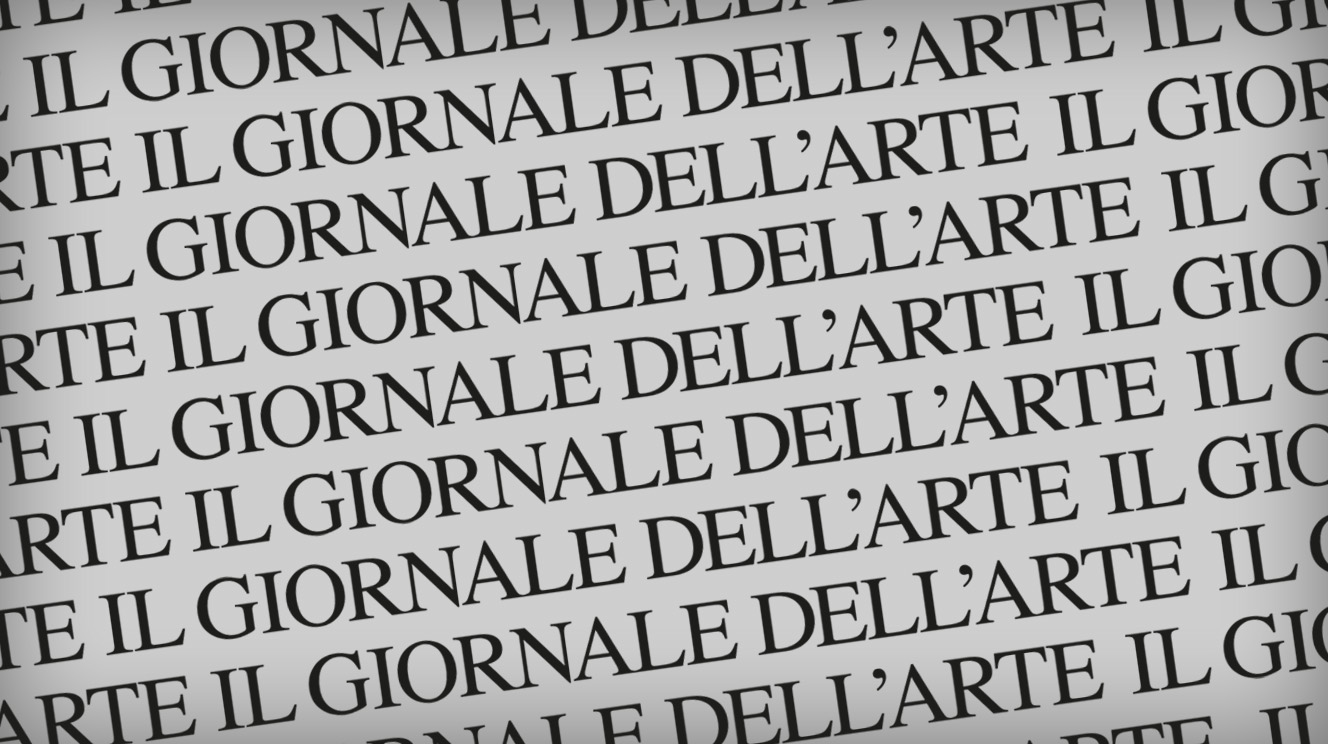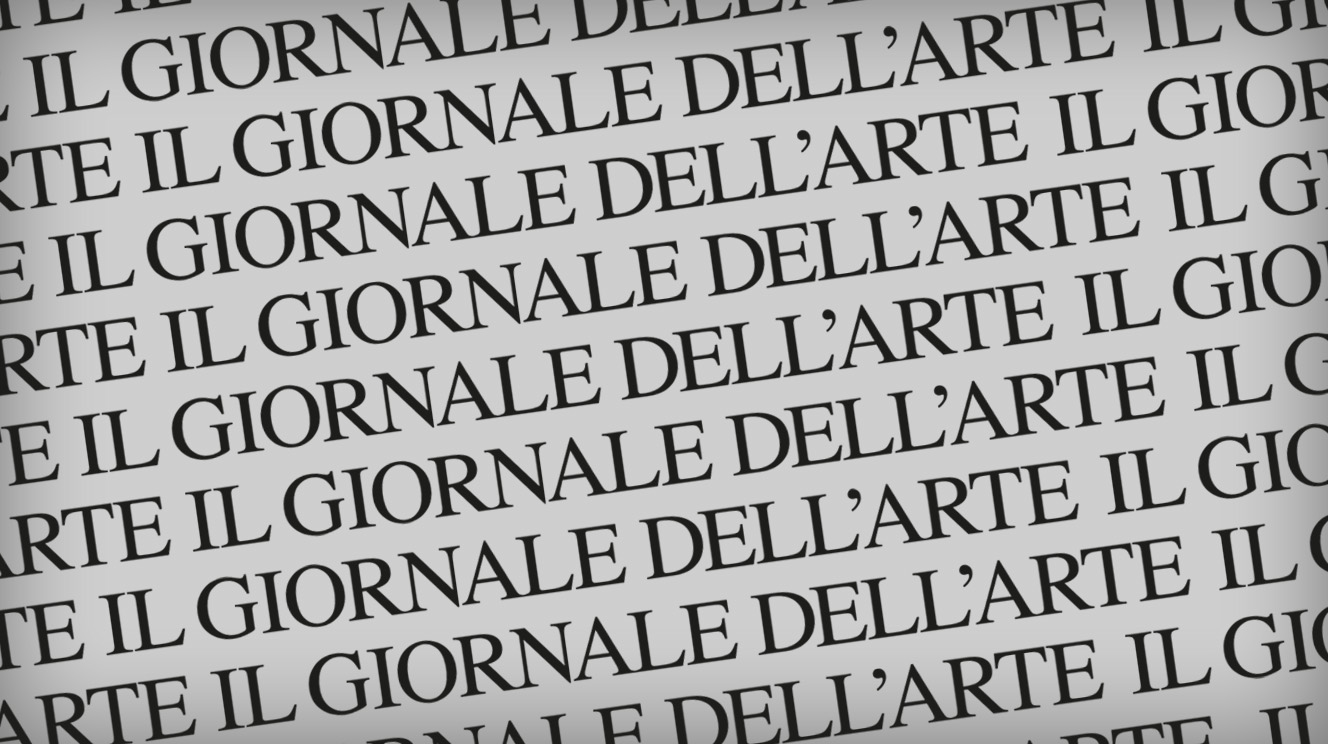Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Bozena Anna Kowalczyk
Leggi i suoi articoliLa scelta di Canaletto per la mostra inaugurale del settecentesco Hôtel de Caumont a Aix-en-Provence, progettato da Robert de Cotte (1656-1735), «architetto del re», sigilla il successo dell’artista veneziano anche in Francia, Paese che l’aveva «snobbato» ai suoi tempi («Les Anglais ont si bien gâté cet ouvrier…», spiega nel 1736 il presidente De Brosses). Per il curatore è stata una sfida, data la sequenza di mostre recenti dedicate all’artista, anche se per lo più limitate alle vedute di Venezia (le ultime due allestite proprio a Parigi nel 2012-13) e un invito a rinnovare e ampliare la ricerca. La mostra «Canaletto. Roma, Londra, Venezia. Il trionfo della luce» (a cura, come il catalogo, di BAK-Bruxelles, Fonds Mercator) in corso fino al 13 settembre, abbraccia l’intero percorso dell’artista, per seguire la sua costante ricerca, sulla luce in primis, la prospettiva, il colore, la percezione, dagli inizi a Roma fino agli ultimi anni a Venezia, e dimostrare la logica dei procedimenti e quella straordinaria intelligenza creativa in cui la maniera intuitiva di alterare la realtà, che Blaise Pascal avrebbe riconosciuto come l’«esprit de finesse», governa la base razionale del suo lavoro di vedutista; e mettere quindi in evidenza il ruolo del capriccio e quello del disegno. I tre capricci «archeologici» esposti, del 1720-23, dominati da un’autentica ammirazione per l’antichità e dalla potente immaginazione di scenografo, sono un nucleo importante per riconsiderare questa prima fase, dalla più arcaica «Veduta ideata con rovine romane» (una vera scoperta e nuova attribuzione), e il già acclamato «L’arco di Settimio Severo», al grande «Capriccio architettonico», già Giovanelli, del 1723. Quest’ultimo dipinto, presentato dopo il recente restauro, ha la qualità e la certezza compositiva di un capolavoro e svela particolari finora nascosti sotto le ridipinture o le vernici alterate: una statua acefala in cima all’architrave dell’arco in primo piano, il fondo a mosaico d’oro del timpano, una matita in mano alla figura seduta sott’arco (Canaletto stesso che prende le misure dei monumenti?). Sotto le ampie pennellate si distingue ora il preciso tracciato delle architetture tirato con il righello, gli archi segnati con diverse misure di compassi; è un procedimento utilizzato nella pratica teatrale che sarà alla base di ogni composizione futura, dipinto o disegno. Il passaggio dalla pittura di teatro e dal capriccio archeologico alla veduta è immediato ma la costruzione dell’immagine di Venezia che l’ha reso celebre in tutta l’Europa («sa manière est claire, gaye, vive, perspective et d’un détail admirable», secondo De Brosses), è invece un processo lungo, di intensa sperimentazione: solo verso il 1730 giunge a un modello preciso, di composizione, luce, tecnica, che sarà seguito da tutto il Vedutismo futuro. È quindi naturale presentare in questa mostra come si evolve in Canaletto il concetto della veduta, dalle composizioni scenografiche delle prime opere («Il Canal Grande verso nord-est dal palazzo Balbi fino al ponte di Rialto» del 1723, già Liechtenstein, ora Ca’ Rezzonico) fino alla controllata nitidezza dei dipinti maturi («Il Canal Grande con l’ingresso a Cannaregio» e «San Pietro di Castello», Londra, National Gallery; due tele del 1736-38 qui per la prima volta attribuite a Canaletto). Diverso il capriccio degli anni Quaranta, elegante e limpido, dalla tecnica sofisticata e matura, ispirato alle idee neopalladiane del Console Smith e di altri mecenati. Con l’esposizione di due soprapporta della serie di tredici commissionati nel 1743-44 da Smith, «Capriccio con il ponte di Rialto secondo il disegno di Palladio» e «San Giorgio Maggiore in un’ambientazione di fantasia» (prestito grazioso di Sua Maestà Regina Elisabetta II che concede sei opere per questa mostra) si affronta lo studio di quest’ultima serie veneziana eseguita prima della partenza a maggio 1746 per Londra; nel capriccio con la chiesa palladiana, mai esposto e giunto al Caumont fresco di restauro, la raffigurazione ravvicinata di un edificio diventa nell’interpretazione di Canaletto testo pittorico di affascinante lettura. Nel capriccio inglese, i colori sono «incipriati» e la luce delicata, con il cielo rosato (Banca Nazionale del Lavoro), come nelle vedute di Londra, del Tamigi («Il ponte di Westminster da nord con la Lord Mayor’s Procession, 29 ottobre 1746», New Haven, Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection) e dei castelli di Alnwick e di Warwick (Collezione Duke of Northumberland e Birmingham Museum and Art Gallery). Cambia l’atmosfera nei tardi paesaggi d’invenzione, per lo più lagunari, di singolare, assorta bellezza, immersi nella luce lunare, dell’alba o crepuscolare (Galleria degli Uffizi; collezione privata). E che dire dei disegni? Tredici capolavori dalle collezioni più importanti del mondo (spicca per la squisita qualità e l’intensa ombreggiatura ad acquarello «San Giacomo di Rialto», del 1755-60, della collezione David Lachenmann) rappresentano varie fasi di elaborazione del motivo e diverse tecniche. Il fulcro della sala dedicata alle vedute inglesi sono due grandi, delicati fogli qui per la prima volta accostati (prestiti eccezionali del Courtauld Institute of Art e dello Yale Center for British Art), vedute complementari del Tamigi, in cui l’uso magistrale dell’acquarello giustifica l’ammirazione dei migliori disegnatori inglesi del XVIII secolo.
Altri articoli dell'autore
Due esempi di cataloghi museali di ultima generazione che vale la pena avere nella propria biblioteca
Il successo della «veduta» ha da subito prodotto imitatori e falsari. Fin dai primi studi era chiara la necessità del corretto riconoscimento e distinzione, ma tuttora sussistono abbagli attributivi. Tanto più gravi quando riguardano opere esposte in musei pubblici
Un percorso labirinto e dubbie attribuzioni rendono ingiustamente il paesaggio veneziano settecentesco un genere minore