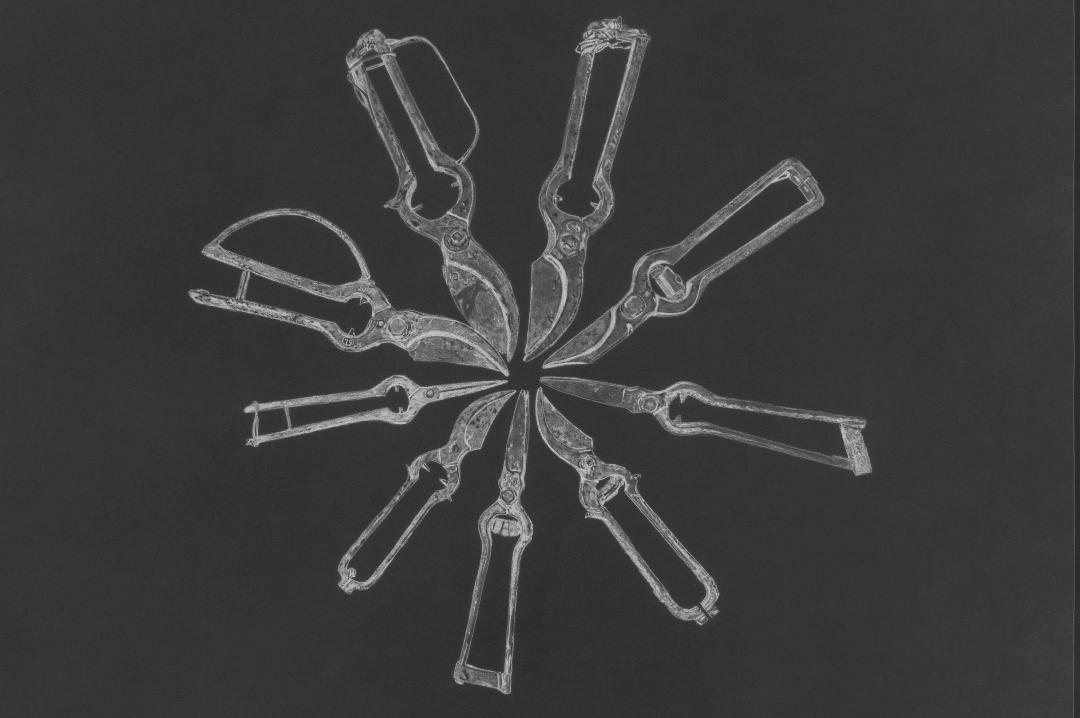Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Nicola Zanella
Leggi i suoi articoliChiara Paolino insegna Organization & Arts Management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, da un decennio svolge ricerche accademiche che definiscono la relazione tra arte e imprese in Italia, e negli anni ha analizzato le conseguenze organizzative e la performance sociale di questo rapporto, fino ad arrivare a studi più recenti nei quali approfondisce come l’arte possa influenzare anche i processi decisionali interni all’azienda, rendendoli, ad esempio, più etici. Le sue parole restituiscono grande complessità al fenomeno dell’arte in azienda e lo nutrono con la forza dei dati.
Quando ha cominciato a fare ricerca sulle tematiche relative ad arte e impresa e da che cosa è nato questo suo interesse?
Ho iniziato a fare ricerca sul tema più di dieci anni fa, nell’ambito di un interesse di ricerca legato ai rapporti tra arte, creatività e management che risale alla mia formazione universitaria. Sono una docente di Organizzazione e Management, mi occupo di come si organizzano attività lavorative, relazioni e spazi. L’arte è sempre stata una chiave personale di studio, di riflessione e di approccio all’altro. Da un punto di vista manageriale, sono ormai molti anni che si è compreso che sia i modelli tradizionali di gestione aziendale sia quelli più «contemporanei», basati sui principi di delega e autonomia, non hanno funzionato egregiamente nel rendere lavoro e relazioni fruttuose, sicure, motivanti. Ho sempre creduto che l’arte potesse dare un contributo significativo, utile a ripensare il modo in cui strutturiamo il nostro lavoro e le relazioni che intessiamo: l’arte consente di proporci nelle diverse situazioni con un’identità più autentica, ricca e varia e ci consente di leggere la stessa complessità nell’altro, sia esso la nostra collega, la responsabile, la persona che dipende da noi nel team, l’azienda cliente o quella a monte dei nostri processi. A livello aziendale più macro questo significa che l’arte crea per le imprese una possibilità molto più ampia del giving back (il dare indietro che implica anche una certa pretesa di superiorità rispetto agli altri attori del sistema economico, politico, culturale). Grazie all’arte, il ruolo sociale dell’impresa, concetto ormai noto, può diventare una dimensione concreta del «costruire insieme» alla società, considerando la varietà di attori che la costituiscono.
A livello di dati quali sono le informazioni più interessanti che ha ricavato?
Io credo che se vogliamo andare al di là di alcuni filoni di ricerca ormai esauriti, i dati più interessanti sono quelli che illustrano la varietà di significati relativi al proprio ruolo, alle proprie responsabilità, agli obiettivi professionali e personali che l’arte e gli artisti possono attivare quando entrano nei contesti aziendali e nel rapporto tra azienda e società. Gli studi più recenti e le ultime osservazioni che ho raccolto illustrano come le opere d’arte in impresa e la presenza degli artisti nelle organizzazioni consentano alle persone di discutere e sviluppare un senso di cura, comprensione e disponibilità verso l’altro, insieme a un maggiore spirito critico e di discussione. Questo genera l’opportunità di mettere a disposizione delle persone più spunti e di saperli collocare nel contesto di lavoro e in quello sociale. L’opportunità che l’arte e la presenza degli artisti diventino un metodo di lavoro per le imprese si è ormai spostata dal tema di produrre una performance tecnica; è andata oltre la classica performance sociale, per diventare una modalità dell’agire imprenditoriale secondo valori estetici (cioè, anche ambientali, sensoriali, equi). Se ben inserita nelle politiche aziendali, l’arte ha illustrato la possibilità di generare trasversalmente a tutte le funzioni occasioni di costruzione di processi decisionali più etici, più ricchi, guidati non solo dalla cognizione, ma anche dalla sensorialità e dalle emozioni delle persone. In termini di rapporti tra imprese, il risultato che ne deriva è un’azione aziendale più credibile, inclusiva, orientata alla trasparenza e alla condivisione.
Quando lei ha iniziato a trattare l’argomento, praticamente non se ne parlava. Come spiega l’esplosione di interesse che c’è stata in seguito?
Nel panorama internazionale, il fallimento di diversi modelli di gestione, insieme all’esplosione della performance sociale dell’impresa, ha certamente favorito un crescente interesse. In Italia credo che questa «fioritura» sia stata anche supportata da una lunga tradizione imprenditoriale di sano e profondo interesse e conoscenza dell’arte e degli artisti. A questo si aggiunge, per quello che ho osservato in più di dieci anni, la presenza nel nostro Paese di artisti e curatori interessati e capaci di costruire una discussione con le imprese, esplorando come queste possano accogliere e influenzare il loro modo di lavorare. Credo che si tratti di un’occasione unica, che spero non si limiti a essere compliant con degli indicatori per l’impresa (anche se si tratta di indicatori nuovi portano sempre il rischio della semplice conformità a uno standard) e che non si fermi, per gli attori del settore dell’arte, alle sole occasioni di mecenatismo: la collaborazione tra arte e management può generare nuovi modi di lavorare e di creare relazioni per tutti gli attori coinvolti, che sono parimenti responsabili.

Festival di danza contemporanea MilanOltre
Come valuta l’evoluzione in questi anni del rapporto tra arte e impresa e in che modo sono cambiati approccio e obiettivi delle aziende?
Adesso l’attenzione si è correttamente spostata sulle aziende come parte di un ampio ecosistema di attori, ed è un fatto molto positivo. Ciò che osservo e ciò che studio mi porta a raccomandare, in ogni caso, che l’arte non diventi semplicemente un altro metodo con cui l’azienda adempie a un dovere nei confronti della società e delle istituzioni. L’arte consente di rivedere le proprie modalità interne ed esterne di praticare la leadership, considerando la complessità delle persone e le relazioni tra le imprese e le istituzioni dell’arte in una prospettiva in cui emozioni, percezioni e valori di solidarietà diventano centrali. Già solo il riferimento alla leadership mostra come la performance sociale possa andare oltre il semplice rispetto di soglie legate a indicatori ambientali, di diversità o altri parametri, diventando più ampia e meglio documentata. Anche il tema dei valori ambientali, grazie all’arte e agli artisti, si sta spostando da una considerazione dell’impatto sull’ambiente, alla considerazione del proprio territorio di riferimento come spazio in cui creare esperienze immersive, cioè come occasione per creare un senso di congiunzione con i propri luoghi, sottolineando al tempo stesso quanto essi contribuiscano a definirci e quanto noi, a nostra volta, li definiamo. Adesso, inoltre, il settore dell’arte si aspetta di entrare in una relazione di maggiore parità e collaborazione con l’azienda privata. È stato certamente già documentato come sponsorizzazioni e finanziamenti siano importanti e utili, ma è fondamentale ricordare che la co-produzione culturale è la chiave di azione più interessante e socialmente più corretta: imprese, musei, associazioni, artisti producono insieme iniziative aziendali e iniziative culturali in un clima di ascolto reciproco e di discussione.
C’è un caso particolarmente interessante su cui si è recentemente focalizzata?
Vorrei menzionare tre casi importanti, molto diversi tra loro, ma che proprio per questo illustrano la vasta potenzialità del rapporto tra arte e impresa. Il primo rientra nella fattispecie del collezionismo corporate, il secondo in quella dell’archeologia e della valorizzazione territoriale e il terzo in quella delle arti performative e del loro profondo valore di metodo di trasformazione sociale.
Cominciamo dal caso in ambito di collezionismo corporate.
Per quanto riguarda il collezionismo corporate, il settore bancario italiano è sempre stato in grado di produrre nuove pratiche e nuove tendenze. Tra queste, segnalo in particolare il progetto di Banca Ifis, che ha dato vita a una significativa iniziativa di promozione culturale che ci illustra come arte, management e società possano integrarsi con successo in occasioni e con modalità diverse, tra loro coordinate. La Banca ha una collezione d’arte a disposizione negli spazi di lavoro e di rappresentanza dell’azienda, ma non solo, ha anche sviluppato un polo museale gratuito aprendo al pubblico il parco della sede centrale di Villa Fürstenberg a Mestre. In questo spazio la variegata natura del Parco si incontra con una trentina di opere d’arte contemporanea di importanti artisti internazionali, offrendo percorsi di approfondimento e sviluppo culturale. Parallelamente, la Banca produce una fitta serie di iniziative di approfondimento e dialogo con le parti sociali per la valorizzazione di luoghi e opere e per la loro condivisione con attori diversi. Tra queste iniziative si possono ricordare il recupero dei busti in gesso del Canova e il salvataggio del murale del Migrant Child di Banksy sulla facciata di Palazzo San Pantalon a Venezia (una delle poche opere dell’artista in Italia) caratterizzato da un tema di grande rilevanza sociale. Quando un progetto si articola in modo così diffuso, si crea l’occasione perché l’estetica diventi per l’azienda una chiave di dialogo quotidiana, una modalità emozionale, sensoriale e artistica distintiva. Progettualità di questo tipo consentono di mostrare l’unicità che l’arte conferisce all’agire d’impresa, in un contesto in cui molte aziende hanno oscillato tra eccessivo conformismo e troppa informalità nell’interpretare le proprie relazioni con la società.

Un’opera di Philip Colbertc a Villa Fürstenberg, Mestre (Ve). © Banca Ifis
Per quanto riguarda invece il dialogo tra arte e territorio?
Per quanto riguarda invece il dialogo tra arte e territorio in modo più stretto, grazie alla collaborazione e al supporto degli stessi archeologi, colleghi, istituzioni museali e attori del territorio, stiamo studiando (insieme alle colleghe Barbara Slavich e Benedetta Lui) lo scavo archeologico di Sasso Pinzuto (Tuscania, VT) dove operano diversi attori fondamentali come il team degli archeologi di CAMNES (Center For Ancient Mediterranean And Near Eastern Studies) e dell’Università Federico II di Napoli. Lo scavo evidenzia la peculiarità di trovarsi sulla proprietà dell’imprenditore Lorenzo Caponetti e convive con la sua azienda agricola. Lo scavo e le relazioni che lo scavo genera offrono l’occasione di comprendere come i ritrovamenti, insieme alle azioni di ricerca e di studio, possano ridefinire i rapporti tra i diversi portatori di interesse, generando tanto tensioni quanto la loro risoluzione. Grazie a una cultura profondamente radicata nel territorio emergono nuovi modi di negoziare e di comprendere l’altro, siano essi studenti, ricercatori, associazioni, turisti, cittadini appassionati o attori istituzionali e aziendali. Se poi si guarda all’attività imprenditoriale in sé, si osserva un’azienda in cui le relazioni con il territorio, attraverso collaborazioni con realtà locali e associazioni, diventano la chiave stessa del suo operare.
E poi citava un terzo caso.
Un progetto che sto portando avanti con il Festival di danza contemporanea MilanOltre a Milano e che apre nuove prospettive ai rapporti tra arte e azienda. Non si tratta, in questo caso, di una semplice collaborazione tra attori aziendali e culturali tout court, ma di un’integrazione tra saperi artistici e manageriali, finalizzata a valorizzare la danza contemporanea come strumento di comprensione reciproca e di apertura all’unicità dell’altro. Ormai da tre anni, con il Festival, organizziamo workshop di co-produzione culturale gratuiti e aperti a tutti, guidati da artisti, coreografi e dallo staff, in cui principi di management, di gestione e valorizzazione delle diversità si uniscono alla storia e alla pratica della danza contemporanea. Grazie a questi workshop, per tutti noi diventa possibile osservare come la danza contemporanea e lo spazio del Festival (dentro e fuori il teatro) rappresentino una metodologia straordinaria per ripensare significati e azioni legati al contrasto della marginalizzazione nel tessuto cittadino.
Perché un’azienda deve investire in arte?
Credo che i tre esempi che ho appena illustrato possano riassumere efficacemente almeno tre ragioni. Per l’azienda si tratta di un’occasione di distinguersi, dando vita a relazioni costruttive con una pluralità di attori, rafforzando la propria visibilità secondo valori positivi di vicinanza, collaborazione e sviluppo di tutti. L’investimento in arte promuove pratiche di dialogo e discussione in grado di arricchire le prassi, le idee, i significati a disposizione di tutti gli attori di un territorio e di un paesaggio: le aziende, le università, le associazioni. Arte e impresa insieme danno vita a una commistione di saperi: l’integrazione tra management e arte diventa strumento per valorizzare l’unicità e ridefinire i concetti di inclusione ed esclusione.

Un’opera di Davide Rivalta a Villa Fürstenberg, Mestre (Ve). © Banca Ifis
Altri articoli dell'autore
Andrea Martinucci firma nello stabilimento di Calenzano il secondo capitolo di «Produrre Futuro», il progetto di Aidaf per portare l’arte nelle aziende. Il racconto di Marina Nissim
Tosetti Value, uno dei più importanti Family Office europei, rivoluziona il rapporto tra economia e creatività. Con una collezione corporate dinamica, il progetto Prospettive e il premio fotografico ad Artissima, sostiene gli artisti e trasforma gli spazi aziendali in un hub di cultura e ricerca, alimentando un dialogo innovativo tra arte e strategia
Tra vigneti e visioni contemporanee, la tenuta San Leonardo affida la sua etichetta d’artista 2020 a Linda Fregni Nagler. Un progetto che unisce arte e vino nel segno della memoria, raccontato dai proprietari Anselmo Guerrieri Gonzaga e Ilaria Tronchetti
Decimo excursus tra le collezioni corporate italiane di arte moderna e contemporanea studiate e mappate nel nuovo libro e progetto voluto da Confindustria con il patrocinio del MiC