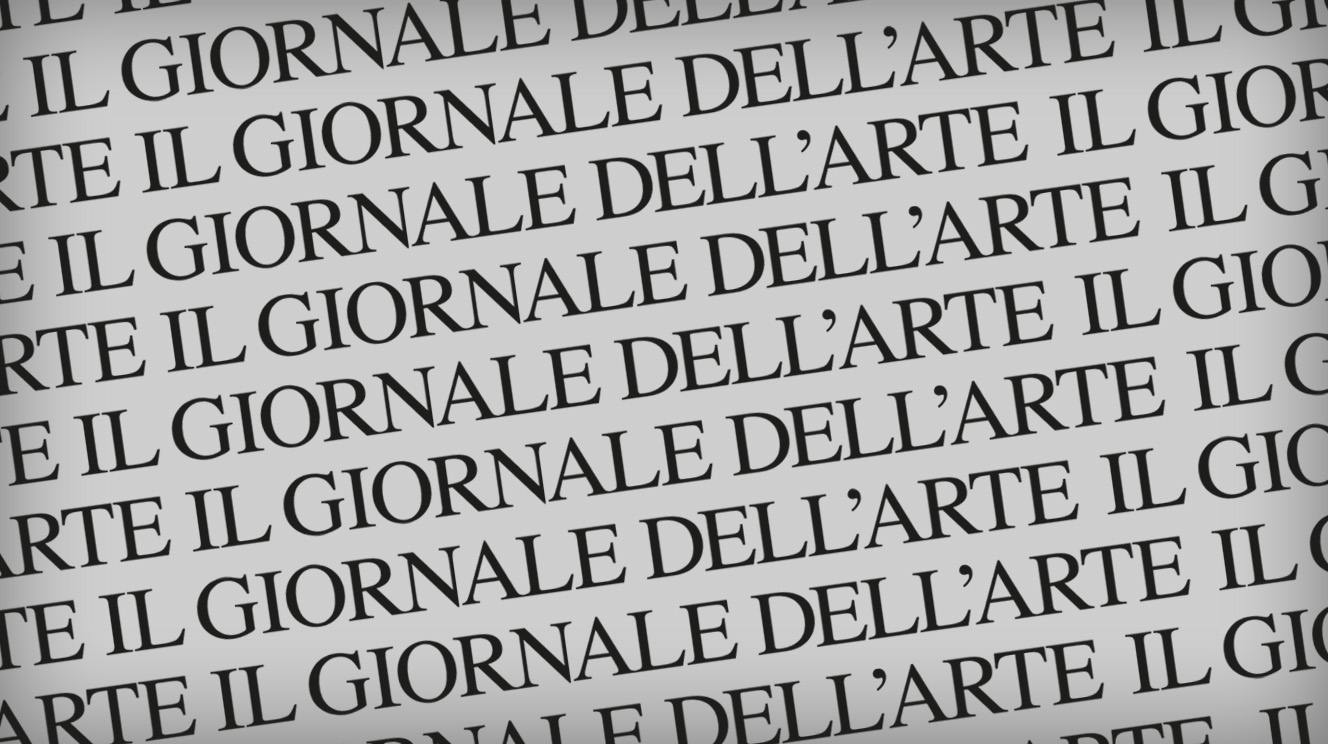Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Giovanna Barni
Leggi i suoi articoliIn questi mesi, rappresentando anche il sistema della cooperazione culturale, oltre a Coopculture, ho avuto una visione completa dell’impatto della crisi. Durante il primo lockdown, i luoghi della cultura sono stati chiusi, poi riaperti ma con estreme limitazioni di flussi e attività e, infine, chiusi di nuovo. La risposta del governo è stata pronta ma parziale: nei ristori ha prevalso l’attenzione sui beni, sui luoghi e sugli eventi, rispetto a quella sulle organizzazioni e sulle persone che ne permettono il funzionamento, ne assistono e arricchiscono la fruizione, anche favorendo l’accessibilità a tanti pubblici diversi.
Per ora non è stato riservato alcun ristoro diretto e nessuna misura specifica di fronte a un crollo di introiti di biglietteria e di tutte le attività: dalle visite guidate ai laboratori didattici, dalle audio e videoguide alle iniziative speciali (aperture serali, passeggiate archeologiche ecc.). E questo nonostante il valore non solo economico ma anche sociale di questi servizi, l’importanza di una accoglienza differenziata, di qualità e arricchente per tanti utenti, spesso provenienti da ogni parte del mondo e una capacità di governare le visite che, anche in questi mesi di estrema attenzione alla sicurezza dei visitatori e dei lavoratori, si è rivelata indispensabile.
È questa la nebbia in cui è finita Coopculture: 2mila lavoratori professionisti, a maggioranza donne e laureati, un’esperienza trentennale di gestione di luoghi noti e meno noti del nostro Paese, dal Colosseo, alla Valle dei Templi, all’Orto Botanico di Palermo, alle Sinagoghe del Ghetto di Venezia, solo per citarne alcuni; una cultura di impresa e un’attenzione al lavoro di qualità, che ha ottenuto riconoscimenti anche in queste settimane, come il premio Industria Felix de «Il Sole 24 Ore» e la classifica sulle imprese per migliori posti di lavoro del «Corriere economia».
Tutto questo nulla ha potuto di fronte alla crisi: che sta vedendo una riduzione di oltre il 50% del nostro fatturato e migliaia di lavoratori in cassa integrazione, con enormi ritardi di pagamento da parte dell’Inps. E, a fronte di questo, le risorse destinate a compensare le istituzioni rispetto alle perdite degli introiti dei musei (165 ml per i musei statali e 70 ml per quelli non statali) non sono state ancora reindirizzate, neppure per la parte di spettanza, ai gestori che ne assicurano il funzionamento.
Ma ci auguriamo che su questo possa esserci un ripensamento, ed è un primo segnale che nostri codici Ateco siano stati inseriti nell’elenco dei settori più colpiti nell’ultimo decreto legge Ristori Bis. Tutto questo pesa: non solo per il presente ma, soprattutto, per il futuro. Dobbiamo dircelo, il 2021 sarà ancora più difficile e forse quello in cui, soprattutto nelle grandi città d’arte e a Roma innanzitutto, si rischia la dispersione di un capitale umano indispensabile per la crescita e per il futuro del Paese.
E questo rende ancora più urgente avviare una vero e proprio piano per l’impresa culturale e creativa, unitaria seppure multidisciplinare, multidimensionale e in tante forme societarie diverse, tra cui la cooperazione eccelle: una filiera indispensabile al Paese da salvare ma anche da sviluppare, soprattutto al Sud, con interventi tanto finanziari quanto fiscali, tanto di incentivi quanto di una politica attiva del lavoro.
Pochi giorni fa l’Unesco ha detto che la cultura è «bisogno vitale in tempo di crisi, una fonte di resilienza»: eppure viene spesso trattata come settore da sussidiare e non come risorsa a cui attingere in un momento critico per il Paese. Tanto più in un Paese come l’Italia, in cui le attività culturali e creative possono essere leva di rilancio e sviluppo economico e, insieme, elementi decisivi per superare quel gap educativo e digitale che la crisi pandemica ha reso evidente a tutti. E più urgente da sanare.