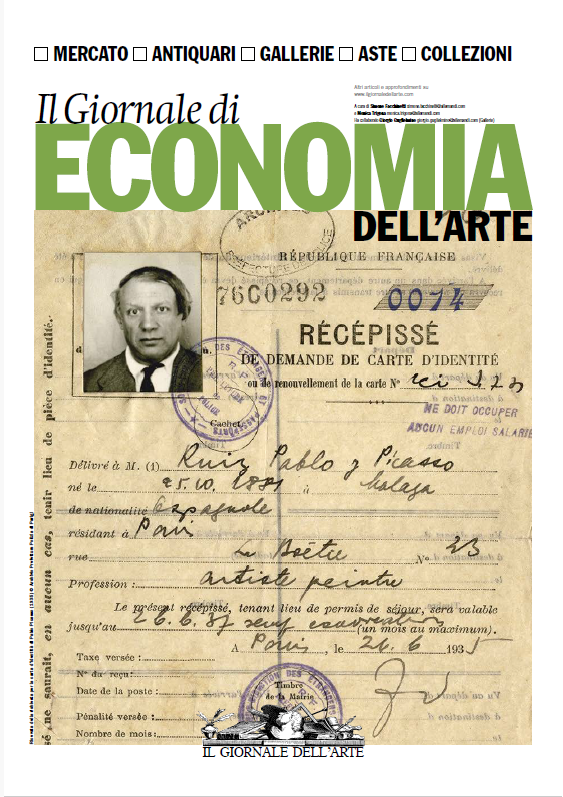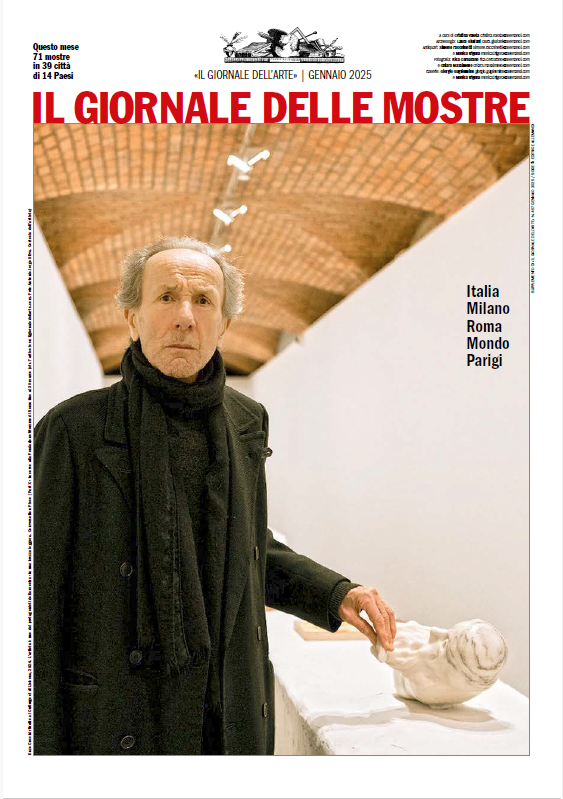«La città fantastica» è il frutto della creatività di un padre che, certo, un padre normale non fu, ma che ha lasciato una straordinaria eredità al mondo dell’arte contemporanea e al figlio Paolo, che oggi ne racconta la storia. «La città fantastica» è anche il titolo della mostra personale che Atipografia, galleria e associazione culturale nel centro di Arzignano, in provincia di Vicenza, dedica alle opere di Piero Fogliati, in collaborazione con l’Archivio Fogliati, fino al 14 settembre.
Nato a Canelli, in provincia di Asti, nel 1930 e morto a Torino nel 2016, Fogliati si era dedicato a partire dai primi anni Sessanta a un ambizioso progetto urbanistico dove ciascuna sua opera riproduceva un’esperienza sensoriale unica, in risposta alla progressiva e aggressiva urbanizzazione, intuendone, con lucidità e in anticipo sui tempi, il forte impatto sull’ambiente e sul paesaggio.
«Pur percependo i problemi legati alla tecnologia che avanzava, spiega il figlio Paolo, aveva piena fiducia che la tecnologia stessa potesse risolvere questi problemi». E anzi attraverso le sue opere, i cui disegni progettuali sono esposti in mostra, proponeva un mondo utopistico che interagiva con l’elemento naturale, realizzato attraverso macchine visionarie e futuristiche, costruite pezzo per pezzo, in ogni singolo elemento, con le sue mani, nel suo straordinario laboratorio. Con l’obiettivo di produrre ascolto (per esempio in «Anemofono» del 1968, esposto alla Biennale di Venezia del 1978) e scolpire la luce, nascono opere come «Reale virtuale» (1993) che gioca con il riflesso luminoso sulle pareti di un’ampolla di vetro per generare forme immateriali, «Luce solida» (1971) o «Prisma meccanico» (1992), che utilizza degli schermi ruotanti per raccogliere e scomporre i raggi luminosi, «Rivelatore cromocinetico» (1984) che crea un’aura colorata grazie alle vibrazioni di una corda su cui la luce riflette e «Euritmia evoluente» (1970), dove un anello arancione sospeso si muove come fosse dotato di vita propria.