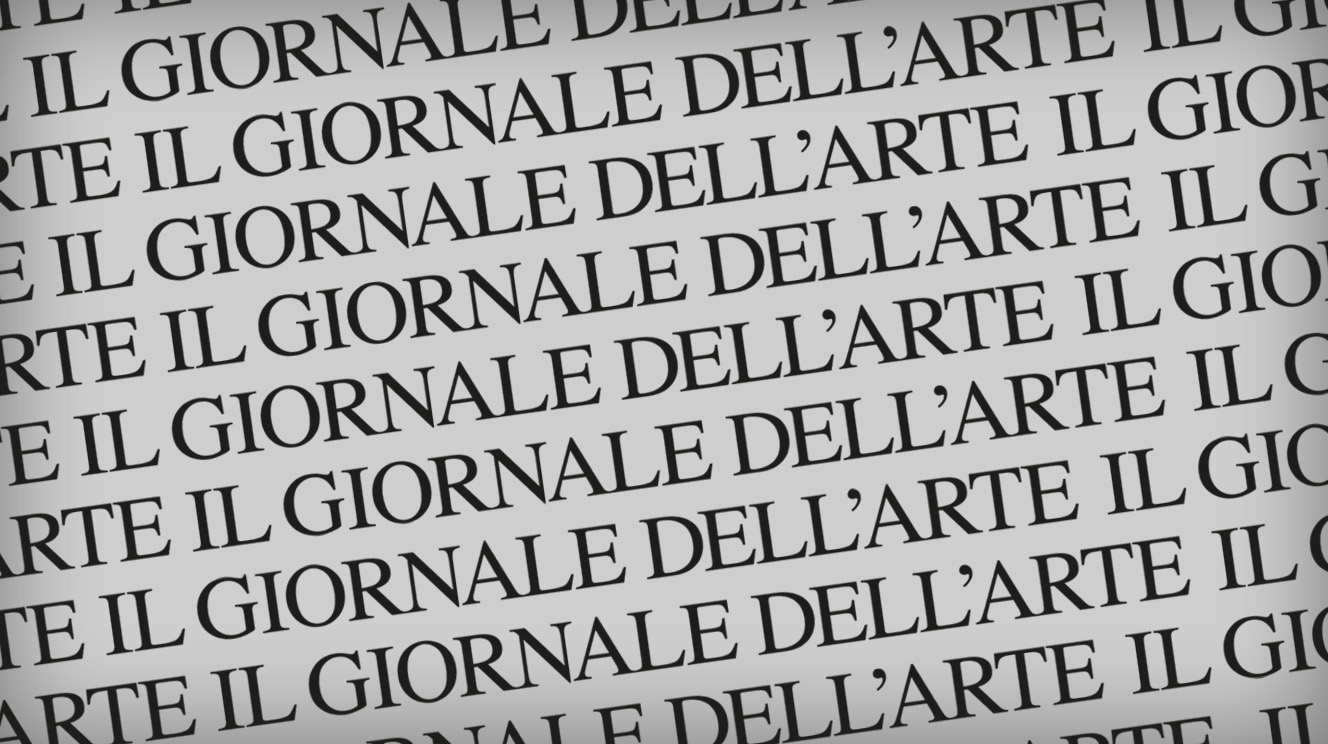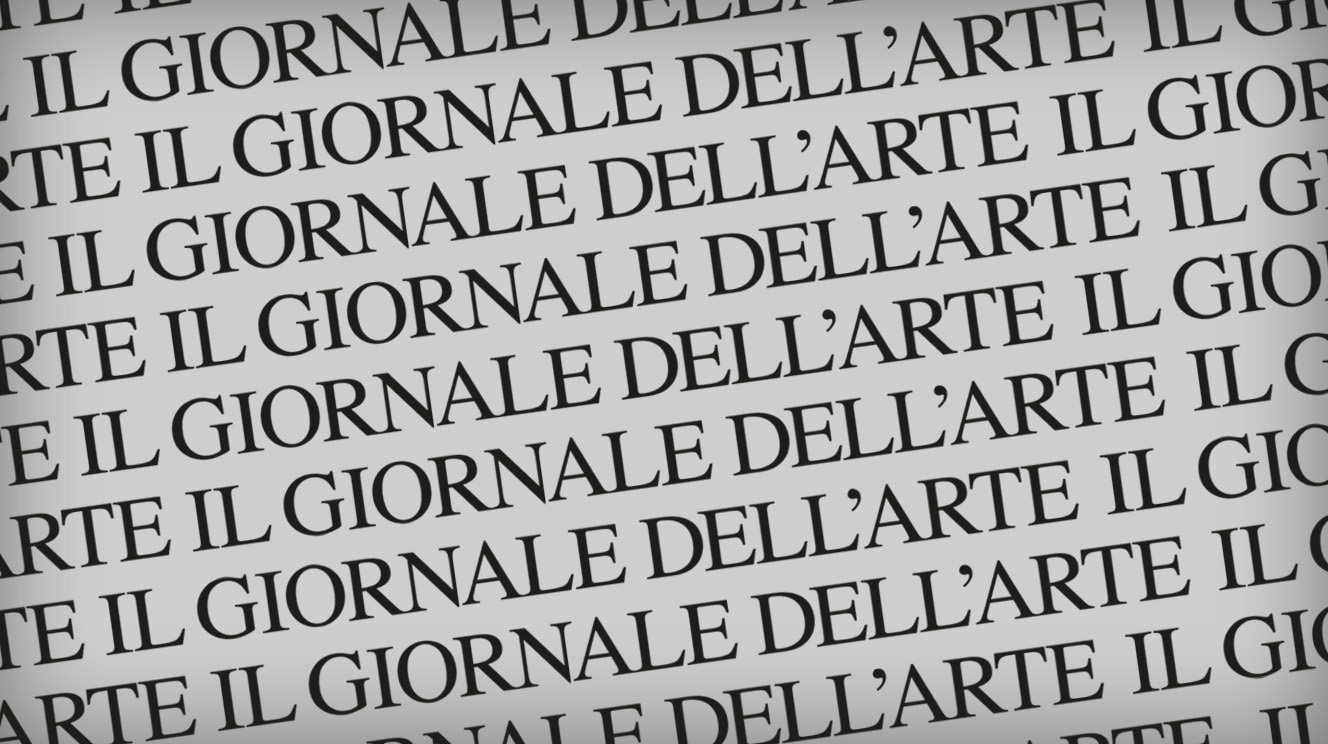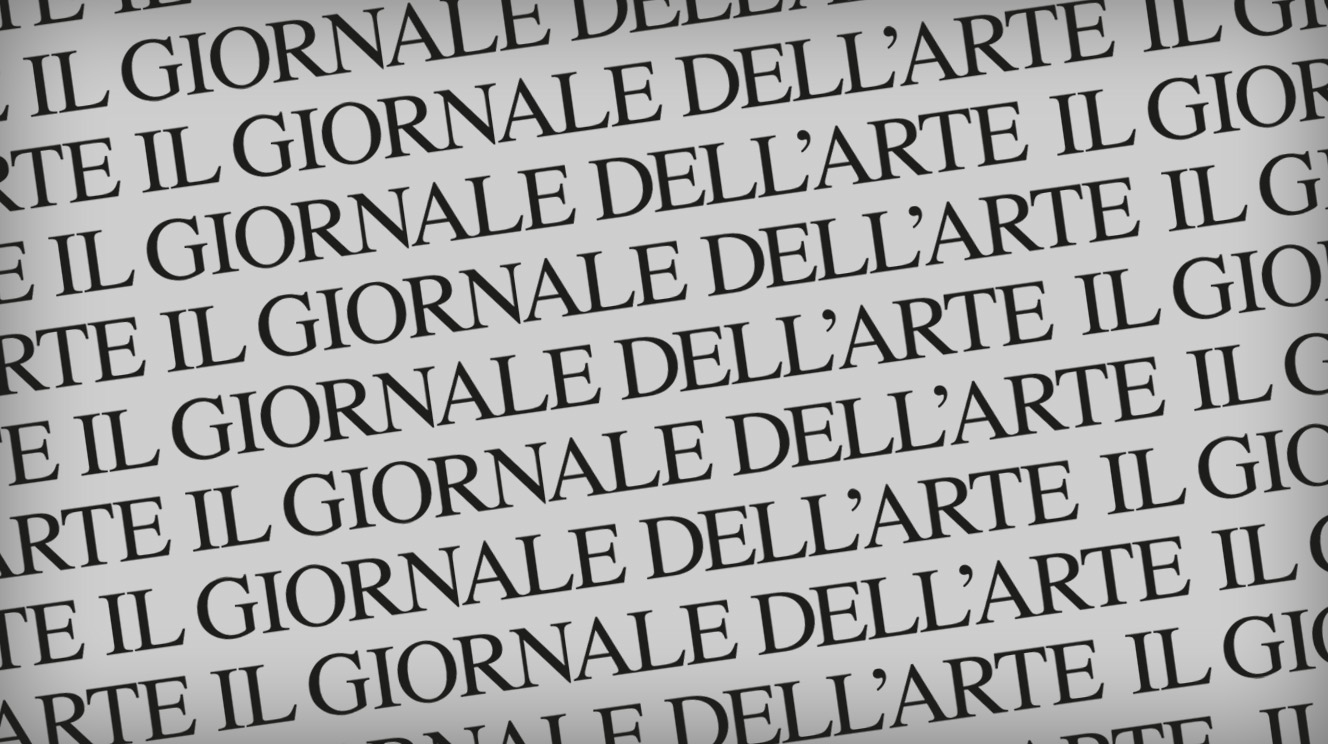Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Massimo Montella
Leggi i suoi articoliLa discussione seguita all’assemblea sindacale che ha impedito per ore l’accesso al Colosseo (cfr. articolo p. 1) è rimasta circoscritta al diritto di sciopero e alla opportunità del decreto adottato dal Governo. I più hanno censurato l’episodio e apprezzato la risposta del Governo. Qualcuno si è spericolato a sostenere che si è trattato del normale esercizio di un diritto incomprimibile e ha dunque sentenziato che non è stato bene includere la fruizione dei beni culturali fra i servizi pubblici essenziali. Magari avrebbe potuto accorgersi che questa decisione può dare inizio a più ampi sviluppi positivi, così come il fatto che il decreto provi a incidere sull’intero panorama museale, anche non statale. Semmai, premesso che il provvedimento del Governo è un giusto rimedio d’urgenza, è da notare che questo tampone non può essere la soluzione adeguata alla reale natura del problema. Ma non perché, come pure si è detto, bisognerebbe piuttosto aumentare la spesa pubblica per i beni culturali e il personale.
Aumentare la spesa è necessario, ma non per essere amministrata come adesso. A voler affrontare, come doveroso, il tema della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale esteso all’intero paesaggio italiano (di cui i musei, per quanto importanti, sono la parte minima e meno rilevante sia sotto il profilo culturale che per la qualità di vita delle persone e per gli aspetti economici), bisognerebbe cominciare da una normativa tecnica che obblighi ad adeguare a tali fini le scelte di governo del territorio e bisognerebbe costituire quegli organismi tecnici territoriali per la conservazione preventiva dei beni proposti mezzo secolo fa dall’allora direttore dell’Istituto Centrale del Restauro Giovanni Urbani.
Anche aumentare il personale è necessario, ma non purché sia. Il problema, prima ancora di quantità, è di qualità. Per limitarsi al tema, per se stesso rilevante, della gestione dei servizi di apertura, di accoglienza e di vigilanza dei luoghi di visita, occorre considerare che il personale ha un peso decisivo per la soddisfazione dei visitatori e per l’immagine che si dà del Paese. L’aspetto, il gesto, la parola sono determinanti. Perlopiù accade, invece, che, per la carenza di avvertite politiche pubbliche e per le demagogiche negoziazioni sindacali, gli addetti manchino di formazione specifica, non indossino una divisa che li renda immediatamente riconoscibili e che manifesti la dignità dell’istituzione e l’orgoglio di appartenervi, non parlino lingue straniere. Per di più, data la natura dei loro rapporti di lavoro, non hanno un concreto interesse all’incremento del numero e della soddisfazione degli utenti. La loro attività è burocraticamente regolata da mansionari che sembrano fatti apposta per limitarne la disponibilità e l’iniziativa.
Converrebbe dunque chiedersi se lo Stato debba gestire direttamente l’erogazione di questi servizi anziché governarla e se non farebbe meglio ad avvalersi di società private, magari cooperative, cui affidare gruppi di musei comprendenti i più e i meno frequentati e con le quali stipulare contratti che, da un lato, ne incentivino l’azione, cointeressandole economicamente al miglioramento dei risultati e spingendole così a promuovere anche i siti meno noti, e, dall’altro, assicurino la qualità delle prestazioni, imponendo l’impiego di personale in possesso di specifiche abilità professionali prefissate da una apposita normativa, che, come già previsto dalla legge, ma fin qui inutilmente, dovrebbe essere obbligatoriamente osservata tanto dall’amministrazione centrale dello Stato quanto dagli enti territoriali. Almeno per questi aspetti il temuto «ingresso del mercato» nel mondo della cultura, previe rigorose regole dello Stato, non dovrebbe urtare nessuno.