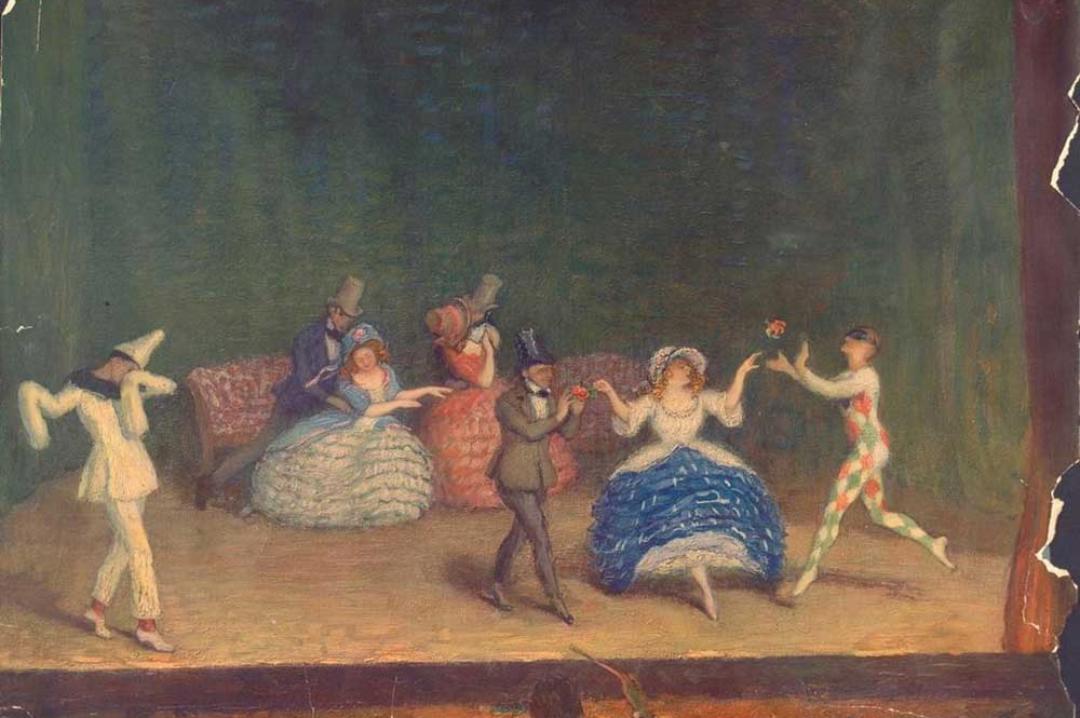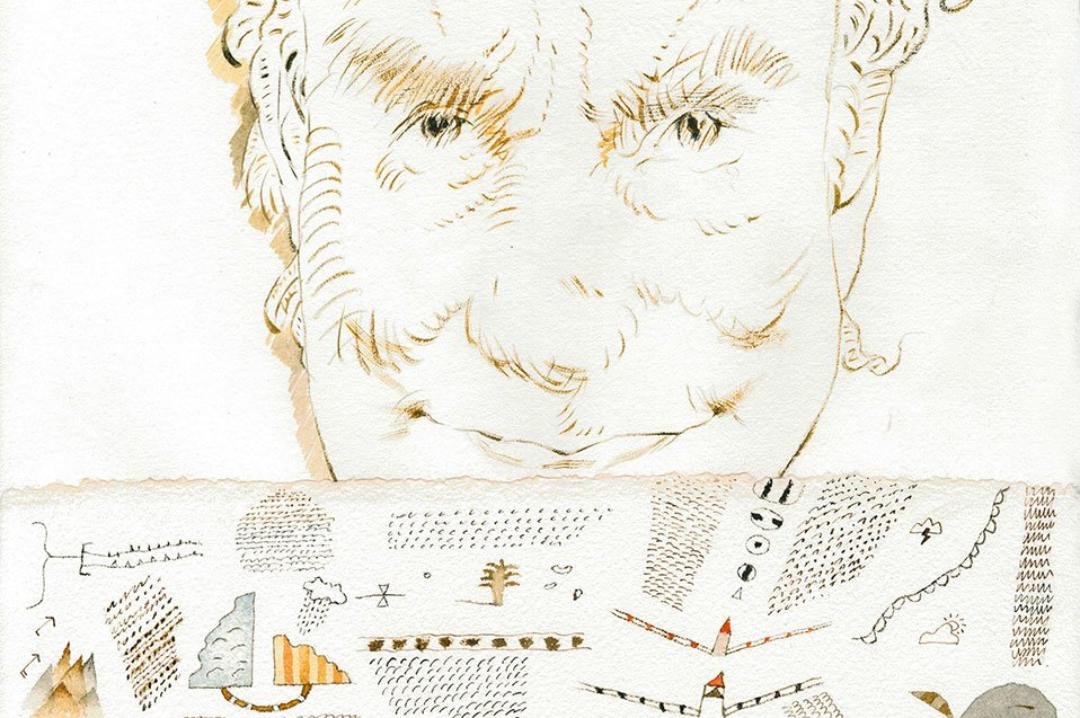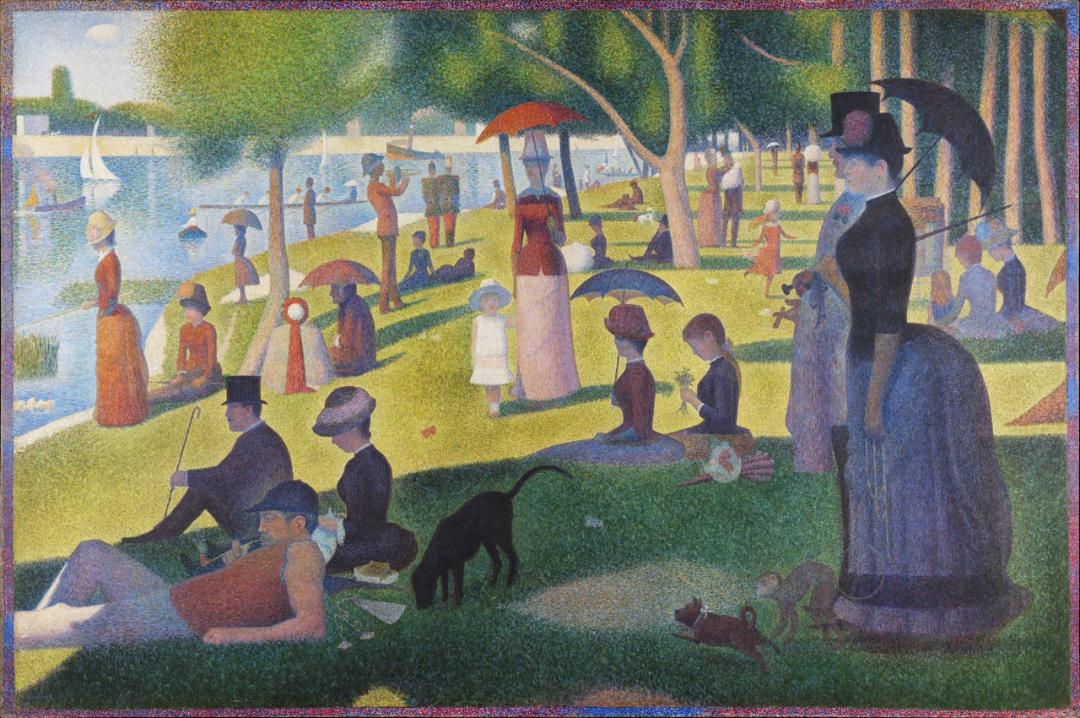Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Causa
Leggi i suoi articoliPostumo Beatrice? Non scherziamo. «Postumo» è la prima parola da scansare per definire il pamphlet di questo critico e storico d’arte torinese scomparso nel gennaio scorso, senza preavviso, a poco più di sessant’anni. Altri aggettivi da inanellare? Vivo. Sulfureo. Incazzoso. Lucidamente pacato. Contemporaneo e inattuale. Curioso. Scorretto e politicamente incorreggibile. Fuori dal coro e poco allineato. Naturalmente seduttivo. Tutto a lettere grandi, come ci ritorna Beatrice e come lo tramandano i compagni di strada. Maiuscolo lui per primo nel divorare vita e consumare passioni, quadri, installazioni, mostre, affetti, film, biennali e quadriennali, Diabolik e Andy Warhol, il Vesuvio e la Mole Antonelliana, Marinetti, futurismo, Renato Zero, Lucio Dalla e la Juve.
Questo e tanto altro rimbalza da centocinquanta pagine che sembrano, nel tono colloquiale, l’esito di un dopocena a microfoni spenti e sigari accesi. «Per essere veramente contemporanei bisogna essere leggermente inattuali»: così sentenzia Nietzsche che, in Beatrice, avrebbe riconosciuto il commensale giusto.
Per questo volume, che di tutto odora tranne che di commiato, il titolo è orientativo o, come si diceva un tempo, redazionale. Siamo dinanzi a un saggio sul metodo e sul mestiere dello storico d’arte nelle sue nuove diramazioni e declinazioni. Si parla di curatori, organizzatori, direttori di musei, registrar. Beatrice nuota al largo, veloce, sicuro, impegnandosi in una delle prime disamine su come sia cambiato il nostro modo di affrontare le immagini e ragionarne, da quando, nel 2009, furono montate le prime telecamere sugli smartphone. A mancare all’appello, però, sono proprio i testi di prima mano, le opere d’arte, ricacciate in penombra da slogan, programmi, infinite password (resilienza, inclusività, fluidità, zona di conforto e altre parole atte a sfiorare le cose senza toccarle e intorno a cui costruire mostre panoramiche dove, più che l’oggetto conta la notizia). «L’arte di oggi non buca, non sforna capolavori». Esonda invece, come tutti sappiamo atteso che ne siamo artefici e vittime, un flusso di opinioni irrilevanti. Spezzoni di pensieri, cultura liofilizzata, ridotta di dimensioni senza connotarsi della forza squassante di un aforisma. «Bullshit» come avrebbero detto Pollock e compagnia newyorkese su cui Beatrice organizzò una mostra al Vittoriano sei anni fa. Non contano le opere ma i discorsi sulle opere rimbalzanti senza più un centro, tra riviste, social media, vecchi e nuovi mezzi di informazione. Di solito, puttanate.
Ma se è vero che «la centralità dell’opera si è persa» sotto l’impero della comunicazione, non si poteva che cominciare dalla banana appesa al muro con lo scotch dal padovano Cattelan e che non si può considerare arte alla stregua dei Caravaggio allineati ora in Palazzo Barberini. Ma allora? Caravaggio lo analizzi secondo criteri variabili definibili in una catena di connessioni più o meno ampia. Alcune garantite. Giotto, Masaccio, Lippi. Raffaello, Caravaggio, Courbet. O Velázquez, Manet, Picasso. Oppure ancora Cezanne, Braque, Morandi, Luigi Ghirri e Michelangelo Antonioni. È un gioco di cui conosciamo a memoria le regole dove si misurano sensibilità e occhio. Ma la banana? Se «l’arte obbedisce a regole estetiche che non possono prescindere dagli esiti formali», la banana non rimanda che a sé stessa o, volendo, alla «Chiquita 10 e lode» inventata nel 1965 da un mago della comunicazione, vero maestro putativo di Cattelan, come Pirella. La banana è il segmento di un discorso infinito, ultra monetizzabile che ripaga dei 6 milioni di dollari spesi per portarsela a casa. Non conta la banana ma i fiumi di parole della sfortunata canzone dei Jalisse. D’altronde la banana esiste fin quando, come nei diritti di chi l’ha comprata, non ci si decida a scocciarla (ovvero liberata dallo scotch), sbucciarla e mangiarla. Come è puntualmente avvenuto.
La commedia dell’arte. Dietro le quinte del contemporaneo. Tra museo, mercato e provocazioni
di Luca Beatrice, 160 pp., Marsilio, Venezia 2025, € 16
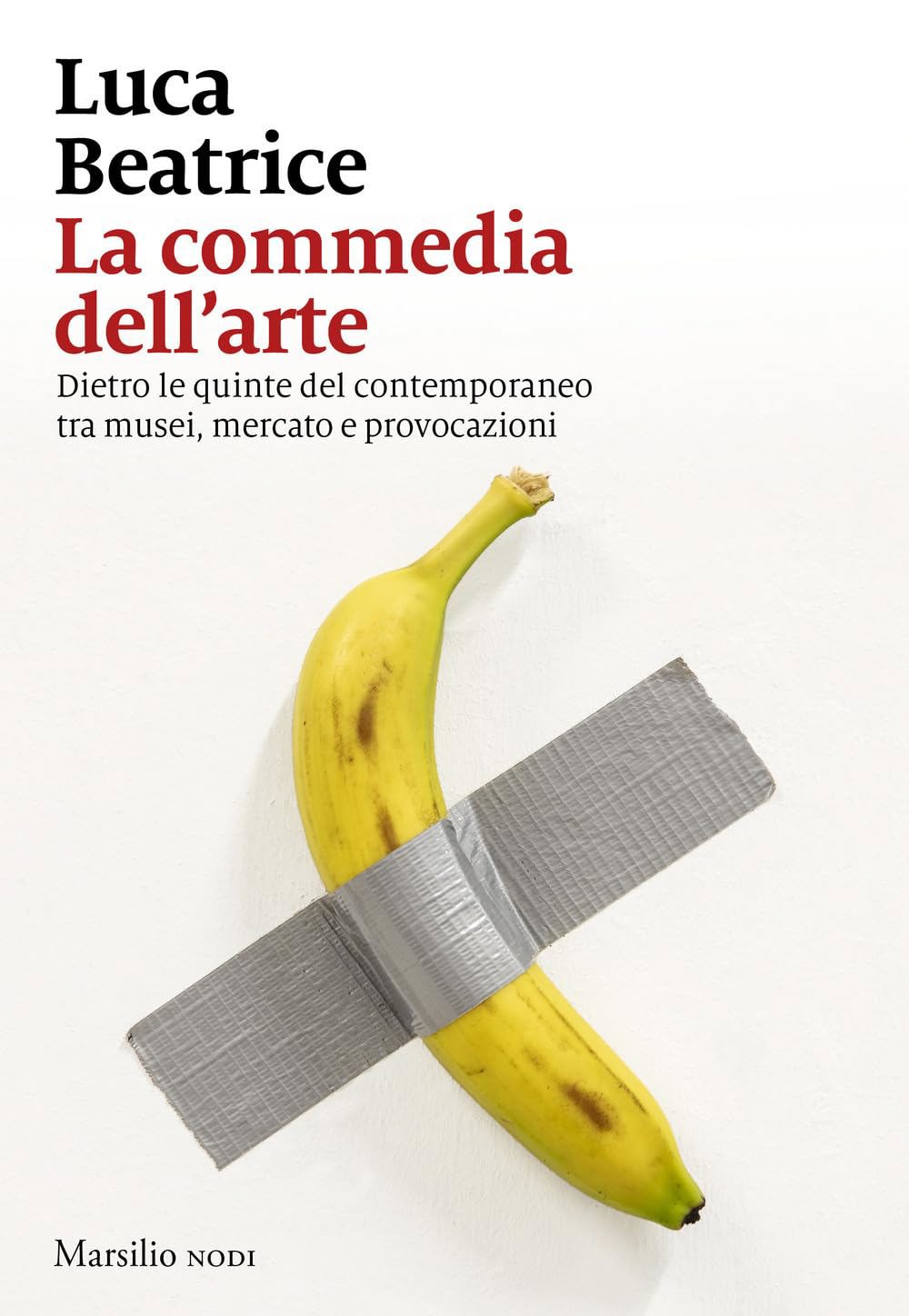
La copertina del volume
Altri articoli dell'autore
Un interrogativo intorno a una musica che dal 1835 per sua natura vive di maschere e sdoppiamenti
Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte
Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure
Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso