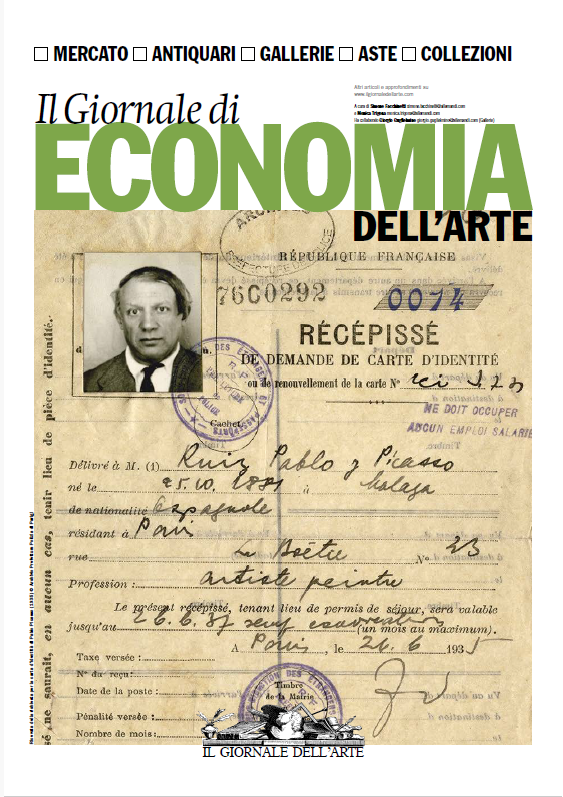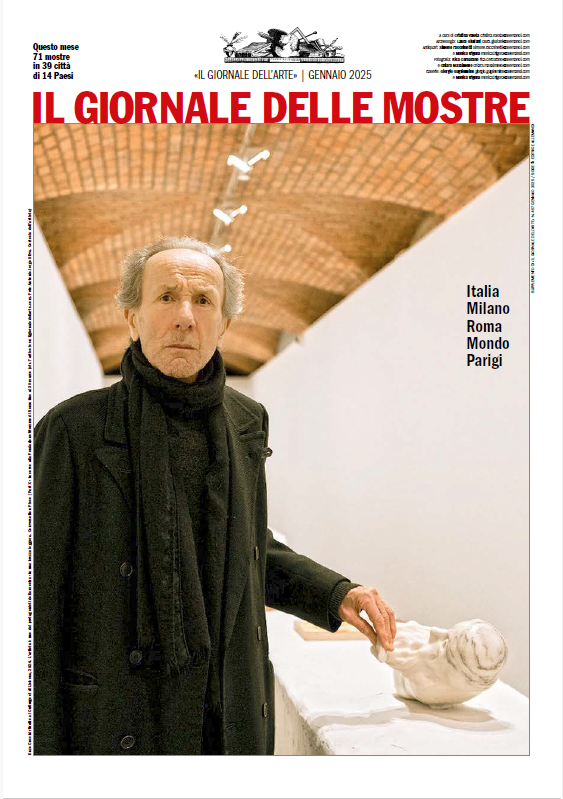«Di fatto il duca Ferdinando passava come minimo tre ore e mezzo al giorno in chiesa e circa otto ore a lavorare agli affari di Stato. Spesso lavorava anche alla domenica. Quando però vi erano problemi rilevanti all’interno del ducato era il governante a prendere il sopravvento sull’oblato domenicano e allora Ferdinando diradava le sue visite ecclesiali. Due volte alla settimana faceva conferenze con i suoi ministri recandosi a Parma oppure facendoli venire a Colorno. Essendo gli uffici governativi tutti a Parma vi era sempre un viavai di staffette a cavallo o con carrozze sulla strada Colorno-Parma». Lo scrive Mario Zannoni ne La «Guerra» tra Napoleone Buonaparte e Don Ferdinando di Borbone. La battaglia di Fombio, 8 maggio 1796 (Parma 2010). Ferdinando I di Borbone (Parma 1751-1802), figlio del duca Filippo e di Luisa Elisabetta di Francia, forse il principale regnante della storia ducale parmense, dunque, si divideva presso la Reggia di Colorno tra devozione, affari statali e attenzione alle belle arti.
La Reggia di Colorno analizza il complesso personaggio attraverso la mostra «Ferdinando di Borbone Parma. Tra arte e devozione», visibile fino al 28 luglio e curata dallo storico dell’arte Giovanni Godi e dalla ricercatrice Antonella Balestrazzi, membro del gruppo di lavoro del progetto di valorizzazione culturale della reggia.
L’appuntamento si inserisce nel filone di studio dedicato alle collezioni ducali disperse dopo l’Unità d’Italia e presenta un’amplissima documentazione iconografica, storica e religiosa che permette di comprendere questa figura storica mettendone in luce un’immagine nuova e diversa, liberata dai pregiudizi sulla sua eccessiva devozione religiosa, più incentrata sulla sua curiositas d’intellettuale, oltre che sull’importanza del suo ruolo come collezionista e protettore delle arti e degli artisti.
Da ricordare per esempio che nel 1768 il Borbone, duca di Parma, Piacenza e Guastalla tra il 1765 e il 1802, durante i primi anni della reggenza, con il primo ministro francese Guillaume du Tillot (1711-74) in quanto minorenne, chiamò alla Stamperia Reale il principale tipografo, stampatore e incisore piemontese Giambattista Bodoni (1740-1813), che si fermerà a Parma per il resto della vita alloggiando nel Palazzo della Pilotta, dove allestì la stamperia e dove ora c’è il museo a lui dedicato. La rassegna analizza varie sfaccettature del regnante, a partire dalla corposa sezione iconografica nella quale si evidenzia la sua figura e quella dei familiari con incisioni e ritratti, come quello di Anonimo col giovane duca a cavallo, manifesto della mostra.
A ricordare la devozione di Ferdinando invece «La Beata Orsolina De Veneri che rimprovera il Papa» di Benigno Bossi e la «Sant’Anna insegna a leggere a Maria Vergine» di Pietro Melchiorre Ferrari. Il percorso mostra poi i progetti da lui seguiti in quegli anni, tra cui la Chiesa di San Liborio, con esecuzioni di Turbini, Cossetti e Petitot e alcuni disegni di tema religioso, come l’inedito bozzetto della «Madonna con Bambino e santi Stefano e Lorenzo» di Domenico Muzzi che affianca la tela omonima. Ampio spazio è dedicato all’architetto nume tutelare a Parma in quel periodo, il francese Ennemond-Alexandre Petitot (Lione, 1727-Parma, 1801), che il Borbone utilizzò con parsimonia, preferendo alcuni allievi per esempio per San Liborio, il convento dei Domenicani e il nuovo appartamento privato con specola astronomica.
Molto estesa è la sezione sui documenti e libri pubblicati durante il suo governo: diari, raccolte di rime, preghiere, calendari, vite di santi. Esposti infine numerosi apparati celebrativi e oggetti per le funzioni religiose, tra cui preziosi reliquiari che testimoniano come la fede fu per lui stimolo alla ricerca culturale e artistica. «Ferdinando, chiosano gli organizzatori di Antea Progetti e Servizi per la Cultura e il Turismo, fu coraggiosamente controcorrente e moderno, perché risoluto sostenitore di una cultura capace di conciliare arte, religione e scienza, di unire morale ed estetica.
In questo fu illuminato senza essere illuminista e religioso senza essere bigotto, come forse ingiustamente e riduttivamente lo si è in altre occasioni definito».

Due reliquiari architettonici, artigianato parmense del XVIII secolo, Reggia di Colorno, Chiesa di San Liborio