
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Arabella Cifani
Leggi i suoi articoliIl 26 luglio del 1581 all’Aia, le sette Provincie Unite che costituivano i Paesi Bassi (Gheldria, Olanda, Zelanda, Utrecht, Frisia, Overijssel e Groninga) dichiararono di non riconoscere più l’autorità di Filippo II di Spagna, despota e tiranno. La sollevazione di quei territori contro il dominio spagnolo fu una delle prime grandi rivolte dell’era moderna, una rivolta sociale, religiosa, politica e culturale. Ci voleva un bel coraggio per opporsi al freddo e malmostoso sire cattolico, fanatico nemico giurato dei protestanti, proprietario di un impero su cui non tramontava mai il sole. Gli olandesi, diventati nel frattempo in gran parte luterani e calvinisti, lo ebbero. Quell’indipendenza affermata nel 1581 si concretò solo nel 1648, con la pace di Vestfalia, alla fine della Guerra dei Trent’anni, quando la Spagna dovette riconoscere autonomia e sovranità alla Repubblica Olandese. Stava nascendo l’Europa moderna.
Di pari passo con le rivolte e con le guerre, a partire dalla fine del Cinquecento, nell’affermarsi dell’idea di nazione indipendente, ebbe inizio per i Paesi Bassi, un'età di grande prosperità economica e culturale. A indagare questo periodo si aggiunge oggi, alla vasta bibliografia sul tema, il suntuoso libro di Jean Blanc, tradotto per la prima volta in italiano e destinato a restare fra i libri fondamentali sull’argomento. Si deve innanzitutto precisare che l’espressione «Secolo d'oro olandese» (Gouden eeuw), riferita alla civiltà dei Paesi Bassi della fine del Cinquecento e poi del Seicento, è, secondo Blanc, da ridiscutere. L’autore ci fa infatti notare che «questa età dorata» è stata in realtà un momento di profonde inquietudini e sconvolgimenti ed è stata attraversata da feroci conflitti che hanno poi ceduto progressivamente il passo a un’epoca di apertura e tolleranza. Il Seicento è, da alcuni punti di vista, il secolo migliore delle Province Unite che riaffermano la propria egemonia economica e commerciale, fondata soprattutto sui traffici e sul dominio coloniale. Sin dal 1581 godettero di un certo grado di autonomia politica; l’Olanda, che era la più grande, la più popolosa e la più ricca, ha sempre avuto uno status privilegiato all’interno della confederazione. La preminenza dell’Olanda spiega perché, in italiano come in francese, si parla facilmente di arte olandese per riferirsi a ciò che, in realtà, è arte neerlandese.
Blanc si propone di indagare l’arte di questo tempo fra «intellettuali, poeti, filosofi e artisti» che hanno colto con la parola, il colore e le idee questa profonda trasformazione. Ritiene anzi che «studiare i loro contributi, nella varietà che offrono, consente di dare vita al composito ritratto di una nazione in divenire, dalla guerra degli Ottant’anni al primo decennio del Settecento». Nel libro, splendidamente illustrato, l’arte e la storia dei Paesi Bassi si distendono sotto i nostri occhi attraverso quadri spesso complessi, allegorie che esaltano paci e trionfi, battaglie di mare, nudi sensuali, opulente nature morte, paesaggi, ritratti e scene di genere, ritratti collettivi con riunioni, banchetti e marce di gloriose guardie civiche o ronde di notte che siano (come nel dipinto di Rembrandt del 1642). Blanc ricorda però che «la società neerlandese del XVII secolo, profondamente patriarcale e violenta e la cui ricchezza discendeva ampiamente dalle conquiste coloniali in America, Africa e nelle Indie orientali, dava voce assai di rado a una visione critica su sé stessa, e ancor meno poteva farlo nelle rappresentazioni, che il più delle volte miravano a idealizzare il mondo piuttosto che a gettare uno sguardo neutrale su di esso»: un dettaglio non da poco.
Nella prospera Olanda del Seicento l’arte si sviluppa in ogni luogo creando ricchezza e, paradossalmente, una enorme concorrenza fra i pittori che per campare erano obbligati quasi tutti a fare doppi lavori. A parte Rembrandt, alla fine travolto da un fallimento, tutti gli artisti esercitavano infatti anche un altro mestiere. Jan Vermeer gestiva una locanda, Jan Steen era mastro birraio, Jan van Goyen coltivava tulipani, Meindert Hobbema lasciò la pittura per fare il sommelier. In ogni casa si trovavano dei dipinti; sia in quelle dei ricchi sia in quelle della piccola borghesia. Si è calcolato che siano stati dipinti almeno cinque milioni di quadri (ed è questo il motivo per cui i quadri olandesi pullulano in tutti i musei del mondo, nelle aste e nelle raccolte private). Ma quando nel 1672 Luigi XIV invase l’Olanda, la voglia di dipingere passò per parecchio tempo.

Jan Vermeer, «La Lattaia», 1658-66, Amsterdam, Rijksmuseum

Jan van Goyen, «Mulino a vento lungo un fiume», 1642, Londra, National Gallery
Ebbe avvio un periodo torbido e si vide che sotto l’oro delle forme c’era un’anima di ferro. Quei bei personaggi dei quadri, di parata o ritratti impizzettati, un po’ pingui, dai baffi curati e dall’apparenza gioviale, popolani o simpatici bevitori di birra, divennero autori di efferati episodi di violenza culminati nella orrenda morte dei fratelli de Witte all’Aia, testimoniata da un dipinto di Jan de Baen oggi al Rijksmuseum, che è certamente uno dei quadri più terrificanti di tutta la storia dell’arte europea. I de Witte, che ben governarono la Repubblica, furono uccisi a tradimento dalla folla inferocita sulla base di accuse false, i loro corpi mutilati, appesi a testa in giù e fatti a pezzi. Il poeta Joachim Oudaen, testimone oculare, scrisse che parte dei loro intestini e fegati venne mangiata dagli assassini e altra data ai cani, mentre altre parti vennero vendute a caro prezzo per la città. No, non era tutto d’oro quel secolo.
Nonostante questi orrori (peraltro sconosciuti ai più), l’arte olandese attrae ancor oggi in modo irresistibile le persone che affollano le mostre e anche gli scrittori: Donna Tartt con il suo Il cardellino (2013), che coinvolge un celebre quadro di Carel Fabritius; Jessie Burton ne Il miniaturista (2014), ambientato nella Amsterdam del Secolo d’oro; Tracy Chevalier, con La ragazza con l’orecchino di perla (1999), dedicato alla storia del celeberrimo quadro di Vermeer; e poi i registi che da questi libri hanno tratto film più o meno rispettosi sul piano storico e di costume.
La pittura neerlandese aveva quasi eliminato i temi religiosi e farà progressivamente sparire anche i quadri di storia, di mitologia e di tematiche sull’antico. Nasceranno nuovi temi: quelli della vita quotidiana, con mercati, bottegai, reggenti di ospizi, mucche, capre, pecore al pascolo, mamme con bambini, donne che spazzano le stanze, vecchie che leggono, nature morte piene di frutta, carne pesce pronte per banchetti succulenti. Tutti soggetti nuovi, con una presa sulla realtà che li rende spesso ancora molto attuali. Soggetti che poi influenzeranno e prenderanno piede nel resto d’Europa e anche in Italia, senza tuttavia arrivare ad avere il peso e il significato che avevano in patria.
Una rivoluzione del gusto molto lontana dal Barocco italiano o francese, ma non per questo meno importante: Blanc ricostruisce con rara profondità storica la cultura e la società che hanno dato vita a un periodo artistico irripetibile, fatto di quadri che non vogliono più narrare storie solenni, non celano iconografie o simbologie criptiche o colte. La forza di questa pittura sta proprio nel fatto di poterla pensare come parte di esperienze quotidiane e possibili, e che dipingere una cosa anche modesta come una cucina, o una cuoca che spiuma polli, non precluda la via della bellezza. Questo è il pensiero che intride gli scritti di Baruch Spinoza e i quadri di Vermeer, due olandesi contemporanei del Secolo d’oro: per Spinoza non vi è alcuna gerarchia tra le diverse realtà, tutto ha pari dignità, per Veermer ogni oggetto anche il più modesto, è colto «sub specie aeternitatis» e nei suoi dipinti la realtà è fissata sotto una luce eterna in cui anche i gesti e gli spazi più semplici emergono dalla loro quotidiana essenza e assumono lo spessore di un attimo sospeso dal tempo e reso eterno. È questo il segreto che rende l’arte olandese ancora oggi così attraente; siamo parte della natura e siamo liberi di guardare e di pensare e di godere anche di un semplice riflesso del latte che discende da una brocca in una ciotola: in esso sta il segreto del mondo, se lo sappiamo cogliere.
Il secolo d’oro olandese. Una rivolta culturale nel XVII secolo
di Jan Blanc, traduzione di Anna Delfina Arcostanzo, 608 pp., ill., Einaudi, Torino 2025, € 150
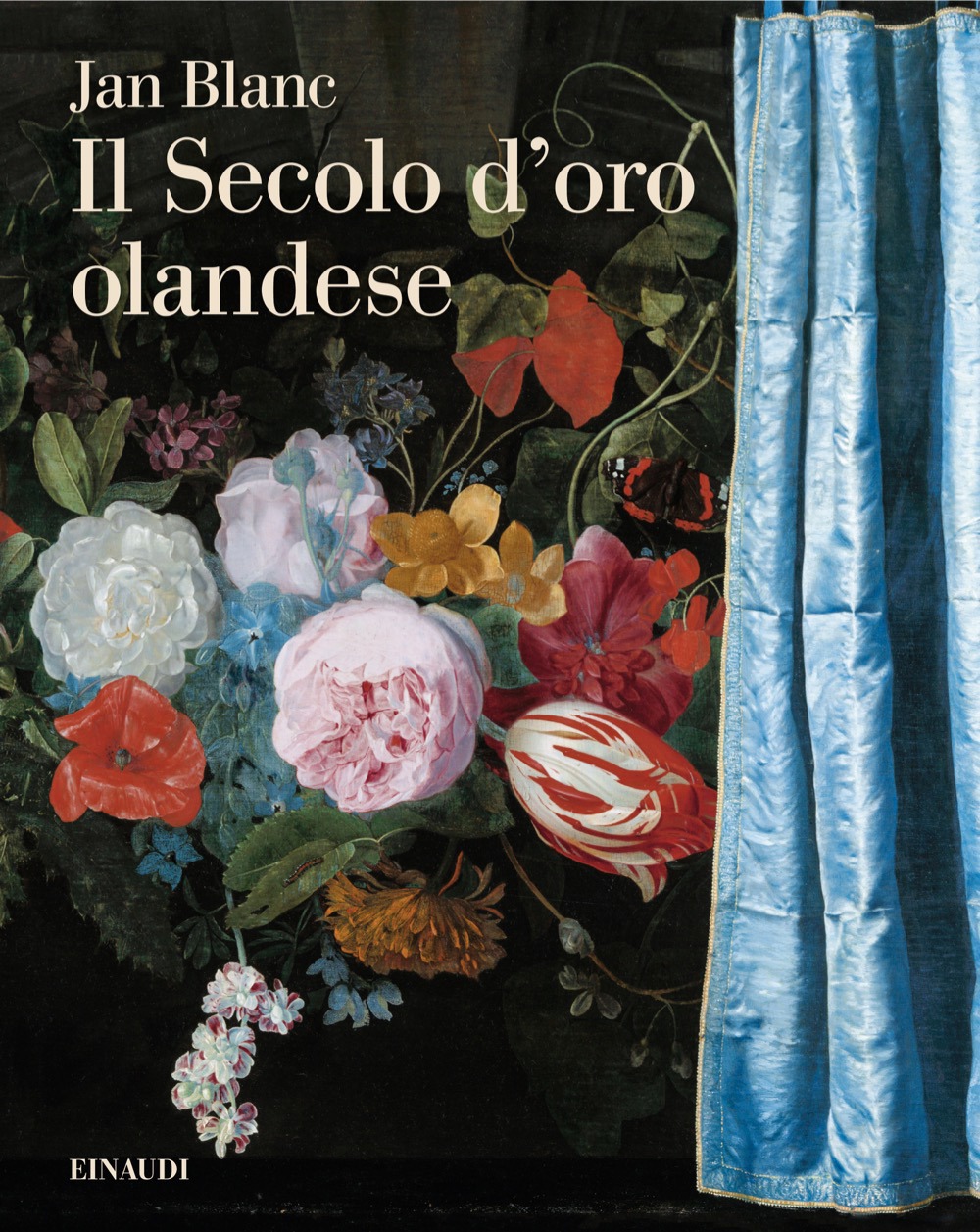
La copertina del volume
Altri articoli dell'autore
Un progetto ideato dalla Fondazione Carlo Molo di Torino con il supporto di ANCoS Roma e Provincia e il contributo della Compagnia di San Paolo mette il museo al centro di un’esperienza di formazione per gli operatori e di benessere, relazione e inclusione per le persone affette da Alzheimer e per i loro caregiver
In anteprima per «Il Giornale dell’Arte» la nuova monumentale monografia che lo storico dell’arte ha dedicato al più grande pittore francese di tutti i secoli, protagonista di un’avventura intellettuale e artistica senza pari tra Francia e Italia
Con l’avvento del Cristianesimo, tra il Tardo Medioevo e il Rinascimento le opere ritraevano le vittime preferite dalla «Nera Signora», giovani e belle, come i quaranta ragazzi la cui vita è stata prematuramente stroncata in un momento di festa
Da Pompei al Medioevo, da Masaccio a Caravaggio e Correggio, da Rothko a Kiefer, dai giardini all’architettura fascista in Africa, e poi Piero Manzoni, la porcellana, Shirin Neshat...




















