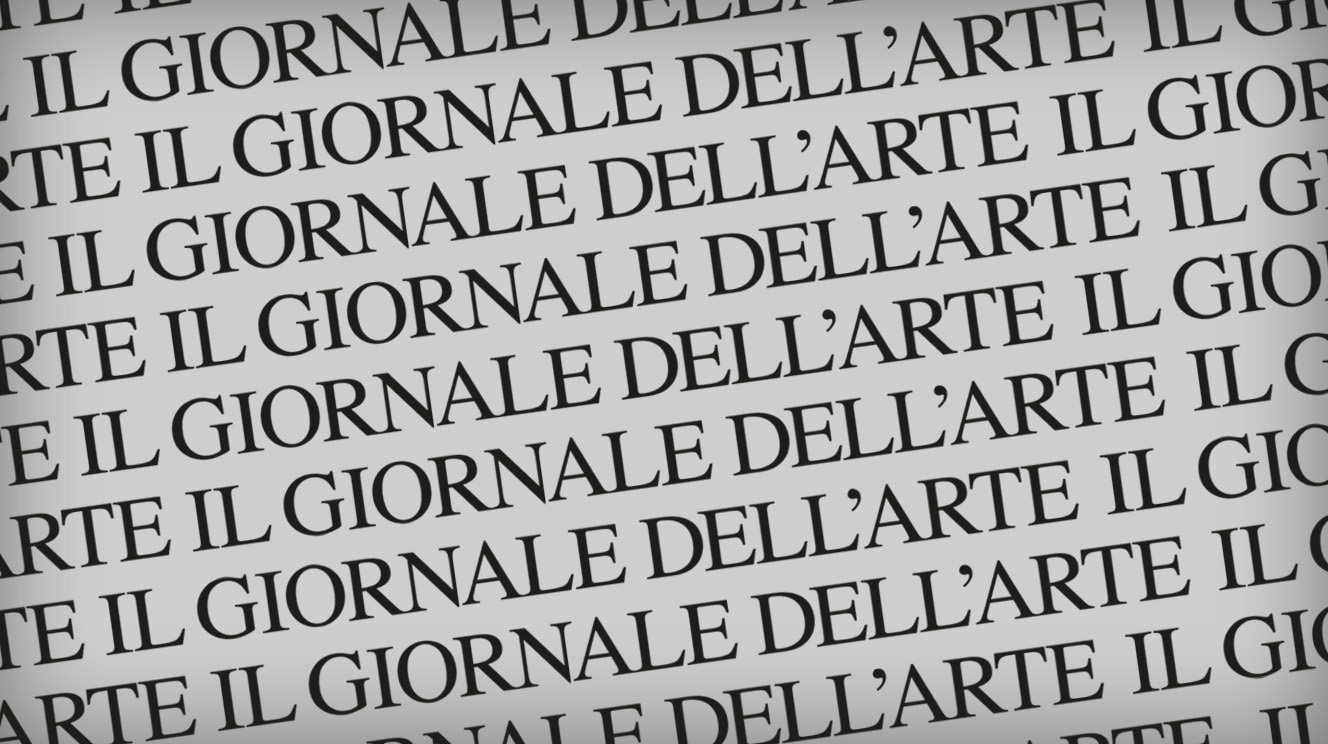Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Bruno Zanardi
Leggi i suoi articoliParma. Il 24 gennaio è morto Gianfranco Fiaccadori, tra i più colti, acuti e autorevoli esponenti della recente storia culturale italiana. Un’amara e dolorosa notizia che ha colto tutti di sorpresa perché nessuno sapeva del male che lo aveva improvvisamente colpito con terribile virulenza e che in pochi mesi lo ha vinto. Nessuno sapeva, perché a nessuno aveva detto quanto gli stava succedendo, in perfetta armonia con il carattere di riservatezza che lo caratterizzava, il piacere di «vivere nascostamente». Aveva 57 anni, davvero troppo pochi per andarsene.
Ultimo allievo alla Normale di Pisa di Giovanni Pugliese Carratelli, a sua volta ultimo allievo di Benedetto Croce (pur se per via di Adolfo Omodeo), tanto che con divertito snobismo talvolta Gianfranco diceva di essere perciò l’ultimo crociano in giro per l’Italia, si laurea giovanissimo, a soli 21 anni. Ed era un piccolo mito della Normale il magrissimo, solitario, barbuto e sapientissimo ragazzo che frequentava i consessi più insoliti e eterogenei per esercitarsi (lui, già vincitore al liceo del «Certamen latinum») nella lunga serie di lingue tra vive e morte che andava nel frattempo imparando con strabiliante facilità: dall’arabo al sanscrito, dall’aramaico all’etiope, dall’ebraico al greco bizantino; oltre ai «correnti» greco moderno, francese, russo, tedesco e inglese. Un piccolo mito il ragazzo che, per natura e formazione, aveva preferito lavorare sulla propria educazione, evitando d’inseguire gli incendi ideologici che infiammavano la Pisa di quegli anni, perché lontanissimo, per formazione e intelligenza, da ogni semplificazione, appunto, ideologica della realtà, ancor più da qualunque forma di demagogia che, come si sa, dell’ideologia è figlia, come resterà tutta la vita; ed è un altro insegnamento che ci ha lasciato.
Si preparava in quel modo Fiaccadori, sotto la guida affettuosa e solidale di Pugliese Carratelli (che una volta mi disse di aver avuto molti allievi, ma forse nessuno dotato come lui era), a far propria la lezione laica e liberale di chi gli era stato Maestro, la lezione secondo cui le antichità storiche vanno studiate nel loro insieme, non mai dividendole in settori specialistici. Si preparava cioè Fiaccadori a perseguire quella «scienza dell’antico» cui i suoi studi hanno in fine sempre mirato. Un lavoro da giganti, perché scienza raggiungibile solo con il possesso d’una sterminata erudizione, vero e solo sale della sapienza, quella che lui padroneggiava come pochi. Fu quindi Fiaccadori più storico della cultura che storico in senso stretto, come testimonia la sua magistrale rilettura nel 1994 della figura del Cardinal Bessarione, offerta in un’indimenticabile mostra veneziana organizzata con Marino Zorzi e illustrata in un catalogo da lui curato con raro e insuperabile rigore. Un catalogo ancora oggi esemplare per la «brevitas» dei testi (brevitas ciceronianamente intesa come tutt’uno con la «concinnitas») fino all’implacabile precisione delle citazioni bibliografiche, perché solo modo per potersi orientare dentro un testo.
Dopo essere stato dal 1984 al 1986 research fellow al Center for Byzantine Studies di Harvard, torna in Italia dove, a Udine, è promosso, prima, nel 1987, professore associato, poi, nel 1995, ordinario, fino a occupare nel 2001 la cattedra di Cultura artistica della tarda antichità e dell’alto Medioevo e di Civiltà bizantina alla Statale di Milano. Membro della Missione archeologica Italiana a Bosra, in Siria, docente d’Archeologia tardoantica e bizantina alla Scuola archeologica Italiana di Atene, Gianfranco fu uomo di straordinaria disponibilità e generosità, sempre elargendo ad amici e collaboratori consigli, aiuti, tempo ed energie professionali e umane, pur non essendogli estranea certa intransigenza, ove questa si rendesse necessaria a redimere errori o sanare ingiustizie. Ma dice bene di quella disponibilità e generosità (sulle reprimende sorvolando) un episodio raccontatomi di recente da Alberto Saibene, che lo vide decifrare seduta stante, per l’amico e collega Giovanni Agosti, una complicatissima e fino a quel momento mai correttamente sciolta iscrizione latina colma di abbreviazioni posta in un cartiglio d’un importante dipinto quattrocentesco. Prova non semplice anche per lui, però superata con la naturalezza, la leggerezza e la solidissima competenza d’un grande studioso d’altri tempi. «Come aver visto al lavoro, diceva Saibene, un Michele Barbi o un Giorgio Pasquali».
Consueta era inoltre la sua presenza alla Biblioteca Apostolica Vaticana, chiamato a dare pareri e contributi. E proprio lì accadde non molti anni fa una vicenda in cui Gianfranco, che era anche uomo assai spiritoso, molto si divertì. Un giorno arriva a casa sua l’invito per la presentazione alla Vaticana del restauro del rarissimo Ottoteuco Etiope di XV secolo conservato nella Biblioteca Comunale di Pistoia, codice a lui ben noto perché alcuni anni prima ne aveva curato la difficilissima traduzione. Un restauro pagato una fortuna ma, al solito, un intervento inutile, quindi dannoso (mi pare avessero drizzato le pagine, tagliandole, e smontato senza alcun bisogno la legatura originale)la cui presentazione veniva annunciata in gran pompa, avvertendo che, nell’occasione, si sarebbe anche esibita la nuova traduzione del codice, producendone un estratto. Estratto in cui Gianfranco non fece fatica a riconoscere il plagio della sua traduzione, come con ironica nonchalance egli disse (avvertita preventivamente la Direzione della Biblioteca) alla cerimonia di presentazione del restauro quando il deputato che presiedeva chiese se ci fossero domande da parte del pubblico; ponendo così in farsa l’intero «evento» e insieme tutelando la tanto prestigiosa sede che inopinatamente l’aveva ospitato.
Parte dirigente di grandi iniziative di studio internazionali (la morte lo ha colto quando era coeditor della Encyclopedia Aethiopica, redatta a Amburgo) così come attento alla didattica (con Giulio Bora e Antonello Negri pubblica I luoghi dell’arte, manuali esemplari e finalmente lontanissimi da ogni «spiegazione» banalmente ideologica della storia dell’arte, alla Argan per intenderci), Fiaccadori ha inoltre promosso importanti studi di storia della cultura non solo legati al suo àmbito disciplinare. Come direttore della collana «Folia» edita a Udine presso Campanotto, Fiaccadori ha accolto e pubblicato volumi di storia delle idee che spaziano dal neoplatonismo inglese alla critica d’arte di Anthony Blunt, non mancando inoltre di produrre mostre importanti sebbene, com’era nel suo carattere, di nicchia: tra le altre, «Nigra sum sed formosa. Sacro e bellezza dell'Etiopia cristiana», mostra curata nel 2009 con l’amico Giuseppe Barbieri, dove nel catalogo si legge un suo saggio di densità e ricchezza di riferimenti davvero non abituali.
In tutto questo, soprattutto in anni recenti, quando anche a Parma, la sua città d’origine (vi era nato nel 1958), chiara a tutti ne fu l’assoluta importanza di studioso, Fiaccadori dà nuovo impulso ai peraltro mai abbandonati studi di storia locale, ancora una volta seguendo il magistero crociano del proprio Maestro Pugliese Carratelli, di cui eredita la storica rivista «La parola del passato». Direttore del Bollettino del Museo Bodoniano di Parma, colonna del «Bollettino della deputazione di storia patria di Parma e Piacenza», sempre attentissimo ai problemi della tutela del patrimonio storico e artistico (fu «ispettore onorario» del Mibac per Parma, ma in un Paese normale, per competenza, senso dello Stato, doti di equilibrio e capacità di comando, avrebbe potuto, e forse dovuto, essere un finalmente credibile Direttore generale del Mibac), con Alessandro Malinverni e Carlo Mambriani fonda il Centro studi per la conservazione e la valorizzazione delle residenze ducali di Parma e Piacenza, ma soprattutto con loro costruisce molte e importanti mostre e numerosi convegni dedicati al Settecento parmense e al periodo risorgimentale della città.
E sono questi appena detti solo alcuni dei moltissimi, eruditissimi, preziosi e sempre appartati lavori di studio condotti da Gianfranco nella sua vita. Per loro, basti il titolo d’una delle decine di voci da lui scritte per il Dizionario Biografico degli italiani: «Shabbĕtay Bar Abrâhâm DONNOLO», dotto astronomo e astrologo ebreo del X secolo ignoto ai più e ai meno, ma non a lui.
A chi lo ha amato, moltissimi, tocca oggi di proseguire nel lavoro che è stato la sua stessa vita. Questo l’impegno.
Addio Gianfranco, sit tibi terra levis.

Gianfranco Fiaccadori. Foto: Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti
Altri articoli dell'autore
L’Italia possiede le linee guida per la prevenzione dei disastri ambientali da quasi 50 anni, ma non le ha mai applicate
Politica, ideologia, burocrazia e miopia hanno cinicamente liquidato la possibilità di preservarci: le non scelte sono i responsabili effettivi dei morti e dei disastri che affliggono l’Italia. Eppure sapevamo. I piani non sono certo mancati
Anche nel turismo l’innovazione senza efficienza fa solo danni