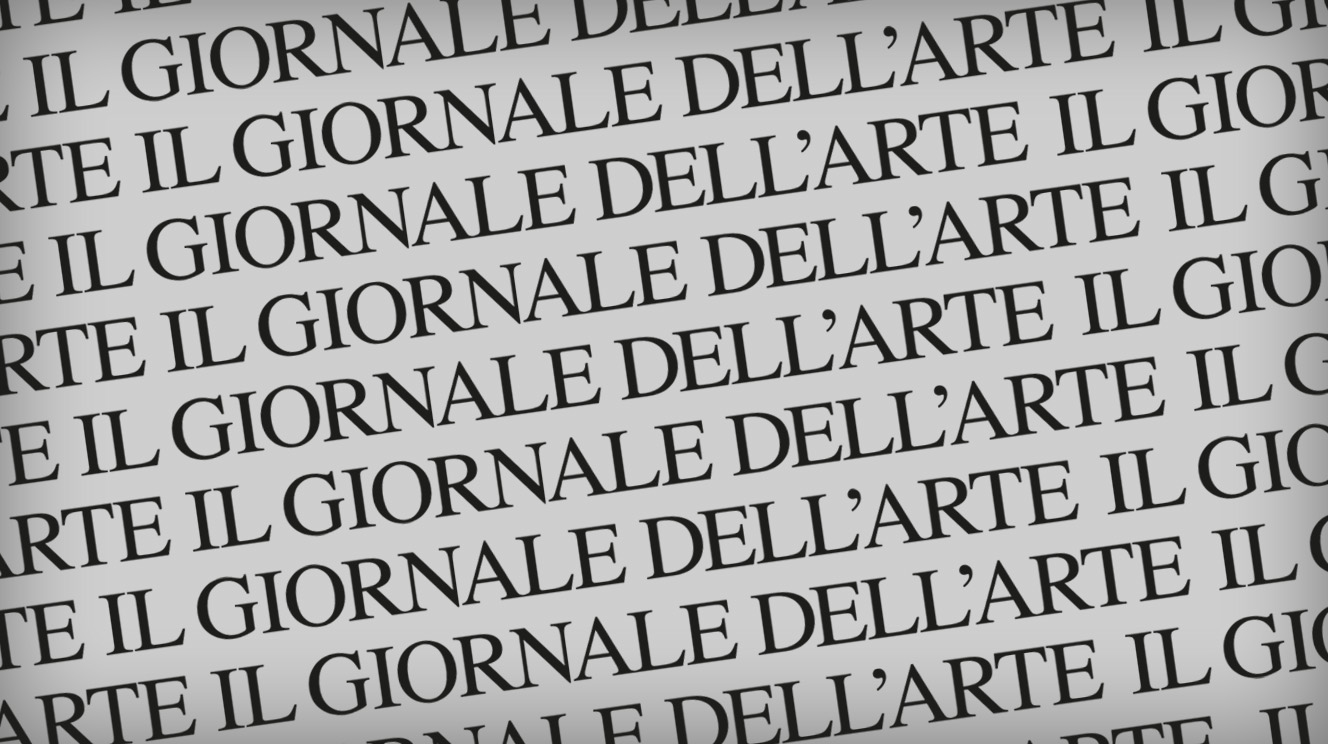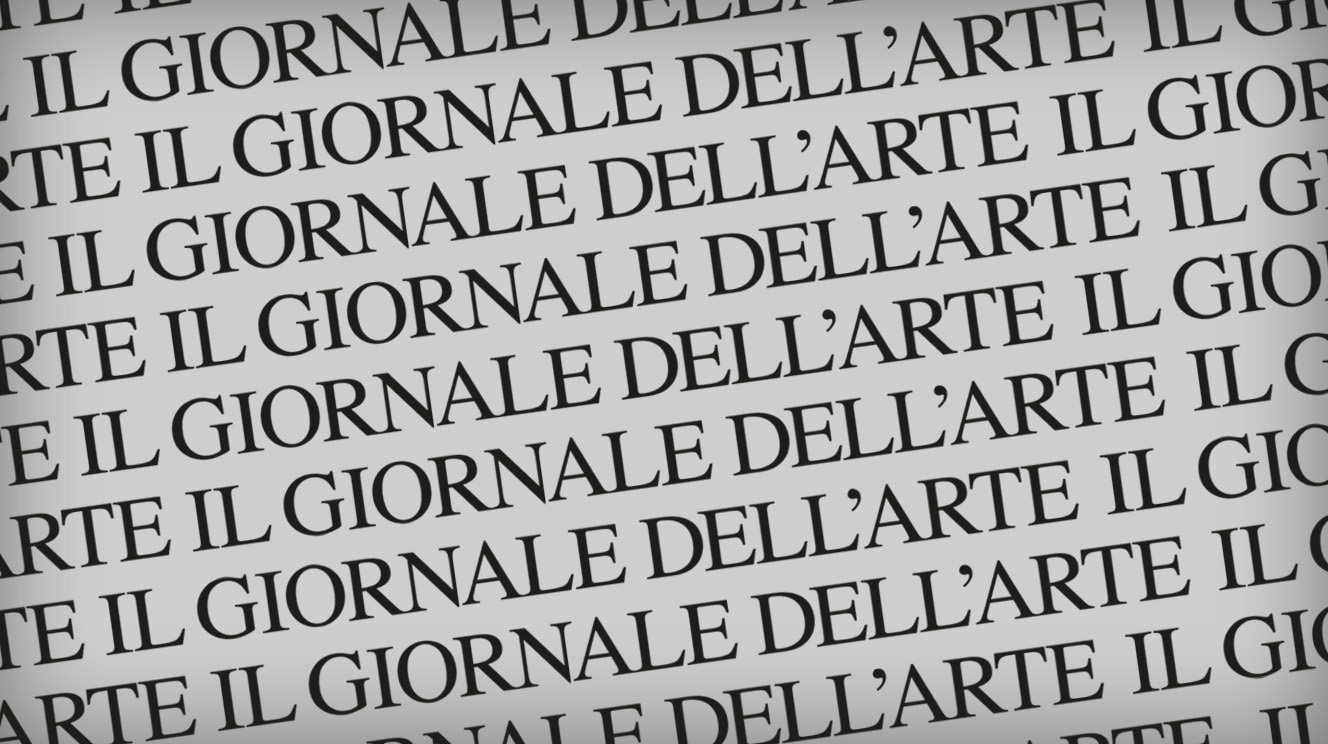Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Bruno Zanardi
Leggi i suoi articoliIl «rammendo delle periferie», secondo la suggestiva formula coniata da Renzo Piano, grande architetto e senatore a vita finalmente per vero merito, pare sia destinato a divenire punto programmatico del governo Renzi. Da ciò il decisivo interesse di questa civilissima impresa al cui fondo credo ci sia il voler riconoscere a quelle stesse periferie il rango d’inedite e autonome città storiche. Un riconoscimento che appare del tutto fondato visto che la grande maggioranza degli uomini (il trend è infatti planetario) vive oggi in periferie urbane. Ma che mal s’adatta, fino a essere errore, all’ultramillenario insieme di vere città storiche e di vero paesaggio storico che ancora oggi fanno dell’Italia (unitamente al suo vero e infinitamente diffuso patrimonio artistico-storico) un unicum nel mondo intero: il «Bel Paese» per eccellenza. L’insieme solo italiano in cui le moderne periferie sono senz’altro città, tuttavia, per dirla con Alexandre Kojève, città poststoriche.
Ma per quale ragione allora Renzo Piano commette un errore del genere? Perché il suo non è un errore, bensì la semplice presa d’atto del completo fallimento delle politiche urbanistiche finora adottate nel nostro Paese. Un fallimento originato dalla distinzione, sempre presente nei piani regolatori italiani, tra un centro storico rigido e immodificabile e, al contrario, una moderna periferia post-storica flessibile e modificabile. Tutto ciò col risultato che i flessibili tentacoli della moderna periferia post-storica hanno stretto in un abbraccio mortale i rigidi centri storici unificandoli in un comune degrado.
Detto questo, e ribadito che siamo di fronte a un problema gigantesco quale è la crescita metastatica delle periferie rispetto ai centri storici, proviamo a cercare le ragioni per le quali un problema di tale palmare evidenza e di così decisiva importanza per il futuro stesso dell’Italia e delle sue giovani generazioni è venuto lievitando dal 1945 in poi, cioè dopo la fine della seconda guerra mondiale, senza che mai lo si sia, se non risolto, almeno affrontato. Ragioni numerosissime; provo a citarne alcune.
q Il gravissimo ritardo culturale in cui vive oggi il Paese. Quello soprattutto attestato dalla nostra classe politica che, proprio a causa della sua impreparazione, ha nei fatti tolto dai propri doveri tutto quanto fosse complesso da elaborare. Quindi mai ha elaborato razionali, coerenti e moderne politiche industriali, agricole, energetiche e quant’altro, come piani a lungo termine su temi civili e sociali fondamentali quali istruzione, ricerca scientifica, ambiente, giustizia, fisco, sanità, pensioni, mobilità viaria e ferrotranviaria, urbanistica, salvaguardia del patrimonio artistico ecc. Tutto ciò per invece promuovere la politica economica più semplice, stupida e ricca che c’è: la speculazione edilizia. Con lei, la cementificazione dei suoli, quindi la loro impermeabilizzazione. Da qui (anche) il dissesto idrogeologico del Paese, quello che sta producendo con cadenza ormai quasi mensile i disastri ambientali di cui tutti sappiamo.
q La sostanziale incompetenza della nostra Università a preparare i quadri amministrativi (dai soprintendenti, ai funzionari regionali e comunali) che dovrebbero risolvere in via tecnica il decisivo quesito sotteso al nostro vivere in un Paese come l’Italia colmo fino all’inverosimile di storia: quale sia il senso della presenza del passato nel mondo d’oggi.
q Il dettato del Manifesto dell’architettura organica del 1945, dettato fatto verbo da molte e successive generazioni di architetti, per il quale il «nuovo» costruito non deve avere rapporto alcuno con il «vecchio» mentre in un Paese come l’Italia avrebbe invece dovuto (e dovrebbe) essere vero il contrario. Cioè che la città storica fosse considerata insuperabile punto di traguardo per distribuzione delle funzioni, forma, proporzioni e materiali da costruzione delle nuove periferie.
q La generale e bovina osservanza della «istanza storica» (1952) della Teoria del restauro di Cesare Brandi, la stessa che impedisce la ricostruzione tal quale delle città storiche distrutte da calamità naturali, inanellando architetti e urbanisti una lunga serie di disastri edilizi privi d’un qualsiasi carattere identitario in senso estetico e sociale. Dalle tutte uguali e tristissime nuove casette del Vajont, all’ideologica «nuova Gibellina», alla ricostruzione in squallidi condomini dell’Irpinia, fino alla truffa delle «new town» di L’Aquila.
q Aver fatto le Regioni verbo ideologico della suddetta rigidità dei centri storici nel nome d’una dilettantesca e ideologica idea di conservazione ad oltranza dell’esistente, idea inverata nella politica fatta solo di vincoli e divieti di cui possono essere simbolo Pier Luigi Cervellati e Vezio De Lucia. Politica il cui principale effetto è stato aver museificato i centri storici ottenendo la fuga della gran parte dei residenti; basti, per dire in concreto del fallimento di quella politica, che dagli inizi degli anni ’70 del Novecento a oggi si è avuta nei centri storici una diminuzione di circa il 60% di abitanti e attività produttive.
q La completa farraginosità del quadro legislativo che oggi governa l’urbanistica in Italia, ancor più grazie alla produzione normativa delle Regioni abnorme e confusa (quando non, prima che criminosa, demente, come la legge che consentiva di poter costruire fino a tre metri dalle rive dei torrenti che la Regione Liguria qualche mese fa, cioè prima della recente ed ennesima alluvione, ancora voleva approvare!).
Soluzioni? Abolire subito le Regioni. Immediatamente dopo, resettare l’attuale quadro legislativo relativo all’urbanistica, semplificandolo radicalmente e finalizzandolo a favorire la congiunzione tra città storica e periferia. Favorire come? Facendo tornare nelle città, ivi compresi i centri storici, le attività lavorative oggi in genere confinate nelle estreme periferie, quando non disperse senza alcun senso nelle campagne. Quindi facendo tornare dentro le città industrie, opifici e quant’altro dia concreta occupazione a operai, impiegati e dirigenti. Il che significherebbe? Molte cose. Ad esempio:
q riprogettare le periferie ponendole in rapporto con i centri storici;
q riprogettare i centri storici recuperandoli a un’abitabilità compatibile con le odierne esigenze dei cittadini (una riprogettazione ovviamente misurata per forme, tipologie, materiali e quant’altro con l’esistente);
q restituire alla coltivazione il terreno agricolo oggi occupato dai capannoni industriali così anche riconsegnando alle città i loro confini;
q esercitare un controllo diretto e immediato dei cittadini sulle emissioni inquinanti degli opifici collocati non più in zone remote;
q far abitare le persone vicino ai luoghi di lavoro perciò spostando il più possibile i consumi alimentari, vestiari, eccetera, dai centri commerciali ai negozi «di quartiere»;
q ridurre il traffico veicolare;
q smettere di dare la solita, ideologica e demagogica destinazione museale all’immenso patrimonio immobiliare demaniale di palazzi storici, rocche, caserme, ospedali obsoleti, mercati coperti dismessi ecc, progettandone un riuso di concreta utilità sociale. Ad esempio, insediandovi le predette attività lavorative, ovvero trasformando quelle stesse caserme, rocche, eccetera in unità abitative; per fare un solo esempio, fino agli anni ’20 del Novecento nel Palazzo Ducale di Mantova, allora proprietà comunale, vivevano in affitto circa 3.500 persone, gli stessi affittuari che, vivendoci, hanno salvato il Palazzo;
q far tornare le città (centri storici e relative periferie) luoghi di vita, quindi luoghi di relazioni civili, sociali ed economiche; le stesse oggi falsamente soddisfatte, nei centri storici, da negozi di finto artigianato, «ristorantini», «movide» e così via, e nelle periferie dalla peste dei centri commerciali e delle sale per giochi d’azzardo.
Tutto questo con molti e numerosi benefici per la creazione d’una «cultura vissuta» della città e del paesaggio che nasca dagli ambiti sociali, organizzativi e occupazionali (specie per i giovani) entro cui una simile e gigantesca sfida si pone. Ambiti giuridici (si pensi al delicatissimo tema degli espropri), economici, fiscali, sociologici, agricoli, idrogeologici, infrastrutturali, storico-artistici, architettonici ecc, fino a una progettazione orientata a un riuso compatibile dell’esistente, come alla ricerca scientifica nella domotica, nelle energie rinnovabili, nei sistemi di trasporto leggero o nella conservazione preventiva e programmata del patrimonio artistico in rapporto all’ambiente: in primis la prevenzione del patrimonio monumentale, o più semplicemente edilizio, dal rischio sismico.
Nella certezza, o almeno nella speranza, che pressappoco questa sia la ratio sottesa ai rammendi di Renzo Piano. Dar corpo a un grande «progetto nazionale» mirato a realizzare un coerente e razionale riassetto del rapporto centro-periferia delle città come del rapporto tra città e paesaggio. Un progetto che abbia al proprio centro una tanto capillare quanto radicale de-cementificazione dell’intero territorio del Paese. Il contrario perciò d’un maquillage estetizzante teso a rammendare, cioè a mascherare, ultradecennali e gravissimi errori progettuali, culturali, politici e sociali. Errori strutturali impossibili da nascondere con bugie dalle gambe corte, anzi cortissime, come dipingere di verde i container, applicare alberi e alberelli a condomini speculativi verticali, decorare con stecche di legno «ecologico» il cemento e così via improvvisando e ingannando.
Altri articoli dell'autore
L’Italia possiede le linee guida per la prevenzione dei disastri ambientali da quasi 50 anni, ma non le ha mai applicate
Politica, ideologia, burocrazia e miopia hanno cinicamente liquidato la possibilità di preservarci: le non scelte sono i responsabili effettivi dei morti e dei disastri che affliggono l’Italia. Eppure sapevamo. I piani non sono certo mancati
Anche nel turismo l’innovazione senza efficienza fa solo danni