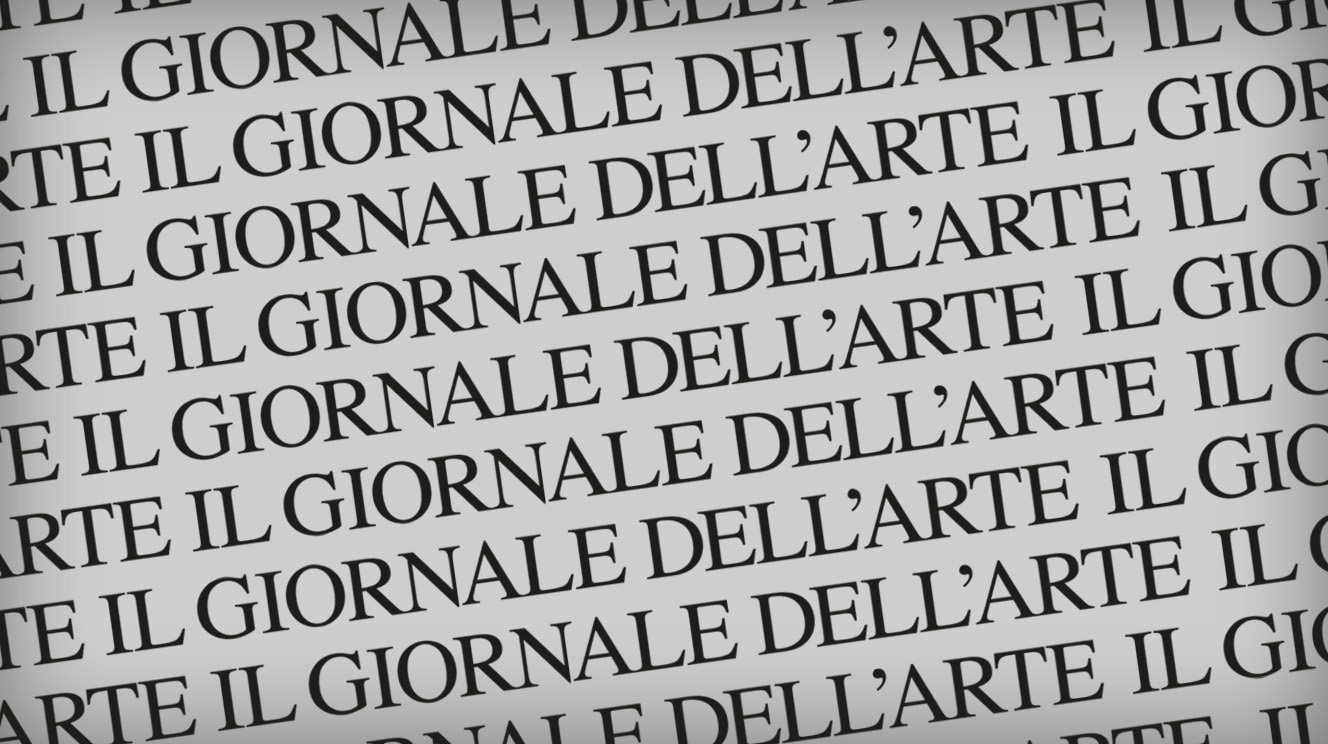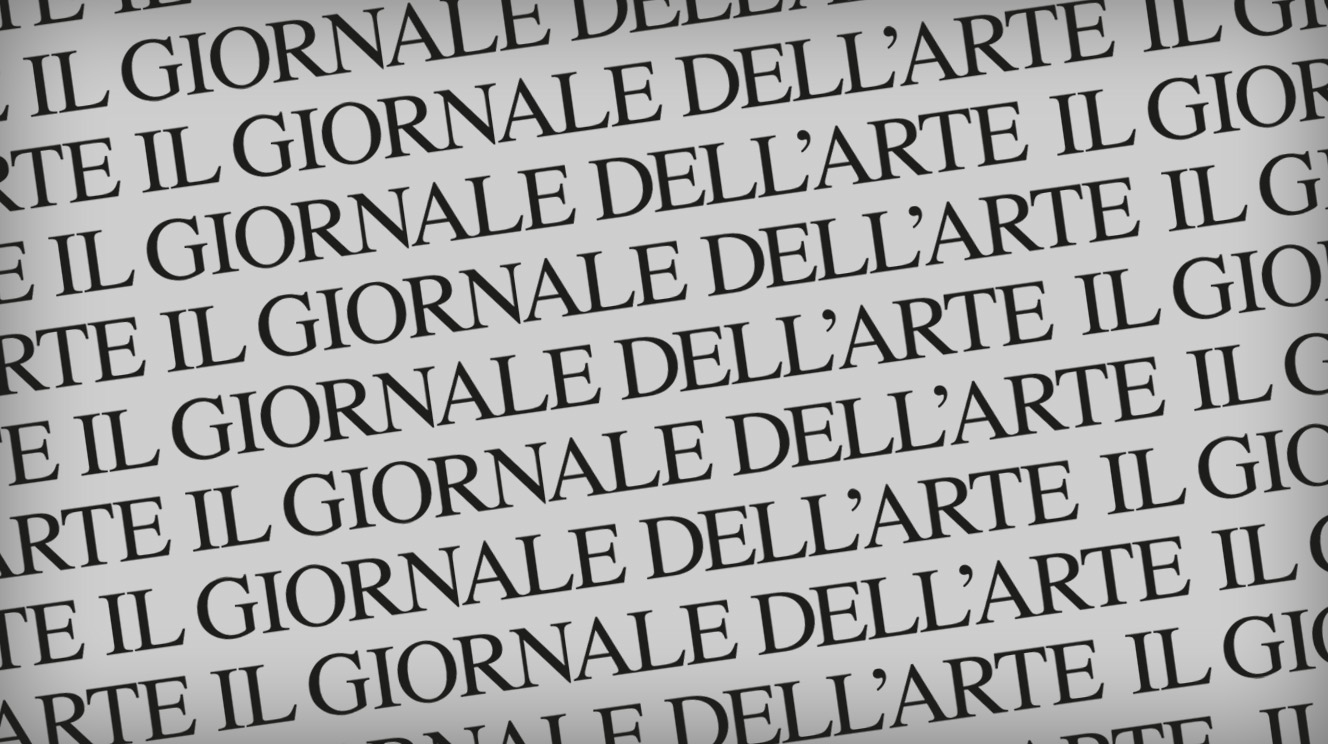Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Denise La Monica
Leggi i suoi articoliDalla Toscana ai fari (ambitissimi) alle dimore storiche
A fine gennaio il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha annunciato che, a partire da marzo, sarà aperto un nuovo bando per la vendita di immobili di proprietà della Regione e delle Asl per un ammontare di 710 milioni di euro; tra questi anche beni come villa Filicaia a Prato, la parte centrale dell’ex ospedale del Ceppo a Pistoia, il palazzo dei Trovatelli a Pisa, proprio davanti alla Torre, il padiglione Morselli di Volterra e il Castello di Monteregio nella parte alta di Massa Marittima. In realtà da qualche anno la Regione possiede una legge apposita (n. 77/2004) in base alla quale è stato avviato un processo di vendita di un centinaio di beni, che ha portato fino ad ora solo 12,8 milioni di euro.
 Tra i beni inseriti in questo primo processo e individuati con Dgr n. 491/2012 (all. D), circa un centinaio, si trovano anche immobili di interesse storico-artistico, come, ad esempio, un ex monastero camaldolese situato in località Luco di Mugello, nel Comune di Borgo San Lorenzo, con tanto di chiostro e cappella affrescata, in vendita per 12 milioni. Il bando di vendita risale al luglio 2015, dopo che i beni mobili e immobili sono stati provvisti di dichiarazione di interesse culturale e dopo che è stata rilasciata autorizzazione alla vendita da parte del Mibact. Il complesso è stato quindi messo in vendita il 24 luglio 2015, ma corredato di una serie di vincoli di tutela: l’esecuzione di lavori è sottoposta a preventiva autorizzazione della Soprintendenza; la destinazione d’uso prevista (attrezzatura turistico-ricettiva, funzioni di tipo culturale e di servizio) non dovrà essere modificata; ogni variazione d’uso dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza; i beni mobili, valutati come pertinenziali, dovranno essere conservati e manutenuti nelle attuali collocazioni. Il dibattito rimane comunque aperto: Enrico Rossi dichiara che il mantenimento di queste strutture costa 100 milioni di euro l’anno, troppo per le casse regionali; i Comuni, in alcuni casi, si propongono come acquirenti chiedendo in cambio interventi della Regione nell’ambito dei servizi.
Tra i beni inseriti in questo primo processo e individuati con Dgr n. 491/2012 (all. D), circa un centinaio, si trovano anche immobili di interesse storico-artistico, come, ad esempio, un ex monastero camaldolese situato in località Luco di Mugello, nel Comune di Borgo San Lorenzo, con tanto di chiostro e cappella affrescata, in vendita per 12 milioni. Il bando di vendita risale al luglio 2015, dopo che i beni mobili e immobili sono stati provvisti di dichiarazione di interesse culturale e dopo che è stata rilasciata autorizzazione alla vendita da parte del Mibact. Il complesso è stato quindi messo in vendita il 24 luglio 2015, ma corredato di una serie di vincoli di tutela: l’esecuzione di lavori è sottoposta a preventiva autorizzazione della Soprintendenza; la destinazione d’uso prevista (attrezzatura turistico-ricettiva, funzioni di tipo culturale e di servizio) non dovrà essere modificata; ogni variazione d’uso dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza; i beni mobili, valutati come pertinenziali, dovranno essere conservati e manutenuti nelle attuali collocazioni. Il dibattito rimane comunque aperto: Enrico Rossi dichiara che il mantenimento di queste strutture costa 100 milioni di euro l’anno, troppo per le casse regionali; i Comuni, in alcuni casi, si propongono come acquirenti chiedendo in cambio interventi della Regione nell’ambito dei servizi.
 Ma, intanto, gli stessi Comuni hanno inserito nelle liste del programma Valore Paese Dimore alcuni beni, anch’essi di interesse culturale: ad esempio il Comune di Prato rende disponibile per la concessione Palazzo Datini (sede dell’ominimo museo) e per la vendita l’ex Monastero di San Clemente; il Comune di Massa mette in vendita Palazzo Nizza (XV secolo). Non solo la Regione, ma anche le Province, in corso di forte ridimensionamento, mettono in vendita i loro beni: a Pisa, ad esempio, sono in vendita la sede della Prefettura e della Questura, sul Lungarno. La dismissione dei beni degli enti locali corre parallela a quella relativa ai beni statali.
Ma, intanto, gli stessi Comuni hanno inserito nelle liste del programma Valore Paese Dimore alcuni beni, anch’essi di interesse culturale: ad esempio il Comune di Prato rende disponibile per la concessione Palazzo Datini (sede dell’ominimo museo) e per la vendita l’ex Monastero di San Clemente; il Comune di Massa mette in vendita Palazzo Nizza (XV secolo). Non solo la Regione, ma anche le Province, in corso di forte ridimensionamento, mettono in vendita i loro beni: a Pisa, ad esempio, sono in vendita la sede della Prefettura e della Questura, sul Lungarno. La dismissione dei beni degli enti locali corre parallela a quella relativa ai beni statali.
A febbraio 2016 l’Agenzia del Demanio ha informato, con un proprio comunicato, che, con il federalismo demaniale, 231 beni dello Stato sono stati consegnati agli enti locali nel solo mese di gennaio 2016. Edifici di interesse storico o storico-artistico, di considerevoli dimensioni ma oggi in gran parte sottoutilizzati o abbandonati, sono stati oggetto di norme per il loro censimento, riuso e valorizzazione. Dal 2001 le norme hanno progressivamente aumentato le possibilità di dismettere porzioni del patrimonio immobiliare pubblico con le più svariate procedure. Dopo il fallimento di Patrimonio dello Stato Spa, l’Agenzia del Demanio è diventata vera e propria protagonista di questa linea politica, finalizzata da una parte a censire il patrimonio, dall’altra a individuare modi per il suo migliore utilizzo o valorizzazione.
Mentre l’Agenzia mette in vendita terreni e immobili privi di valore culturale, altri beni sono inseriti in procedure concertate. Ad esempio, per il Demanio storico artistico è in corso il «federalismo demaniale culturale» con cui si elaborano operazioni condivise tra più soggetti istituzionali, e ovviamente partecipate dal Mibact, per il recupero strutturale e funzionale di immobili di interesse storico-artistico. In parallelo nella società civile si è riacceso l’interesse verso la dimensione sociale e culturale dell’abbandono. Si possono citare, ad esempio, progetti di ricerca (Reuse, Artesalva), mostre («Recycle», a cura di Pippo Ciorra), convegni («Riutilizziamo l’Italia», Wwf), laboratori (Riusa, a cura di Giacomo Zaganelli; Laboratorio per la sussidiarietà) e campagne fotografiche: con «Nuovo Paesaggio Italiano» (2010) e poi con «Fatto in Italia», Oliviero Toscani ha concentrato la sua attenzione su costruzioni abusive, paesaggi disastrati e città informi, rinsaldando così il tema del paesaggio con quello dell’architettura di qualità e dell’abbandono dell’edilizia storica; altri si sono interessati al fenomeno dell’abbandono, ritraendo vecchie fabbriche in disuso, dimore disabitate, interni abbandonati («Atlas Italiae»; «Esibisco»). L’interesse civile, culturale e artistico per il «dismesso» sembra aumentare in parallelo alle operazioni di vendita e valorizzazione. Per quanto riguarda i beni di interesse storico-artistico, il federalismo demaniale culturale procede più lentamente: solo 67 immobili sono stati trasferiti agli enti locali, mentre 233 tavoli tecnici sono ancora aperti tra Demanio, Mibact ed enti locali. In questa procedura i Comuni sono sostanzialmente i principali destinatari dei tavoli tecnici per l’assegnazione dei beni demaniali.
 Il programma Valore Paese Fari punta a recuperare i fari e a riutilizzarli a fini turistico-ricettivi; a ottobre 2015 è stato pubblicato un bando di gara da parte dell’Agenzia del Demanio per 7 fari di sua competenza, scaduto a gennaio (dal Faro di Punta Imperatore a Forio d’Ischia, Na, al Faro di Capo Grosso nell’Isola di Levanzo-Favignana, Tp). Si attendono gli esiti delle valutazioni. Parallelamente anche Difesa Servizi Spa ha emanato un proprio bando per la gestione di 4 fari di sua competenza (da Faro di Capel Rosso nell’Isola del Giglio, Gr, al Faro di Capo Rizzuto, Kr). Un comunicato dell’Agenzia del Demanio (14 gennaio) informa che il bando ha riscosso successo da parte di imprenditori immobiliari e investitori esteri, ma anche di associazioni locali.
Il programma Valore Paese Fari punta a recuperare i fari e a riutilizzarli a fini turistico-ricettivi; a ottobre 2015 è stato pubblicato un bando di gara da parte dell’Agenzia del Demanio per 7 fari di sua competenza, scaduto a gennaio (dal Faro di Punta Imperatore a Forio d’Ischia, Na, al Faro di Capo Grosso nell’Isola di Levanzo-Favignana, Tp). Si attendono gli esiti delle valutazioni. Parallelamente anche Difesa Servizi Spa ha emanato un proprio bando per la gestione di 4 fari di sua competenza (da Faro di Capel Rosso nell’Isola del Giglio, Gr, al Faro di Capo Rizzuto, Kr). Un comunicato dell’Agenzia del Demanio (14 gennaio) informa che il bando ha riscosso successo da parte di imprenditori immobiliari e investitori esteri, ma anche di associazioni locali.
Il programma Valore Paese Dimore riguarda invece 200 beni, residenze storiche e immobili di pregio, distribuiti in centri storici e aree di interesse paesaggistico, con l’obiettivo di recuperarle dal punto di vista strutturale e di riutilizzarle per fini turistico-ricettivi. Gli strumenti a disposizione di questo programma sono la concessione di valorizzazione per periodi prolungati (fino a 50 anni), che prevedano aspetti di recupero e di sostenibilità economica, ma anche la vendita a fondi immobiliari o tramite gare a evidenza pubblica. Tra le proprietà statali sono in vendita il Castello di Gradisca d’Isonzo, il Forte Pianelloni di Lerici, alcune pertinenze del castello ducale di Agliè (residenza sabauda musealizzata, patrimonio Unesco dal 1997), il complesso minerario di Vigneria (Rio Marina, Isola d’Elba), una parte del Castello Orsini a Soriano nel Cimino, l’Istituto Filangieri di Napoli, il Convento di San Domenico Maggiore a Taranto.
Altro strumento sono i Programmi urbani di valorizzazione territoriale (Puvat), che riguardano più immobili e aree individuati in alcune città: per ora Bologna, Ferrara, Torino, Novara. Nel 2007 sono state avviate le analisi per i Puvat di Bologna e Ferrara che riguardano, rispettivamente, 19 e 28 immobili. A fine 2015 è stata sottoscritta una intesa interistituzionale tra il Comune di Ferrara e l’Agenzia del Demanio per l’attuazione del Puvat; a marzo 2015 per Bologna è stato firmato un accordo che prevede il coinvolgimento di Invimit Sgr Spa, una società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia. Per alcuni di questi programmi (Valore Paese Dimore, Valore Paese Fari, Puvat) l’Agenzia ha promosso consultazioni pubbliche; una si è conclusa molto recentemente, il 26 febbraio, per il convento dei Padri Riformati di Petralia Sottana (Pa), per individuare proposte e soggetti interessati a partecipare al riuso del complesso; in passato ne sono state avviate altre per palazzo Erizzo (Venezia) o per l’ex Arsenale di Pavia.