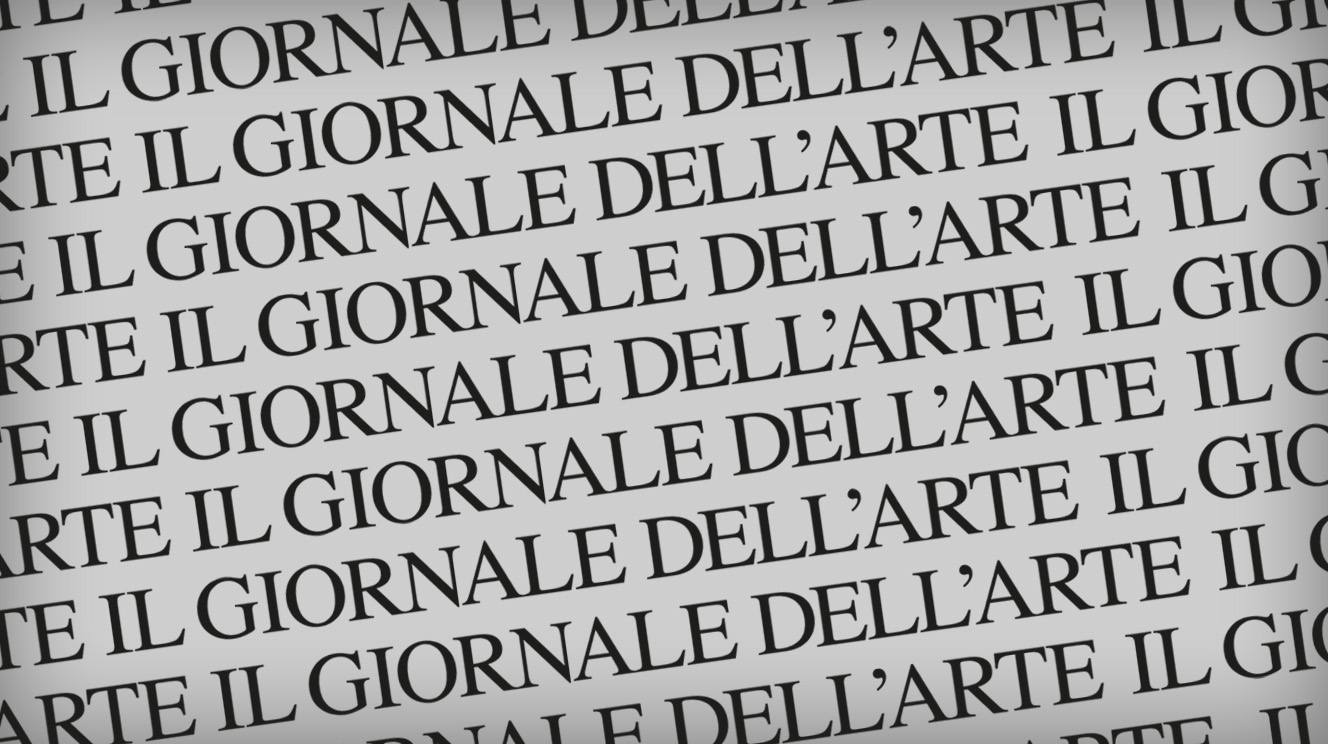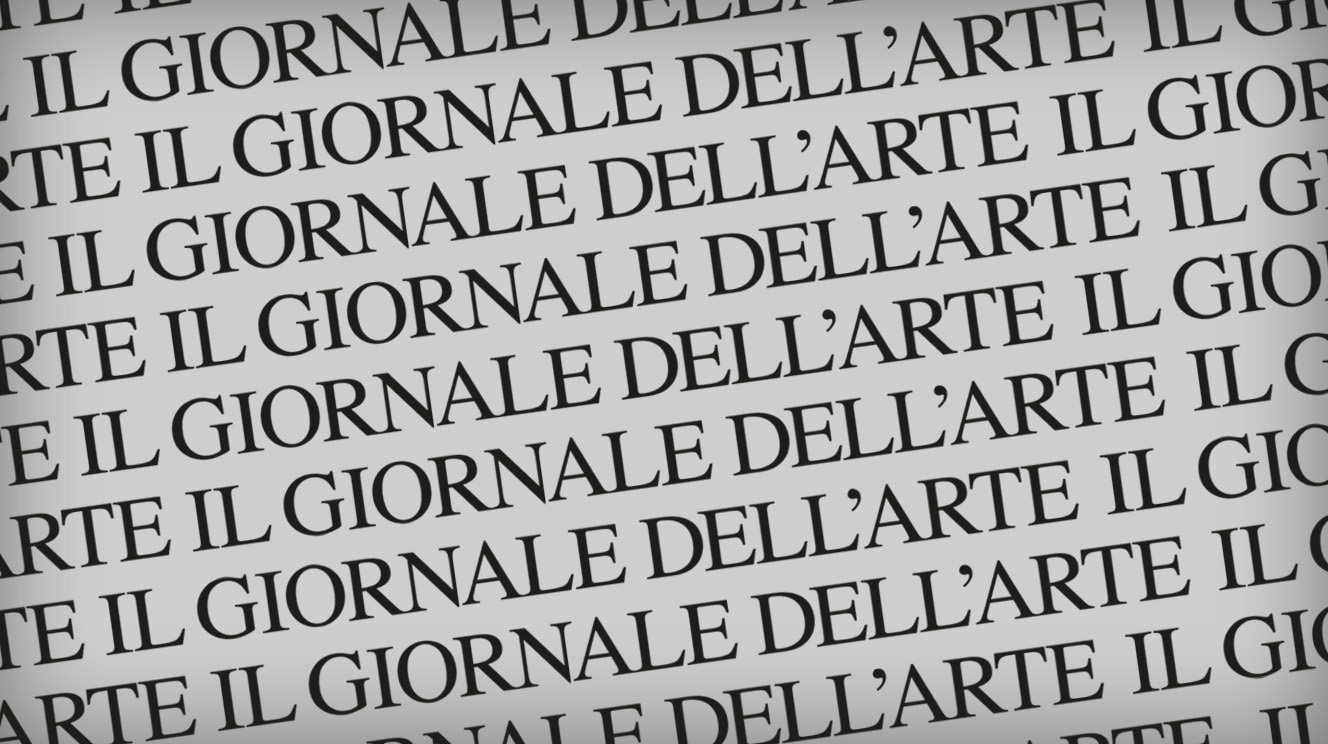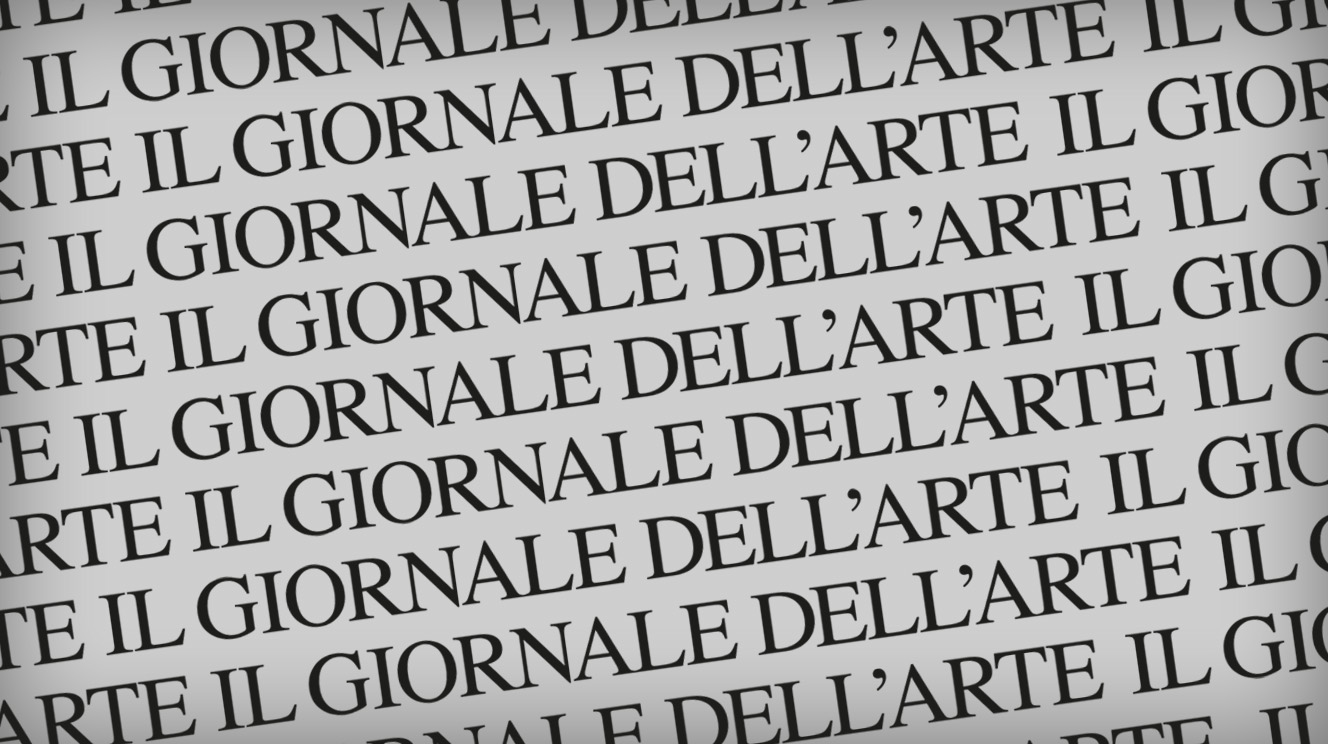Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Miriam Panzeri
Leggi i suoi articoliUna nuova fortuna attende il libro che Geoffrey Scott (1884-1929), studioso inglese membro della cerchia di Bernard Berenson a Firenze, pubblicò a Londra dapprima nel 1914 e, in seguito a un aggiornamento, nel 1924. Un fatto però rimane invariato: la traduzione eseguita nel 1939 da Elena Croce, figlia del filosofo Benedetto e moglie dello storico Raimondo Craveri. Già pubblicato da Dedalo, L’architettura dell’Umanesimo viene oggi riproposto da Castelvecchi, forse nella speranza di risuscitare qualche forma di dibattito storico e progettuale sull’architettura; perché, di fatto, non si discute propriamente o soltanto dell’architettura dell’età dell’Umanesimo tout court (che, per l’autore va da Brunelleschi a Palladio e che prosegue, nella progettazione inglese, per altri due secoli), bensì del concetto di architettura e del significato di cui essa, in quanto arte pensata dagli uomini per gli uomini, debba farsi portatrice. Dato alle stampe negli anni cruciali per la nascita della «architettura moderna», il saggio di Scott si interroga sulla via intrapresa dai progettisti negli ultimi decenni, a partire dalla diffusione del pittoresco, passando per la rinascita del Gotico, fino al Protomodernismo. Una chiara dichiarazione antiruskiniana, dunque, data alle stampe proprio quando gli scritti di Ruskin vedevano concretizzarsi le loro «lampade» nei disegni e nelle realizzazione di un gruppo di architetti innovatori e internazionalmente legati. Questa presa di posizione, unita alla vicinanza al formalismo nutrito dai sodali inglesi convenuti a villa I Tatti, costò all’opera la disapprovazione dei critici d’architettura connazionali, fino alla sua riscoperta (ma Henry-Russell Hitchcock non lo aveva mai dimenticato, pur nel riconoscimento di alcuni limiti, nel secondo dopoguerra: due tra le voci principali del pensiero architettonico, quelle di Bruno Zevi e Reyner Banham, diedero a Scott quel che gli spettava. Da una parte l’intuizione della realtà spaziale quale «pura negazione», dall’altra la riesumazione della «tradizione di un estetismo pedante» cui, tuttavia, bisogna guardare per comprendere alcuni processi, forse non sempre secondari, della progettualità. Ma se si estrae il discorso dal contesto in cui Scott concepì la sua teoria, possiamo leggervi la necessità di ritrovare una forma di bello consona allo spirito degli uomini, senza che questo fine distolga l’architetto dai doveri del costruire bene e secondo ragione; eticità e gusto possono, anzi devono accordarsi: una dottrina sempre valida. Purtroppo con quest’ultima riedizione si è persa l’occasione di dare il giusto approfondimento storico e critico alla figura di Geoffrey Scott, ancora poco conosciuta nella sua integrità poliedrica.
L’architettura dell’Umanesimo. Contributo alla storia del gusto, di Geoffrey Scott, traduzione di Elena Croce, 190 pp., Castelvecchi, Roma 2014, € 19,50