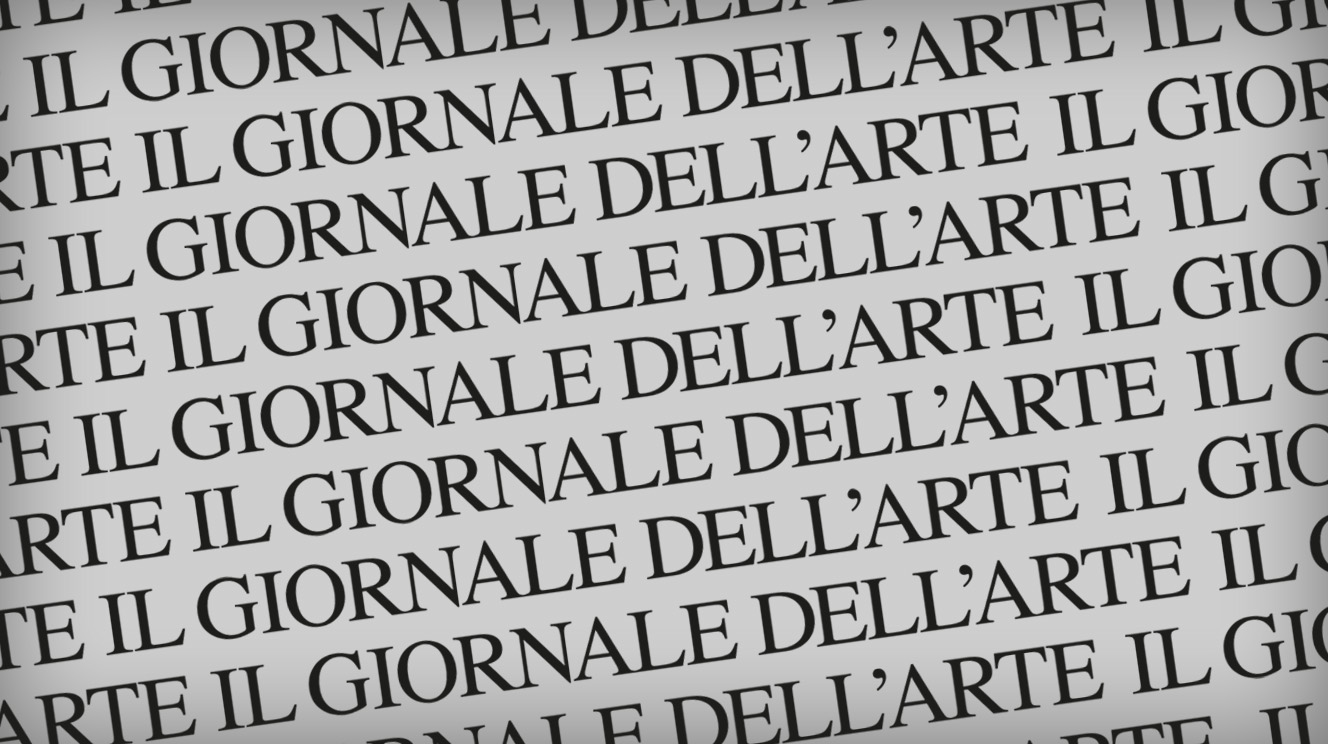Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Luca Scarlini
Leggi i suoi articoliLa vita e le imprese di Rodolfo Siviero (1911-83), lo si è detto più volte, sconfinano nel romanzo. Imprese, o avventure, in parte coperte dal segreto ufficiale. A gennaio, in concomitanza con l’uscita del film statunitense «The Monuments Men», basato sulla storia di un gruppo di storici dell’arte e curatori museali impegnati nel recupero di importanti opere d’arte trafugate dai nazisti (il film è diretto e interpretato da George Clooney), Skira manda in libreria Siviero contro Hitler. La battaglia per l’Arte, di Luca Scarlini, una ricostruzione del contributo del nostro «monuments man» a una causa cruciale: la messa in salvo del patrimonio artistico e il recupero e il rimpatrio delle opere trafugate dai nazisti durante l’occupazione. Ne anticipiamo un brano.
Dalla parte di Siviero: la relazione con Roberto Longhi
Siviero non era uno storico dell’arte, ma aveva sempre studiato la materia e ne conosceva benissimo i massimi cultori. Roberto Longhi, scrittore sommo, fu a lungo in contatto con lui e i loro destini furono connessi in modi non facilmente ricostruibili nel tempo della guerra e del dopoguerra. Nel 1947 Longhi introdusse un suo scritto nel bollettino dei Lincei e in un articolo su «Paragone» del 1950 («Recupero di un Masaccio») celebrava «l’energia» del nostro. Nella notevole raccolta postuma destinata a raccogliere gli interventi sul tema Critica d’arte e buon governo, il nome di Siviero compare spesso nell’indice. Gli interventi longhiani su «Paragone» e su altre testate danno conto dei vari momenti dell’attività del nostro. Nel 1957 un articolo intitolato «Le fatiche d’Ercole e di Siviero», su «L’Europeo», indica come le relazioni della commissione italiana con i colleghi tedeschi fossero tese. Passato il primo momento di urgenza postbellica, la burocrazia teutonica, coadiuvata dagli storici dell’arte, aveva fatto di tutto per tenere le opere in Germania. Longhi in quell’articolo indicava che agli Uffizi mancavano ancora all’appello un ritratto di Lorenzo di Credi, una natura morta di van Huysum e le Fatiche di Ercole (da cui il titolo ironico) di Antonio del Pollaiolo. Longhi sostenne poi fortemente il riconoscimento di una medaglia per Siviero da parte «degli artisti e degli scrittori italiani», come riassume nella sua Relazione all’Accademia Nazionale dei Lincei nel 1961.
Longhi sottolineava giustamente che le attività della Delegazione erano state spesso ad alto rischio: nel corso delle operazioni per riprendere le opere ai nazisti erano morti Bruno Bècchi, pittore che incrociava curiosamente Rosai e la lezione del surrealismo, e il sergente maggiore Rino Cioni.
Il maestro dopo la seconda guerra mondiale fu abilissimo nel far dimenticare il suo passato. Longhi a lungo aveva avuto un legame privilegiato con il ministro Bottai, intrecciato a doppio filo a quello con il suo patron, Sandro Contini Bonaccossi, mercante d’arte e suo complice di mille avventure per quasi un trentennio. Longhi, per tramite dell’antiquario, aveva contatti con il mondo nazista ed era in relazione con l’antiquario Ventura, vicino a Göring, ma poche sono le tracce rimaste di questo momento.
Il solo che parla esplicitamente di questi aspetti è Federico Zeri, nella sua memoria, scritta con Patrick Mauriès, Confesso che ho sbagliato, in cui dedica una pagina assai esplicita all’argomento, nella sezione che celebra lo storico dell’arte tra ammirazione e rancore. «Longhi fu al fianco di Contini anche nelle sue transazioni con Hermann Göring, cosa che tutti sapevano all’epoca, ma che egli si guardò bene dal ricordare quando Contini ebbe a giustificarsi dopo la guerra».
In un altro punto del libro egli rievoca un caso legato a una sua presenza come inviato ufficiale del Governo fascista all’estero. «All’estero non incantava nessuno. Voglio ricordare per esempio il congresso di storia dell’arte, che si tenne a Londra nel 1939 e nel quale egli doveva prendere la parola. Arrivato alla sede del congresso, si accorse che il suo intervento era previsto dopo quello di Lionello Venturi, antifascista dichiarato che aveva preferito andarsene dall’Italia piuttosto che restare sotto il regime. Longhi fece una scena terribile e disse che prima di parlare al congresso gli era indispensabile avvertire il suo ministro Bottai. (...) Erwin Panofsky oppure Frederik Antal non avevano nessuna stima di lui: il primo mi domandò con sospetto se io fossi davvero un amico di Longhi, che egli non citò mai né nel testo né nelle note delle sue opere. Quanto ad Antal mi ricordo ancora dell’espressione di disprezzo e di collera con la quale durante una mostra a Milano nel Palazzo Reale nel 1950 o ’51, egli si avvicinò a Longhi domandandogli davanti a tutti se non avesse vergogna di essere uno storico dell’arte italiano e per giunta di sentimenti fascisti dopo le distruzioni che la guerra aveva causato ai tesori d’arte della penisola. Io vidi Longhi allontanarsi con le lacrime agli occhi, il viso contratto in un’espressione di freddo odio».
Dalla parte di Siviero? I benefici paradossi del console Gerhard Wolf
Siviero nel corso del frenetico anno e mezzo che mise a dura prova il patrimonio artistico di Firenze, poté contare anche sulla collaborazione di un complice insospettabile, che si adoperò in molti modi per salvare i monumenti della città. Per quanto però i due sembrassero operare dalla stessa parte, il nostro non lesinò a Gerhard Wolf (1896-1971), console della città, accuse di doppiogiochismo. Comunque sia stato, la Storia li ha accomunati e il gentleman germanico che aveva studiato all’università con Heinrich Wöllflin, venne insignito da Giorgio La Pira della cittadinanza onoraria nel 1951 e opportunamente ricordato da una lapide che qualche anno fa è stata posta sul Ponte Vecchio. Esprimeva poche simpatie per i nazisti, con cui aveva relazioni complesse e difficoltose. Amava molto la città, e fece di tutto per proteggerla, come si adoperò quando poté per difendere gli uomini della resistenza, gli ebrei e per proteggere la famiglia del principe Rupprecht, ultimo dei Wittelsbach, particolarmente inviso al Führer, di cui non aveva sostenuto il Putsch monacense del 1923. Egli fu anche vicino ai parenti fiorentini dei Savoia, riuscendo ad aiutare una parte della famiglia, che poté fuggire in Svizzera, senza essere sottoposta all’esperienza del campo di concentramento. Hitler, d’altra parte, aveva espresso un suo parere favorevole esplicito a una richiesta ufficiale inviata dall’ambasciatore di Romania, Nicolae Petrescu-Comnen, che gli aveva inviato un’accorata richiesta di salvezza per la città, in una missiva scritta nella splendida dimora di Villa Machiavelli, quella che chiamava «il suo bel Majano» in alessandrini perfettamente torniti. Il culmine della sua prosa, chiariva un modo di sentire comune e condiviso: «Si Rome est la ville de la Foi, Florence est incontestablement la ville de la Beauté». Il messaggio era stato recapitato da Wolf, e la risposta era giunta per tramite dello scherano Alfred Jödl, capo di stato maggiore dell’Oberkommando della Wehrmacht, fornendo ampie rassicurazioni. Il testo hitleriano nella sua calcolata ambiguità vale la pena di essere citato estesamente. «Da quando una più forte offensiva terroristica nemica sulle città dell’Alta Italia e della Centrale si è delineata, il Führer, onde non omettere alcuna misura per la protezione della città di Firenze, la cui conservazione è considerata dalla Germania come uno dei più alti doveri che incombono alla cultura europea, ha ordinato l’evacuazione da Firenze di tutti gli uffici militari tedeschi superflui. E per quel che riguarda la constatazione delle necessità di una residenza in Firenze, si è provveduto ad adoperare una misura insolitamente severa. Inoltre, salvo per insignificanti casi eccezionali, è stato proibito agli appartenenti alla Wehrmacht di visitare Firenze. (...) Noi abbiamo troppi esempi della distruzione brutale di importanti luoghi culturali da parte dei sistemi terroristici del nemico senza che avessero nessun valore militare, e ciò lo debbo dire con mio vivissimo personale rimpianto, perché io possa non avere altro che poca speranza che Firenze possa uscire intatta da questa guerra. Ciò premesso, la Wermacht germanica continuerà ad applicare tutti i suoi sforzi e le sue misure di cautela onde non fornire all’avversario alcun motivo militare per assalire questo gioiello di Europa».
Wolf era legato a Kriegbaum, morto in uno dei primi bombardamenti alleati e aveva ben chiara la complessità dell’intervento nella città, in cui poteva agire allo scoperto con il sovrintendente Poggi, mentre le relazioni con il gruppo di Siviero dovevano giocoforza essere clandestine. Pochi giorni prima della liberazione, egli lasciò la città con gli sconfitti affrontando il proprio destino, ma molti scrissero accorate lettere a suo favore. In primo luogo Bernard Berenson, che nell’anno dell’occupazione aveva incontrato nel suo rifugio della villa dei Serlupi. Iris Origo, amica di lunga data di Berenson, così ricorda l’impegno di Wolff e Wildt: «Due persone particolarmente umane, hanno fatto forse più di qualsiasi italiano, negli ultimi mesi dell’occupazione germanica per salvare persone innocenti, e anche per proteggere le case e le opere d’arte d’Italia. Hanno agito con grande coraggio, provocando gravi sospetti nell’animo dei loro compatrioti». Sulla stessa linea sta anche il grande direttore Vittorio Gui: «Se durante l’occupazione tedesca, ogni città italiana avesse avuto un “tedesco” come il console Wolf, quanti tormenti e dolori ci sarebbero stati risparmiati».
La voce furente e scomposta di Dante Virgili, forse il solo scrittore nazista italiano, nel suo notevole La distruzione (1970), conferma da destra la storia di Wolf salvatore delle opere d’arte riassumendo così la vicenda dal punto di vista di un fedelissimo dell’ordine nero: «A Berlino si voleva il combattimento fino all’estremo. Von Vietinghoff si difenda fino all’ultima goccia di sangue questo il mio ordine. (...)». Invece, quelli che si imposero furono: «Intellettuali, esteti. Salvare i dipinti degli Uffizi oggi valgono trecento miliardi ecco un colpo degno di un uomo scaltro».
Siviero contro Hitler. La battaglia per l’arte, di Luca Scarlini, 192 pp., ill., Skira, Milano 2014, € 16,00
Altri articoli dell'autore
L’arte per il poliedrico scrittore e artista vicentino è il fulcro di un interesse che coltiva sin dalla giovinezza, per comparire come filo rosso lungo tutta la sua attività editoriale
A partire da cammei autobiografici e racconti degli artisti effigiati, un libro con le storie di una serie di copertine celebri della storia del rock
Pubblichiamo in anteprima una brano dell’autobiografia di Luca Scarlini, in uscita per Bompiani
Il conte dadaista in 26 minimonografie di Andrea Cortellessa