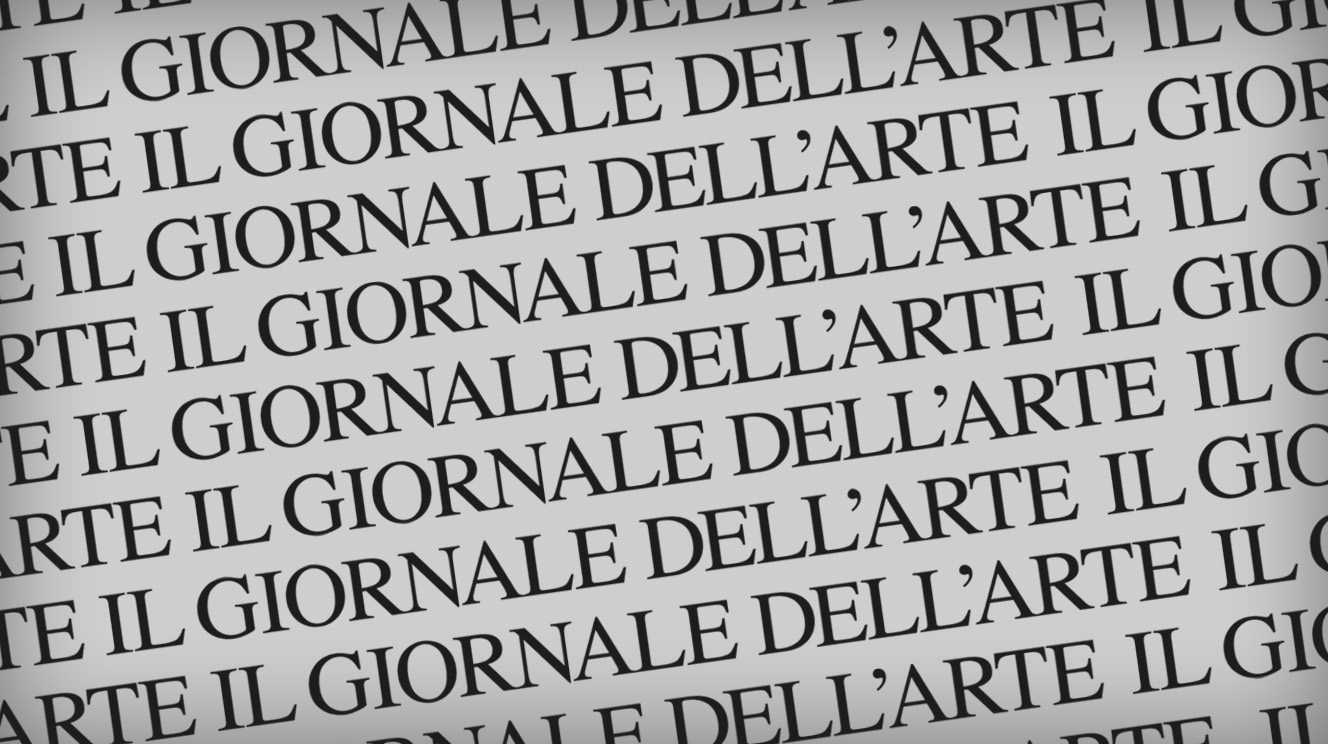Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Lemme
Leggi i suoi articoliContinua il dibattito sulle differenze tra restauro e contraffazione
Nel dicembre 1992, scrivendo su questo giornale (ho l’onore di esserne tra i più vecchi collaboratori), affrontai il tema del rapporto tra restauro e contraffazione, tema sul quale vorrei ora ritornare, per verificare, dopo ventitré anni, quanto ci sia di attuale e quanto di caduco nel mio sforzo di allora di trovare una coerenza concettuale nelle leggi in difesa del patrimonio culturale.
Il punto di partenza di tale complesso problema era costituito dall’articolo 8 della legge 20 novembre 1971 n. 1062 (cosiddetta legge Pieraccini, dal nome del suo proponente, il senatore Giovanni Pieraccini) che, nella chiusura del primo comma, così recitava: «Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli... non si applicano… ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale».
Da tale norma si argomentava, a-contrario, che un restauro attraverso il quale l’opera d’arte fosse stata «ricostruita in modo determinante» dava luogo a un fatto di reato, punito sotto il titolo della contraffazione (oggi, art. 178/1 lett. a) decreto legislativo 42/04, che recepisce l’art. 3, primo comma, della legge 1062-1071). E ci si chiedeva, in sostanza, quali fossero i limiti entro i quali il restauro non comportava tale «ricostruzione in modo determinante». Nell’articolo citato, io proponevo di considerare determinante quel restauro che avesse inciso, snaturandola, sulla trama compositiva dell’opera d’arte.
A distanza di quasi ventitré anni, la norma prima riportata ancora esiste nel nostro ordinamento: essa costituisce oggi l’ultima parte dell’art. 179 cit. decreto legislativo 42/04. E me la sento di ribadire quel concetto, anche se non mi nascondo che, come sempre, ogni definizione rimanda a un’altra: nella specie, in che cosa consiste la «trama compositiva»?
Per tentare di arrivare a una nozione esaustiva al riguardo, sarà forse necessario premettere, in modo schematico, alcuni concetti fondamentali:
- il restauro non riguarda solo l’arte figurativa, ma l’arte in tutte le sue forme: i testi poetici e letterari, spesso, almeno quelli antichi, lacunosi e incompleti; i testi musicali (troppi spartiti risultano contraffatti o lacunosi); perfino le pellicole cinematografiche, avariate con il decorso dei decenni. Quindi, quel che affermiamo per il restauro nell’arte figurativa ha una valenza generale;
- il restauro non tende «a riportare l’opera d’arte allo stato originario», come affermato in alcuni, anche autorevoli, manuali del diritto dei Beni culturali, a meno che non si precisi che «stato originario» non corrisponde all’iniziale invenzione artistica ma a come la stessa si sia evoluta e storicizzata: concetto sul quale potremmo essere d’accordo, con le precisazioni che seguono;
- il restauro non tende al ripristino del «messaggio ideale» o «messaggio poetico» del bene culturale, come affermano talune sentenze della Corte Costituzionale: l’opera d’arte si evolve nei secoli, con una capacità di attualizzarsi e di modificarsi con il mutamento del contesto storico. Si prenda l’Amleto di Shakespeare, testo poetico che, nel corso dei secoli, ha acquistato per i lettori significati nuovi e totalmente diversi;
- il restauro tende in sostanza a ripristinare la mutevole godibilità del bene culturale, ma senza incidere sulla sostanza creativa di esso: dunque, la trama compositiva si risolve nella godibilità del bene culturale percepita attraverso la struttura che ne ha consentito la realizzazione e ne costituisce l’essenza poetica.
Nell’Ottocento, due diverse concezioni del restauro si affermarono e furono praticate, nel campo dell’architettura: in Francia, quella di Eugène Viollet-le-Duc (1814-79), che adattava il bene architettonico ai tempi e ai gusti contemporanei, al punto di inventare il falso antico dei castelli della Loira e addirittura una falsa città medievale quale Carcassonne. In altri termini, un Medioevo di cartapesta, quale lo concepiva il mondo tardo romantico; in Inghilterra, quella di John Ruskin (1819-1900), per il quale la rovina andava preservata da ulteriore degrado ma non certamente ripristinata.
Nell’attuale momento storico, siamo molto più vicini a John Ruskin che a Viollet Le Duc, le cui trovate, al più, fanno benevolmente sorridere e torna attuale una massima che risale addirittura all’Alto Medioevo (sembra ne sia autore Ildeberto di Lavardin, nato nel 1056 e morto nel 1133, arcivescovo di Tours): «Roma quanta fuit ipsa ruina docet».
Oggi, a distanza di oltre quarant’anni, la Carta del Restauro, redatta da Cesare Brandi e dotata di forza normativa (venne diramata a tutti i soprintendenti e capi di istituti autonomi dal Ministero della Pubblica Istruzione, con circolare 117 del 6 aprile 1972) continua a costituire un punto di riferimento fondamentale, per risolvere il problema dei limiti del restauro, con tutte le sue proposizioni (artt. da 1 a 12) e i suoi allegati (a, b, c, d). Ma anche al riguardo occorrono un distinguo e un’accortezza.
La Carta del Restauro è un punto di riferimento ma non racchiude la soluzione di tutti i problemi: essa va infatti letta con intelligenza e non assunta acriticamente come «verità rivelata», alla stessa maniera della Bibbia o del Corano. Infatti, nell’ambito del bilanciamento di interessi, che costituisce la regola fondamentale dell’interpretazione giuridica, non è possibile ignorare altre esigenze, che sono date dal vivere civile, come si concepisce ai nostri giorni. Chi potrebbe criticare le aperture praticate nelle romane Mura Aureliane, per consentire il passaggio di mezzi pubblici, certamente non immaginabili quando l’imperatore Aureliano (214-275 d.C.) ne curò la realizzazione?
Il mutato contesto di riferimento impone dei sacrifici e a essi non si sottrae il pregevole testo elaborato da Cesare Brandi, sforzo di pensiero certamente importante ma che non può soffocare o impedire lo sviluppo dei tempi.
Altri articoli dell'autore
I beni culturali possono essere dichiarati di particolare interesse solo se la loro esecuzione risalga ad almeno cinquant’anni
La capacità (e l’obbligo) di correggersi della Pubblica Amministrazione
Va introdotta una distinzione tra ricerca significativa e ricerca inutile: la prima aggiunge qualcosa alle conoscenze già acquisite, la seconda si limita a riproporre il «déjà dit»
Il conflitto tra Russia e Ucraina mette in luce un relativismo che parte da Giovanni Battista Vico