
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Silvia Mazza
Leggi i suoi articoliSettis o Volpe, ma anche siciliani come Merlo o Buttafuoco vorrebbero vederla abrogata, mentre tra i fautori ci sono pure insospettabili come il politologo americano Luttwak: stiamo parlando dell’autonomia siciliana, che sul banco degli imputati dovrebbe salire più perché rimasta sostanzialmente sulla carta e non perché sbrigative letture «deformanti» di fatti storici capitali per la regione la additano come causa di ritardi e criticità di ogni sorta che ne hanno sancito il regresso nel panorama nazionale, ma che poco hanno a che vedere con la specialità siciliana. È vero, invece, che proprio nel settore dei Beni culturali essa offra uno dei rari settori di applicazione, con esiti persino positivi e anticipatori di scenari riformistici che solo di recente si sono registrati in ambito statale. Freccia tesa nell’arco e mai fatta scoccare, quella della competenza esclusiva in materia di beni culturali, di cui la regione gode da quando le fu trasferita dallo Stato nel 1975, unica anche tra quelle a statuto speciale, è la storia di oltre un quarantennio di premesse e promesse che non si è saputo e voluto sviluppare nella loro carica innovativa.
A questi temi, di estrema attualità perché sul «modello siciliano» è esemplata la riforma Mibact voluta da Franceschini nei suoi due passaggi qualificanti, quello delle soprintendenze uniche, introdotte in Sicilia dalle leggi fondamentali nel settore del 1977 e 1980, e quello degli istituti autonomi secondo il «modello Granata» del 2000 per i parchi archeologici e del 2002 per i musei (caso pilota del Riso a Palermo), un modello autonomistico che non separa come nel Mibact tutela e valorizzazione, è dedicato un intero capitolo di «Redimibile Sicilia. L’autonomia dissipata e le opportunità dell’insularità» (Rubbettino), di Gaetano Armao, docente di Diritto amministrativo e Contabilità pubblica all’Università di Palermo, già assessore regionale all’Economia e ai Beni culturali.
La competenza esclusiva siciliana in materia di beni culturali: una questione mal posta
Perché, dunque, la Regione dovrebbe rinunciare a quella competenza esclusiva grazie alla quale ha anticipato la recente stagione riformistica statale, e non di qualche anno, ma in un caso di quasi mezzo secolo e nell’altro di oltre tre lustri? Le leggi appena citate la regione se l’è potute dare proprio perché gode di potestà legislativa primaria. Norme giuridiche. Ma non solo. È in virtù di questa competenza che sono state scritte le Linee guida per il Piano paesaggistico regionale del 1999 (il primo Piano paesaggistico adottato nel 2002, quello delle Egadi), mentre è solo da qualche anno che si hanno nel resto del Paese i primi Piani paesaggistici (Puglia, Toscana e Piemonte); che è stata istituita l’unica Soprintendenza del Mare in Italia (2004); che si è registrata la prima sponsorizzazione (2003), la prima concessione d’uso a un’associazione non profit (1999). E ancora, i musei siciliani da ben prima (dalla fine degli anni Ottanta) dell’entrata in vigore della riforma Franceschini (dicembre 2014) sono autonomi amministrativamente, gestiscono in proprio la programmazione, insomma non sono uffici delle soprintendenze, come lo erano i musei statali. E se le soprintendenze siciliane non sono sottoposte alle prefetture come stabilito dalla vergognosa Legge Madia è perché l’applicazione di quest’ultima si ferma allo Stretto di Messina. Primati, questi e altri, i cui sviluppi sono stati soffocati dalla mala politica, la vera causa delle degenerazioni prodotte nel momento della traduzione in pratica del modello teorico e, più in generale, della situazione di paralisi che ha condannato la Regione all’immobilismo, o peggio, all’involuzione. E cosa c’entra, ancora, l’autonomia con l’ingerenza politica nei Beni culturali siciliani? Se anche nelle altre regioni gli scenari sono questi, e non altro denunciavano i dipendenti Mibact nell’appello del 24 agosto 2015 al presidente Mattarella, cioè che nella riorganizzazione ministeriale invece che tenere debitamente conto delle competenze di carattere tecnico si era ricorso ad «altri» criteri delle nomine. E per menzionare ancora un altro cavallo di battaglia dei detrattori, che cosa c’entra l’autonomia con il ritardo nell’uso dei fondi europei? Se almeno fino al 2013 era l’Italia nel suo insieme a scontare, con appena il 40% di fondi comunitari complessivamente spesi fino ad allora, un ritardo che la piazzava tra gli ultimi posti in classifica, terz’ultima nazione in Europa, meglio soltanto di Bulgaria e Romania. Tra le regioni del Sud, la Sicilia è stata in buona compagnia della Campania, Regione a statuto ordinario. Regione in cui un’inchiesta condotta da un pool di pm della Dda ha fatto finire ai domiciliari, tra gli altri, anche la sovrintendente ai Beni culturali di Napoli Adele Campanelli. Giusto per ricordare solo uno dei fatti di cronaca più recenti di prossimità tra politica, malaffare e beni culturali in una regione «ordinaria».
Politica culturale e politica economica: il binomio possibile
Ma prima ancora di sfogliarlo, il libro di Armao è tutto in quell’immagine di copertina, che, perfetta, traduce visivamente i due termini dell’antinomia del titolo: il «Cretto» di Burri a Gibellina (Tp), recentemente restaurato e completato, preso a «simbolo, si legge nella didascalia, di come dalla distruzione e dall’abbandono possano scaturire cultura e sviluppo». Che un ex assessore ad entrambi rami abbia chiaro che l’assessorato ai Beni culturali debba essere in Sicilia il secondo assessorato all’Economia è la risposta «bifronte» che finora la politica non aveva dato alla ormai famosa volgare battuta del suo «collega» Giulio Tremonti, che da ministro del Tesoro disse «di cultura non si vive, vado alla buvette a farmi un panino alla cultura, e comincio dalla Divina Commedia». Come ha scritto Carlo Tosco (il Mulino, 2014) «ogni politica culturale comporta una politica economica», con la ineludibile premessa che «il valore culturale del bene è sovraordinato a qualsiasi altro valore, anche a quello economico». A tal riguardo Armao cita, in particolare, l’art. 4 della Convenzione Unesco del ’72, sull’obbligo degli Stati «di garantire l’identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale». «La conseguenza, spiega il giurista, è una più decisiva valorizzazione della sfera pubblica in opposizione alla sfera privata del mercato, che sia finalizzata a sollecitare la sottrazione di certi beni alla logica della negoziazione e della competizione, in vista della difesa di interessi comuni di conservazione e valorizzazione all’umanità intera».
Contributo dei privati, siti Unesco, Consiglio Regionale dei Beni culturali, parchi archeologici, art. 14 dello Statuto: potenzialità della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale siciliano
Soffermiamoci ancora su alcuni temi chiave trattati nel capitolo dedicato alle «potenzialità della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale siciliano». Tra questi, il partenariato pubblico-privato nella valorizzazione del patrimonio, in cui l’autore ripercorre la vicenda dei bandi dei servizi al pubblico con i quali da assessore sette anni fa aveva anticipato lo scenario Mibact, poi annullati illegittimamente nel 2013 da Crocetta e solo di recente assegnati dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale (2015). A proposito dei siti della World Heritage List (Armao è stato presidente della Fondazione Unesco-Sicilia), di cui la regione detiene tra le altre il più alto numero di riconoscimenti, dieci, con l’ultimo, quello del percorso arabo-normanno di Palermo-Monreale-Cefalù (2015), il cui procedimento fu avviato sempre sotto il suo mandato, sottolinea « la scarsità di strumenti organizzativi che possano garantire il coordinamento degli interventi e degli incentivi», e la «singolare dicotomia» tra il primato di cui si è detto e «l’incapacità di utilizzarli come leva di sviluppo». Del Consiglio regionale Beni culturali, «organo di alta amministrazione capace di contribuire alla definizione della strategia in materia di beni culturali», viene denunciata la mancata ricomposizione (avvenuta solo di recente, non sono stati ancora resi noti i nominativi; ma sulla «qualità» dell’organo riformato cfr. la nostra denuncia sottoscritta da Legambiente e Italia Nostra) e la commistione tra politica e amministrazione in un organo che dovrebbe essere consultivo a carattere tecnico-scientifico («i politici potranno esplicare la loro influenza sminuendo la rilevanza di quello tecnico»), occasione per ricordare la proposta di revisione dell’arcaica composizione che il professore avanzò in qualità di assessore nel 2010 e che lo avrebbe avvicinato al corrispettivo Consiglio Superiore del Mibact. In particolare, tra le rilevanti funzioni attribuite a quest’organo l’ex assessore sottolinea come «in spregio alle previsioni di legge (Legge Granata 20/2000 ndc.) e ai principi di buona amministrazione l’attività istitutiva dei parchi e la relativa perimetrazione si è svolta in carenza dell’apporto consultivo del Consiglio» (anche su questo tema cfr. la nostra inchiesta).
Soprattutto, Armao ricorda un passaggio quasi sconosciuto, che l’art. 14 dello Statuto siciliano attribuisce alla Regione competenze in materia «di ampiezza tale che non è dato riscontrarne di analoghe in altre Regioni». A cui vorremmo aggiungere la considerazione che già due anni prima della Costituzione repubblicana, nel 1946 lo Statuto attribuiva alle competenze della regione la «tutela del paesaggio» (art. 14, lett. n. dove compare il termine «paesaggio», mentre le leggi del 1922 e del 1939 parlano ancora di «bellezze naturali»), e ad esse accosta la «conservazione delle antichità e delle opere artistiche», identificabili con quei «beni culturali» definiti giuridicamente quasi mezzo secolo dopo dal Testo Unico del 1999 (art. 1 e art. 2 cc.2), e quindi dal Codice (art. 2, c. 2). Fatto di assoluto rilievo, inoltre, lo Statuto, legge di rango costituzionale, non solo annovera la tutela, ma la inserisce tra i suoi principi fondamentali. E senza precedenti, perché non registrabile nelle due Costituzioni menzionate da Settis come antesignane della nostra Costituzione in riferimento all’art. 9: quella della Repubblica di Weimar, del 1919 e quella della Repubblica Spagnola, del 1931. E ancora in ambito normativo, della legge 1977/80 che ha disegnato l’architettura dei bbcc nella regione l’autore analizza gli elementi innovativi rispetto all’allora legislazione statale. Primati con i quali non si vuole certamente sostenere che non occorra una revisione e un aggiornamento organico di tutta la legislazione siciliana dei bbcc. Significativo è che il giurista parli prima ancora di una «arretratezza culturale» dei rappresentanti delle istituzioni.
Potenzialità di un’autonomia dissipata: la Sicilia è redimibile?
Nel suo complesso il libro offre un serio approfondimento delle maggiori questioni di un’autonomia «mancata» e «dissipata» come delle «potenzialità che ancora residuano per ipotizzarne il rilancio» e giustificare ancora un regime differenziato a settant’anni dall’approvazione dello Statuto e dopo la proposta di revisione che aveva trovato nuovo rilancio dal pur controverso percorso di riforma costituzionale bocciato dal referendum 2016. Le cause, più esogene che endogene, sono indagate in un’efficace sintesi della parabola dell’esperienza della specialità siciliana, letta nelle sue opportunità che non si è saputo cogliere come nelle «patologie» che si sono manifestate nella fase attuativa, una riflessione che parte dalla genesi dello Statuto, che una stanca litania non verificata sui fatti storici vorrebbe ancorare esclusivamente a un particolare clima socio-politico del dopo-guerra, dimenticando tutto un fermento costituzionale dal 1812 al 1860 animò «il confronto sull’autogoverno della Sicilia», per arrivare alla legislatura che sta per concludersi.
E allora, è un’autonomia rimasta sostanzialmente lettera morta il problema o la cattiva declinazione che se n’è fatta finora? «Il giudizio di sostanziale inadeguatezza dell’esperienza maturata» implica che la strada sia, si chiede Armao, quella sbrigativa della soppressione o si può ancora pensare a una riforma e «ripensamento con l’adozione di modelli innovativi»? E se d’un colpo la si abrogasse, la Sicilia che vanta il parlamento più antico d’Europa si ritroverebbe anche il migliore? Piuttosto bisognerebbe chiedersi con Armao l’autonomia senza «responsabilità» fiscale che autonomia è? E, per altro verso, l’autonomia in mano a una classe politica «irresponsabile», mediocre, corrotta e affarista dove ha condotto la Sicilia?
Uno Statuto dunque disapplicato, ma anche sostanzialmente misconosciuto: i siciliani non lo conoscono, non lo hanno studiato a scuola né all’università (funzionari e tecnici dei Beni culturali vi familiarizzano con la pratica, non attraverso dottorati o scuole di specializzazione), né tanto meno sentono probabilmente la necessità di conoscerne i contenuti, come qualcosa che possa invece avere ricadute pratiche nella vita quotidiana. Un’ignoranza che di fatto gli impedisce di accedere alla riappropriazione della propria autodeterminazione. Così non solo l’applicazione della Carta fondamentale siciliana, ma anche la sua necessaria revisione per «accrescerne, scrive Armao, il rendimento istituzionale» e per «garantire un effettivo coordinamento con il quadro costituzionale, in particolare europeo, estraneo all’attuale stesura», necessiterebbe, per non restare arida operazione chiusa nel palazzo qualora veramente vi si porrà mano, del sostegno di un’opinione pubblica consapevole. In tal senso non può non essere capitalizzata la volontà di espressione manifestata nel dissenso alla riforma costituzionale con una delle più alte percentuali di partecipazione del Paese. La nuova auspicata stagione costituente alla quale il libro offre molteplici e inedite riflessioni non può prescindere, dunque, come invece avvenne alle origini, da una forte legittimazione democratica.

Gaetano Armao
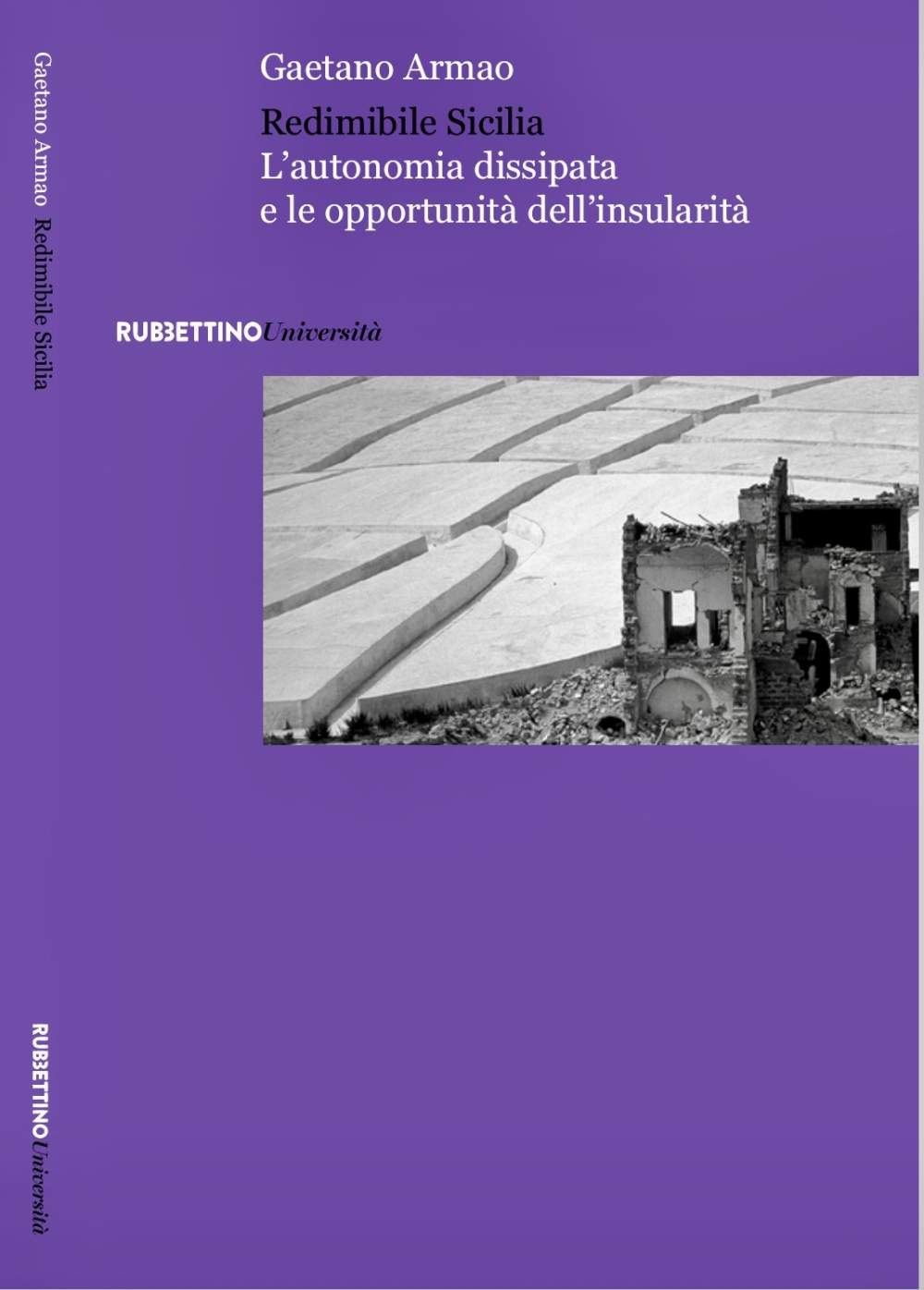
Copertina di Redimibile Sicilia di Gaetano Armao

Parco archeologico di Selinunte
Altri articoli dell'autore
La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera
Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni
Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma
Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.



















