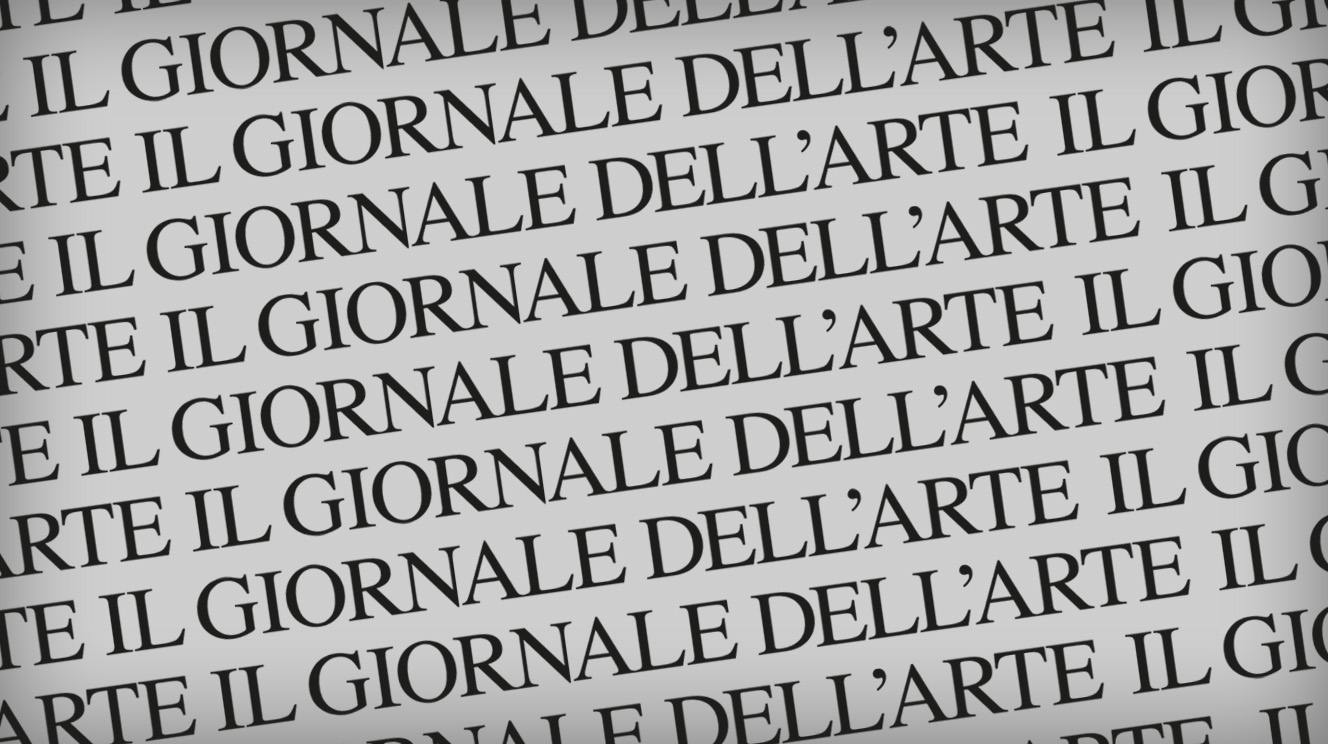Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Biferali
Leggi i suoi articoliTreviso. Quando il ventiseienne Domínikos Theotokópulos approdò a Venezia, nei primi mesi del 1567, la città era in una fase di grande fermento artistico. Se Iacopo Tintoretto era impegnato nella sala dell’Albergo della Scuola di San Rocco, il primo degli ambienti da lui decorati nella fastosa sede della più ricca tra le Scuole grandi, Paolo Veronese si dedicava all’impresa altrettanto ciclopica della decorazione dei soffitti e delle pareti della chiesa di San Sebastiano. Tiziano invece, il grande vecchio al servizio della Repubblica di San Marco da oltre mezzo secolo, era all’epoca proiettato oltre il perimetro della committenza pubblica di Venezia, sempre pronto a esaudire le fameliche richieste di opere sacre e profane che gli giungevano dalla corte asburgica di Filippo II di Spagna.
Non è forse nemmeno lontanamente immaginabile il vero e proprio shock professionale che dovette subire al suo arrivo in laguna il giovane artista cretese, il «maistro Domenego» che il 26 dicembre 1566, nella natìa Candia, si affannava a mettere all’asta un suo dipinto raffigurante la «Passione di Cristo» pur di racimolare il denaro utile all’imminente trasferimento a Venezia.
Il rapporto tra la famiglia di Domínikos e la Dominante, del resto, era allora già piuttosto solido, sol che si pensi al fatto che il fratello del pittore, Manussos, ricopriva da tempo il ruolo di funzionario di fiducia del governo veneziano a Creta. Giunto nella città marciana con le credenziali di artista di una certa notorietà, tanto da essere designato in patria con l’etichetta di «sgúrafos», ossia maestro dotato di una propria bottega, Domínikos nel 1567 era esclusivamente un pittore di icone tradizionali in stile greco-bizantino, eseguite secondo un gusto che a Venezia era stato spazzato via da almeno un secolo dalla maniera moderna di Giovanni Bellini.
Il geniale pittore cretese non impiegò molto tempo ad appropriarsi con disinvoltura delle strutture linguistiche dell’arte veneziana e più in generale dell’arte italiana, che in quegli anni viveva una delicata fase di crepuscolare trapasso dal fulgido Rinascimento e dal lambiccato manierismo ai primi tangibili esiti di un’arte al servizio della cupa pedagogia controriformistica.
Il linguaggio usato da Domínikos nei suoi dipinti veneziani, dal cosiddetto «Trittico di Modena» della Galleria Estense alle «Stigmate di san Francesco» dell’Accademia Carrara di Bergamo, dall’«Ultima cena» della Pinacoteca nazionale di Bologna alla «Deposizione di Cristo nel sepolcro» della collezione Stanley Moss a Riverdale-on-Hudson, fino alla «Guarigione del cieco» della Gemäldegalerie di Dresda, solo per fare qualche esempio, è un linguaggio ancora ibrido, in cui sotto un denso velo bizantineggiante già vibrano gli echi della maniera del maturo Tintoretto e del tardo Tiziano e dove una pennellata corposa e materica costruisce le figure, quasi scolpendole per mezzo del colore.
Nell’autunno del 1570, dopo gli oltre tre anni trascorsi a Venezia, Domínikos sarebbe giunto a Roma. Qui, grazie a una lettera di presentazione del miniatore croato Giulio Clovio, egli sarebbe stato accolto in casa dal «gran cardinale» Alessandro Farnese, il munifico nipote di papa Paolo III la cui sontuosa dimora presso Campo de’ Fiori era spesso meta di soggiorni o visite di grandi artisti italiani e forestieri. Nella missiva Domínikos era citato addirittura come «discepolo di Titiano», un astuto stratagemma utilizzato dal Clovio forse per incuriosire il cardinale nei confronti del giovane artista straniero, dal momento che il Farnese intratteneva ormai da vari anni un rapporto privilegiato di committenza con il sommo cadorino.
Durante il suo soggiorno nell’Urbe Domínikos avrebbe dipinto diversi capolavori quali, a titolo d’esempio, il «Ritratto di Giulio Clovio» e il celebre «Ragazzo che accende una candela (El Soplón)», entrambi al Museo di Capodimonte a Napoli, la allucinata «Veduta del monte Sinai» del Museo Heraklion a Creta, ma anche la teatrale «Cacciata dei mercanti dal tempio» dell’Institute of Arts a Minneapolis, nel cui angolo in basso a destra avrebbe omaggiato alcuni dei maestri che più influenzarono il suo modo di dipingere: vi figurano a partire da sinistra, in una sorta di galleria ideale e di personale specchio della memoria, Tiziano, Michelangelo, Giulio Clovio e Raffaello (o forse Correggio), artisti che con il loro stile inconfondibile rappresentavano agli occhi del pittore greco quanto di meglio aveva prodotto nell’ultimo secolo il Rinascimento italiano.
L’esperienza romana di Domínikos si sarebbe conclusa nel giro di tre o quattro anni, lasciandosi dietro veleni e strascichi polemici scaturiti dalle sue acide e inopportune critiche al «Giudizio» sistino di Michelangelo che, nonostante le censure in cui era incappato all’indomani della conclusione del concilio di Trento, era pur sempre un’opera realizzata sotto Paolo III, il nonno di quell’Alessandro Farnese che così generosamente lo aveva accolto nella sua famiglia. Il brusco allontanamento di Domínikos da parte del «gran cardinale» lo avrebbe costretto ad aprire in fretta e furia una bottega e di lì a breve, evidentemente ormai inviso alla maggior parte del contesto artistico capitolino, ad abbandonare Roma per viaggiare tra Siena, Firenze e Parma e fare ritorno a Venezia, da dove si sarebbe mosso infine alla volta della Spagna, in cui risulta documentato a Toledo sin dal 2 luglio 1577.
Questo e molto altro racconta la straordinaria mostra «El Greco in Italia. Metamorfosi di un genio», allestita negli ampi saloni della Casa dei Carraresi a Treviso e visibile al pubblico dal 24 ottobre al 10 aprile 2016 (catalogo edito da Skira).
Curata da uno dei maggiori specialisti del pittore, Lionello Puppi, la mostra costituisce senza dubbio la più importante retrospettiva mai organizzata sulla giovinezza del maestro candiota, sugli anni della sua formazione artistica a contatto con i grandi artisti italiani, sul periodo forse più oscuro del genio visionario che sarebbe passato alla storia come El Greco, e della cui modernità si sarebbe nutrita la furia creatrice di Francisco Goya o di Pablo Picasso, cresciuti all’ombra dei tanti capolavori lasciati in Spagna da Domínikos.
Oltre a molte delle opere realizzate dal Greco durante il suo decennale soggiorno italiano, in prestito da musei o collezioni nazionali e internazionali, la mostra ospita alcuni capolavori di artisti italiani con i quali egli dovette misurarsi più o meno direttamente, a cominciare dai veneti Tiziano, di cui sono esposti il «San Giovanni Battista» delle Gallerie dell’Accademia a Venezia e le «Stigmate di san Francesco» del Museo Pepoli a Trapani, Veronese, con l’«Allegoria della Battaglia di Lepanto» ancora all’Accademia di Venezia, Tintoretto e Iacopo Bassano, per arrivare poi a esponenti di spicco del manierismo emiliano come il Parmigianino, presente con la raffinata «Madonna di san Zaccaria» degli Uffizi.
Suddivisa in quattro macrosezioni e arricchita da fondamentali aggiornamenti sulla bottega del Greco in Italia, il cui allievo più dotato fu il misterioso Lattanzio Bonastri da Lucignano, la mostra presenta anche documenti d’archivio, carte geografiche, libri, incisioni: materiali forse di minor impatto emotivo rispetto ai quadri e che in realtà si rivelano preziosi per gettare una vivida luce non solo sull’uomo e sull’artista, ma anche sui diversi contesti in cui ebbe l’opportunità di mettere a frutto il suo talento.
A un anno dalle celebrazioni in Grecia e in Spagna in occasione dei quattro secoli dalla morte del Greco, avvenuta nel 1614 a Toledo, la mostra trevigiana offre la possibilità di conoscere appieno la formazione di uno dei più originali artisti di ogni epoca e di cui Picasso ebbe a osservare, intuendone l’assoluto valore pionieristico, che fu l’unico in grado di ideare nella sua epoca «costruzioni cubiste».

El Greco, Altarolo portatile detto Trittico di Modena. Modena, Galleria Estense

El Greco, «Cacciata dei mercanti dal tempio», Minneapolis, Institute of Arts
Altri articoli dell'autore
Un centinaio di importanti opere tra quelle recuperate dai Carabinieri Tpc