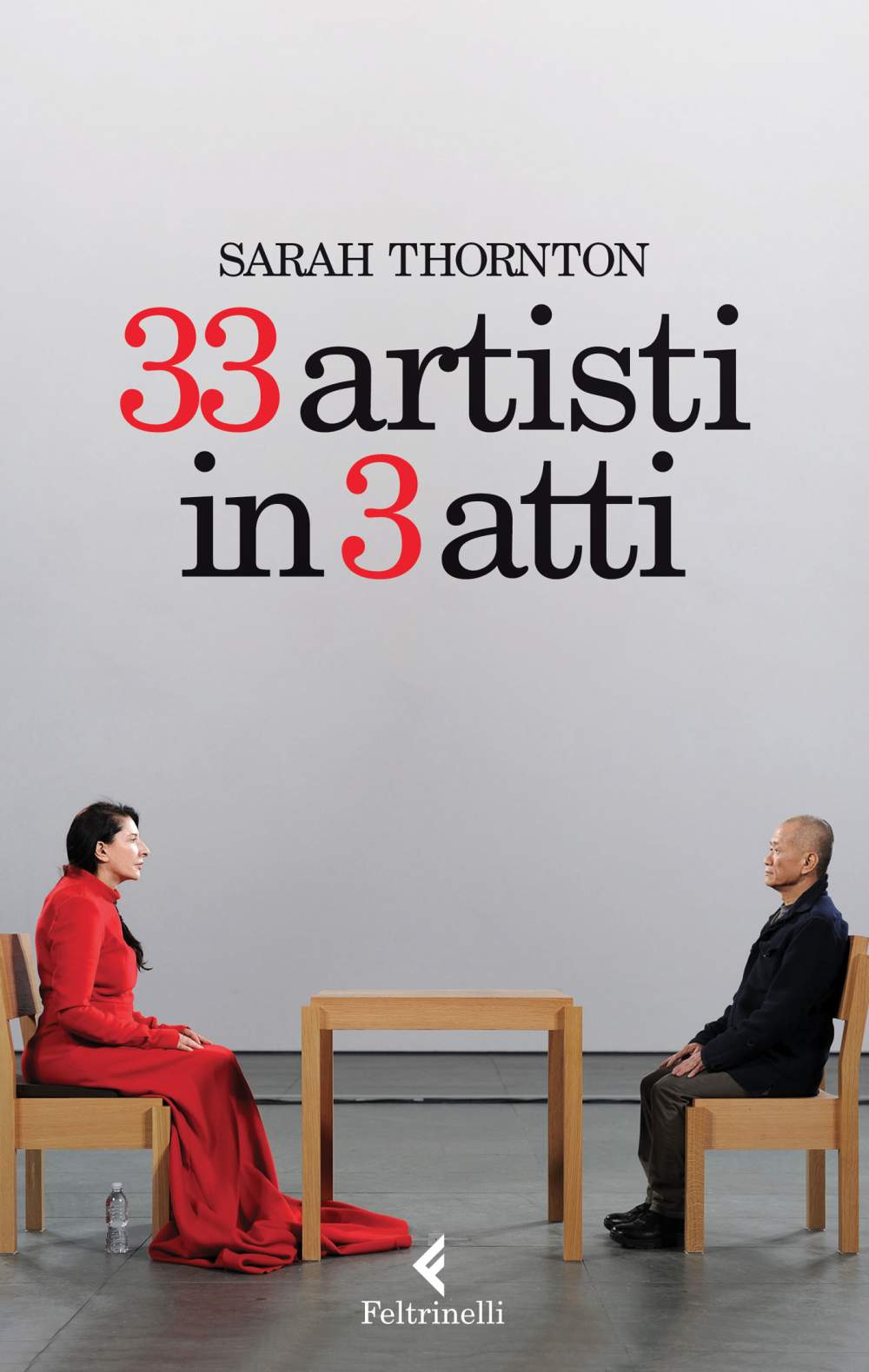Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Anna Minola
Leggi i suoi articoliIl «realismo», stile che si sviluppa potentemente nel corso del XIX secolo, scruta la realtà che ci circonda, la rappresenta e, nello stesso tempo, la analizza. Tuttavia, puntualizza Peter Brooks in Lo sguardo realista, non è la realtà che si specchia nel realismo, ma è vero il contrario. Letterati e artisti hanno cioè «costruito» il realismo mettendo in luce il mondo quotidiano. Mondo nel quale si scopre anche il brutto e si coglie «il fascino esercitato dal non conforme, che si ritrova anche ai nostri giorni nell’opera di Lucian Freud, ad esempio».
Lo sfondo comune a letterati e artisti in cui matura questo stile ha origine dalla rivoluzione industriale, nata in Inghilterra e diffusasi poi in Francia, grazie alla quale si assiste alla trasformazione del lavoro e della produzione, mentre si costruiscono macchinari complessi, ferrovie, strade, si costruisce insomma la città moderna. L’autore, americano, professore di Letterature comparate all’università di Yale, comincia con l’occuparsi di Balzac, scrittore che: «ha inventato il XIX secolo, dando forma ai suoi agglomerati urbani, alle sue nascenti dinamiche capitalistiche, al culto sfrenato per la personalità individuale». In Illusioni perdute sono fondamentali le cose, gli oggetti, i vestiti, con il loro valore «rappresentativo» della persona. Anche Dickens in Tempi difficili partecipa del realismo, descrivendo le terribili condizioni di vita di coloro che abitavano le aree industrializzate. E così Flaubert che, in Madame Bovary, ricorre a tutta una serie di dettagli realistici. A proposito di Charles, il marito di Emma, scrive Flaubert: «Non poteva impedirsi di toccare continuamente il suo pettine, i suoi anelli, il suo scialletto».
A questo punto Brooks si rivolge ad analizzare le immagini di Courbet per ritrovarvi lo stesso sfondo realistico degli scrittori citati. Sono, questi, gli anni delle «rivoluzioni» politiche che si succedono in Francia alla metà del secolo. «Funerali a Ornans» desta scandalo: ha dimensioni enormi, è dipinto in modi che sembravano brutti, coi protagonisti dai volti sgraziati. Vengono analizzati anche «Gli spaccapietre» e « Le bagnanti». Ritornando alla letteratura, l’autore vede in Zola la terza generazione, dopo Balzac e dopo Flaubert, del realismo letterario francese: in Nanà compare il determinismo.
Brooks si occupa quindi, tra gli artisti, di Manet, con cui nasce, per dirla con Baudelaire, la «pittura della vita moderna», che continua con Caillebotte. Si lavora en plein air, adesso, negli anni Settanta-Ottanta, ma il paesaggio è anche ancora urbano (mentre Parigi viene grandiosamente rimodellata da Haussman) essendo i soggetti preferiti la folla e ancora la moda. Per Manet, l’analisi riguarda «Olympia», «Le déjeuner sur l'herbe», «La ferrovia», «La lettrice». Con Caillebotte, il realismo si fa più duro: vedi «I piallatori di parquet» o «Le pont de l’Europe». Da ultimo l'analisi è rivolta alla scrittura di Henry James, con la sua prospettiva «disorientata», come capita nella pittura di Degas.
E l’autore conclude un libro ricchissimo di informazioni, immagini e spunti seducenti, riflettendo su Virginia Woolf, Joyce, Proust e l’inversione di tendenza che essi imprimono al genere «romanzo».
Lo sguardo realista, di Peter Brooks, traduzione di Federico Casari, 255 pp., Carocci editore, Roma 2017, € 29,00
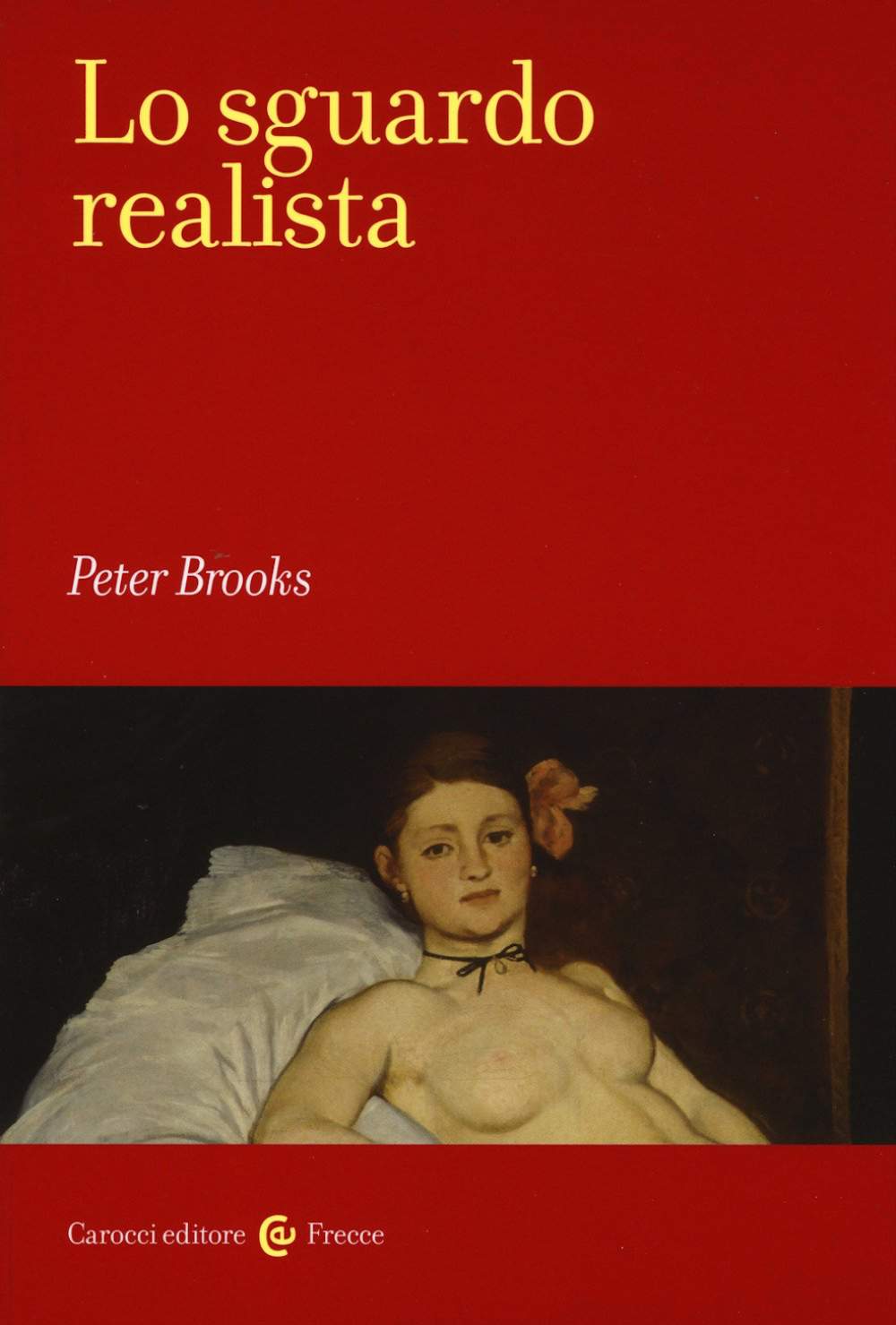
La copertina del volume
Altri articoli dell'autore
Sarah Thornton ha scelto 33 «personaggi coinvolgenti» del mondo dell'arte