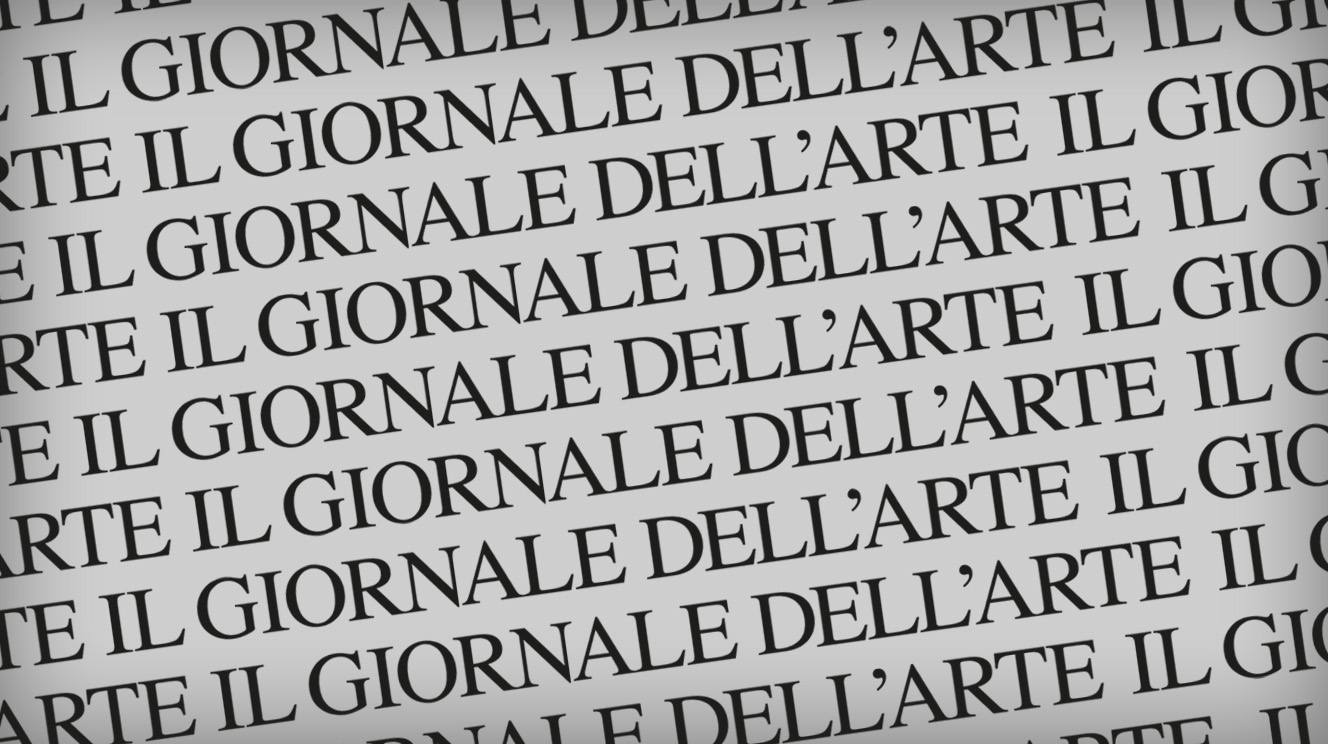Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Silvia Mazza
Leggi i suoi articoliLa decadenza del Centro per la progettazione e il restauro è il simbolo di come autonomia gestionale e finanziaria non siano sufficienti se non ci sono direttori all’altezza
C’è uno spartiacque nella storia del Centro per la progettazione e il restauro (Crpr), un prima e dopo, che può essere letto come cartina di tornasole per la nuova riforma Franceschini dei musei e, in Sicilia stessa, per gli istituendi Parchi archeologici. È l’esempio di come autonomia gestionale e finanziaria, di cui saranno dotati entrambi, non siano sufficienti a garantire successo se a capo degli Istituti che ne godranno non andranno direttori all’altezza dei loro compiti istituzionali. Poi, certo, si potrà discutere anche di come pesanti tagli ai fondi e carenza di personale qualificato per il blocco del turn over abbiano contribuito a disegnare la parabola discendente dell’Istituto palermitano, organismo tecnico-scientifico dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.
Aveva avuto la sua stagione d’oro durante i nove anni (2001-10) della gestione di Guido Meli, quando era salito alla ribalta anche internazionale, grazie a restauri come quello della Villa romana del Casale di Piazza Armerina o dell’ala Settecentesca di Palazzo Abatellis, a convegni con l’Iccm, Iccrom o il Getty sul rischio sismico; e alla mutuazione di progetti nazionali come la Carta del Rischio del Patrimonio, ma anche del lancio di progetti originali coma «I Luoghi della Memoria». Dopo l’ottobre 2010 a poco è servita, appunto, quell’autonomia gestionale di cui il Crpr è dotato sin dalle origini (1989). Scelta precorritrice in Italia: l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per esempio, può vantarla solo dal 2008. Come innovativa era stata la fondazione stessa del Centro nel 1982. Era, in qualche modo, la prima risposta alla visione con cui Cesare Brandi nel 1939 fondò a Roma l’allora Istituto centrale del Restauro (Icr), che in quel «centrale» della sua originaria denominazione, venuto meno con quella nuova di Istituto «superiore» per la conservazione e il restauro, conteneva implicitamente la previsione (rimasta inattuata) di una successiva filiazione di «sezioni» regionali.
Al Crpr, dunque, dopo la poco significativa gestione di Adele Mormino (ottobre 2010-aprile 2013; cfr. n. 321, giu. ’12, p. 56), nel luglio 2013 è stata spedita una dirigente «discussa», l’archeologa Enza Cilia, nobildonna dopo il matrimonio con il marchese Giuseppe Platamone, fresca di nomina a capo di gabinetto di Crocetta e prontamente trasferita ad altro incarico dopo un articolo al vetriolo sul settimanale «Centonove» (23 novembre 2012), in cui il giornalista Enzo Basso riporta le dichiarazioni rese nel corso di un processo abbreviato dall’allora procuratore della Repubblica di Enna Silvio Raffiotta (poi assolto), titolare delle più importanti inchieste sui traffici illegali di reperti archeologici. Erano ben 19 i procedimenti penali, dal ’90 al ’99, che aveva contato a carico della Cilia, mentre era alla Soprintendenza di Enna: avrebbe autorizzato l’espianto di un noccioleto alle falde del monte sopra la Villa romana del Casale, causandone la successiva «inondazione colposa» nell’alluvione dell’ottobre 1991; «Avrebbe fatto scavare, scrive Basso, un sito diverso da quello indicato dal professor Malcolm Bell, sul luogo presunto del ritrovamento del Tesoro di Morgantina», finito poi al Metropolitan Museum di New York; veniva anche accusata di mancata vigilanza sui depositi del museo di Aidone, dove erano avvenuti una serie di furti, per cui fu sospesa dai pubblici uffici; e di aver autorizzato i lavori per la diga di Pietrarossa, dove si è rischiato che i resti di un villaggio di epoca romana fossero sepolti dall’acqua. Protagonista Enza Cilia è stata pure di due pamphlet anonimi negli anni a cavallo del nuovo secolo, intitolati L’Avvocato e la Marchesa, firmati da tal Eliodoro&Ducezio, dossieraggio in chiave Wikipedia, concepito perché le informazioni riservate e scottanti fossero implementate via internet. Date e fatti, dagli anni ’30 fino al 2001, con l’obiettivo di destabilizzare non solo gli uffici dei Beni culturali, ma certi poteri forti siciliani.
Questa dirigente, con questi trascorsi, la si è incaricata di dirigere quello che avrebbe potuto essere il fiore all’occhiello dei Beni culturali in Trinacria. Quando vi approdò Meli nel 2001 il Centro non vantava trascorsi gloriosi. Il dirigente generale dell’epoca gli diede «due anni di tempo, ricorda l’architetto Meli: o riuscivo a farlo decollare o si sarebbe chiuso».
La dotazione finanziaria fino al 2001 era di un milione di euro all’anno, una bella cifra che servì solo a produrre avanzi d’amministrazione da capogiro, centinaia di milioni non spesi, recuperati e reinvestiti da Meli. Nel suo ultimo anno si era dimezzata a 560mila euro e in quello dopo, nel 2011, sotto la Mormino era di 540mila, per precipitare con la Cilia, nel 2014, a 74mila, a cui si devono sommare i 200mila per il corso di laurea a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni culturali, istituito nel 2004. Proprio per questo drastico taglio alle erogazioni ordinarie, e in assenza di canali di finanziamento da terzi (fondazioni o società private), vitale sarebbe stata la capacità di canalizzare, come in passato, i fondi europei per i «progetti speciali», progetti internazionali di cui il Centro è stato partner. Quanto al personale, durante il periodo Meli c’erano oltre 100 unità, 80 sotto la Mormino, per conoscere poi una vera e propria diaspora all’arrivo della Cilia, quando pare che le richieste di trasferimento siano state tali da costringere a bloccarle. Cosicché oggi ci sono 70 persone, di cui poco più di una ventina con mansioni tecniche (chimici, biologi, fotografi ecc.) e 11 provenienti dal bacino «Emergenza Palermo» ex Pip (Piani di inserimento professionale): disoccupati ed ex detenuti assunti per pulizie, fotocopie ecc., secondo un modello di sistema assistenzialista siciliano non toccato nemmeno dal governatore «rivoluzionario».
Il restauratore, in un Centro del Restauro, è uno solo: Lorella Pellegrino, specializzata all’Opd in lapidei e mosaici e all’ex Icr in intonaci dipinti. Sotto le sue mani sono passati i pezzi più pregiati delle collezioni lapidee siciliane: busto di Eleonora d’Aragona dell’Abatellis, Torso di Mozia del Salinas, mosaici e affreschi della Villa romana del Casale. Il suo laboratorio a un certo punto pare fantasma: scomparso sulla carta (non nella sua consistenza fisica) con la rimodulazione dell’assetto organizzativo del Dipartimento Beni culturali del 2010. Ci volle un decreto dell’anno dopo per riparare a questa anomalia. Adesso non c’è niente per il laboratorio «riabilitato» della Pellegrino: una statua lignea, un reliquiario, poco altro. Una presenza, la sua, quasi simbolica, in mancanza di altri restauratori per tipologie diverse di materiali.
Il dato più macroscopico dell’attuale corso è la chiusura, dal periodo Mormino, del Sit (Sistema informativo territoriale) siciliano della Carta del Rischio, cartella clinica dei monumenti, che mette in correlazione la loro vulnerabilità con le pericolosità presenti nel territorio. Gettati alle ortiche 4 milioni di fondi europei che il Centro dal 2001 al 2008 ha gestito, speso e concluso. Sprechi che l’Ue non sembra più intenzionata a tollerare, se, come denunciato dall’eurodeputato Ignazio Corrao del M5S, «dei 300 milioni previsti per la programmazione precedente si arriverà al massimo a 100 milioni del nuovo programma di finanziamenti “Cultura e Sviluppo” 2014-20». Nel novembre 2009, quando era stata presentata la Carta, di cui era responsabile Roberto Garufi, i beni censiti erano 10.178, 2.500 le schede di vulnerabilità, 99 i comuni oggetto del rilevamento, oltre a sei volumi prodotti e due video didattici per le scuole (cfr. n. 293, dic. ’09, p. 12).
Tra le varie calamità possibili, prendiamo, per esempio, il caso di un terremoto in una regione come la Sicilia con elevata sismicità: alla banca dati online operatori, Soprintendenze e Protezione civile potevano accedere dal sito www.cartadelrischio.sicilia.it; cliccando sopra l’epicentro si apriva un ventaglio spaziale in cui era possibile individuare immediatamente i beni compresi all’interno della cosiddetta buffer zone di influenza sismica e stabilire le priorità. La Cilia ci riferisce che «sarà di nuovo disponibile al termine della revisione e aggiornamento». Senonché, cosa singolare, in atto non c’è proprio nulla. E, intanto, perché «oscurarlo»? L’abbiamo chiesto all’assessore ai Beni culturali siciliani Antonino Purpura che ci parla di «criticità di natura tecnica rilevate in corso di funzionamento». «Funzionante» sicuramente il Sistema lo era quando era stato presentato. Ad attestarlo è Carlo Cacace, responsabile della Carta del Rischio all’Iscr, che aveva collaborato alla progettazione di quella siciliana, «secondo gli schemi metodologici del sistema nazionale». Al Crpr «andarono anche oltre, ricorda, affinando gli algoritmi in funzione della specificità territoriale siciliana, effettuando schedature dei beni e implementando anche altre forme di rilevamento». Ma «ovviamente il sistema realizzato deve prevedere spese per il suo mantenimento, spiega, durante le attività di utilizzo emergono delle criticità normali». Finito il progetto, la collaborazione s’interruppe perché il Centro non ebbe più le «condizioni economiche» per «evoluzioni del sistema». In realtà, nel 2012, tra i progetti presentati per accedere al Po Fesr 2007-13, c’era proprio quello per «una riconversione dell’architettura di sistema della Carta» (639.980 euro; cfr. n. 321, giu. ’12, p. 56). Evidentemente alla fine non è stato finanziato. Alla questione nel suo complesso, che non era stata sollevata fino all’interrogativo posto da «Il Giornale dell’Arte», l’assessore intende rimediare con «un progetto di aggiornamento e implementazione del Sit, sfruttando anche i fondi della nuova programmazione europea 2014-20».
Per il resto, in generale i progetti che avevamo annunciato nel 2012 sono al palo. Di «nuovo» c’è solo la ripresa dei «Luoghi della Memoria», il cui primo censimento risale al 2008 con 700 elementi. Qualche segno di vita mostra ancora l’attività diagnostica svolta dai laboratori. Niente più convegni internazionali (quello del 2007 per una Carta del Rischio del Mediterraneo aveva anche offerto a esperti di tutto il mondo una irripetibile visione ravvicinata dei «muqarnas» della Cappella Palatina, grazie ai ponteggi del restauro allora in corso) e ferma dal 2009 la rivista d’informazione. Forme di pubblicizzazione di altro tenore corrono, piuttosto, sul sito del Centro. Fino a qualche mese fa nella homepage campeggiava non un progetto o un restauro, ma l’avviso di vendita di una «Bmw berlina 318 D targata BZ 928 NT di proprietà del Centro». Auto di servizio, o se si vuole di rappresentanza. Quando ancora qualcosa il Crpr rappresentava.
Altri articoli dell'autore
La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera
Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni
Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma
Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.