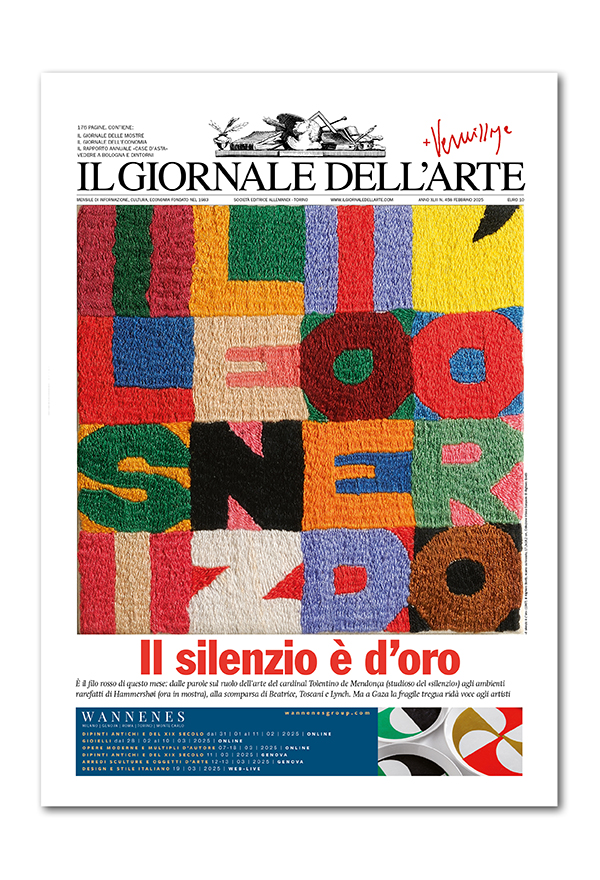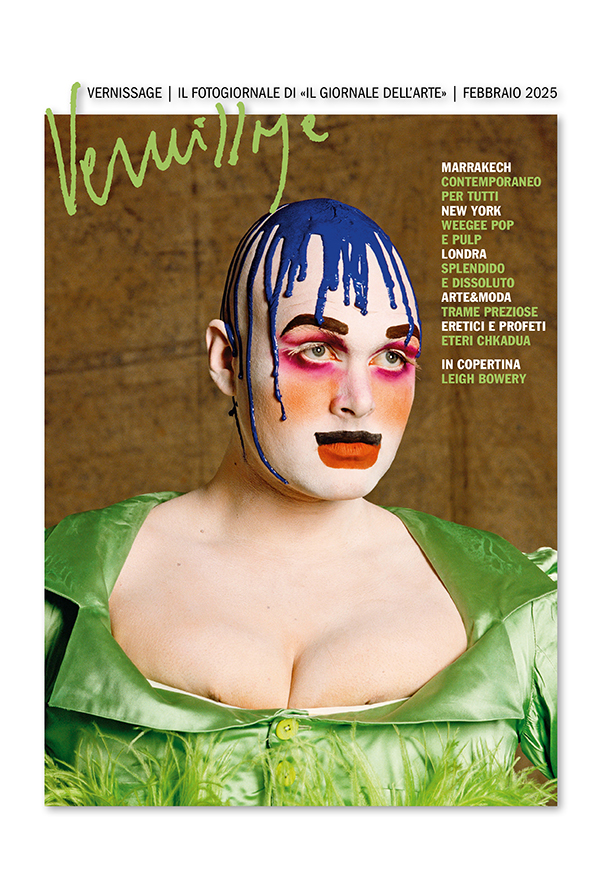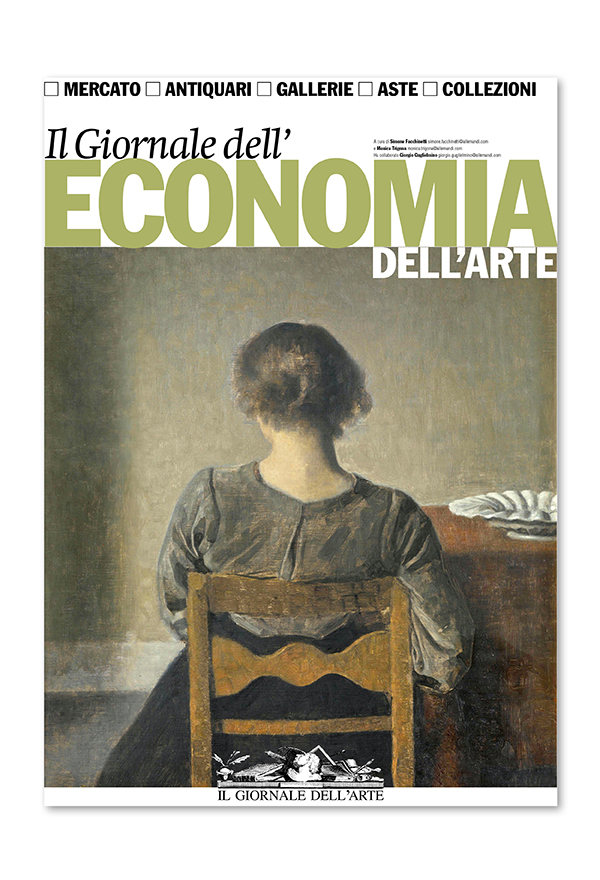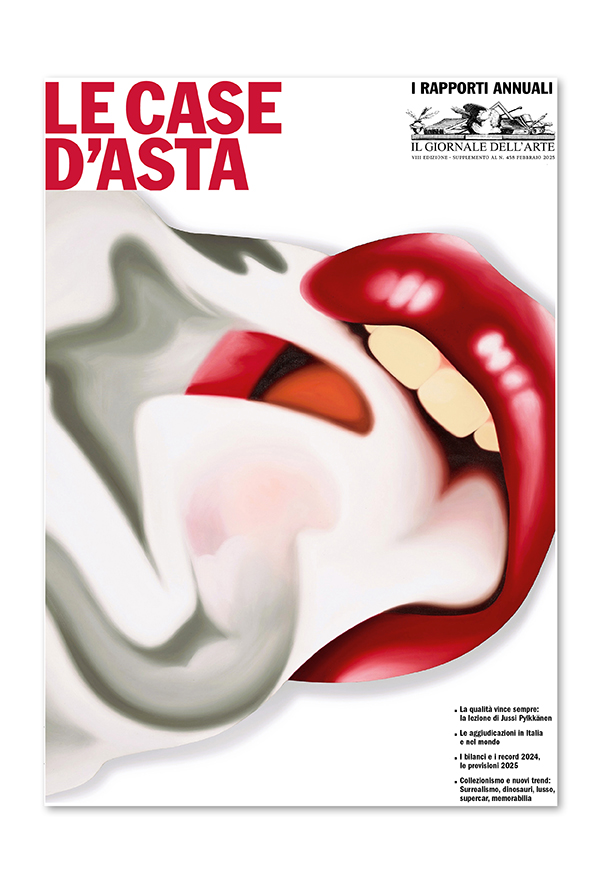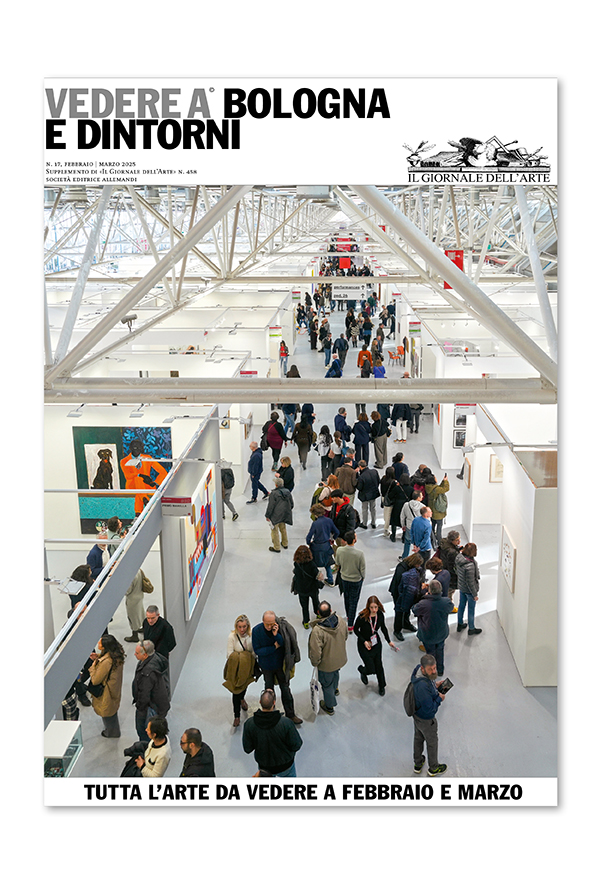Anche nella scultura moderna l’agire dell’artista «per via di torre» (togliere) e «per via di porre» (aggiungere) ha costituito un modo per identificare alcuni tra i maggiori protagonisti di questa disciplina. In pochi, tuttavia, lo scalpello che cerca, sottraendo materia, la forma nel volume della pietra o del marmo coesiste con la spatola che scava, sposta e dove occorre addiziona e segna la morbidezza dell’argilla e della cera.
Uno di quei pochi, nel ’900 europeo, fu Arturo Martini; e dopo di lui il suo maggiore prosecutore, Marino Marini (Pistoia, 1901-Viareggio, 1980), più giovane di lui di 11 anni. Il visitatore della mostra intitolata «Arcane fantasie» e aperta dal 15 giugno al 3 novembre nel Forte di Bard in Valle d’Aosta ne può apprezzare soprattutto la sensibilità del modellatore attraverso una bella selezione di bronzi di varia dimensione, tra i quali il prestito più atteso è il grande «Gentiluomo a cavallo» del 1937, concesso dalla Camera dei Deputati, ma ha altresì la possibilità di avvicinarsi alla sua tutt’altro che episodica produzione pittorica e grafica. Marini operò in un tempo in cui la padronanza delle tecniche e la conoscenza delle potenzialità dei materiali era uno dei primi requisiti. Ebbe in tal senso eccellenti maestri: Galileo Chini per la pittura e Domenico Trentacoste per la scultura all’Accademia di Firenze. Ma tutto il resto, la parte ancora più importante, glielo offrivano gli Etruschi del Museo Archeologico, meta di ripetuti sopralluoghi.
La mostra di Bard, curata da Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento di Firenze, riunisce 23 sculture e 39 opere su carta e tela, in buona parte provenienti dal Museo fiorentino intitolato all’artista. Sono presenti le iconografie mariniane più note: il cavallo e il cavaliere e le Pomone sono tra le principali. Il primo tema, che, spiegò l’artista, nacque da un’«idea architettonica, data dalla verticalità del cavaliere e dall’orizzontalità del cavallo» è documentato nella sua evoluzione, dalle composte, armoniche sculture degli anni Trenta sino alle drammatiche tensioni dei primi anni del dopoguerra, ai confini con l’astrazione, culminanti con una sorta di guerriero-Chimera plasmato nel 1958-59. I Primitivi italiani che furono i primi modelli di Marini lasciano così spazio all’Espressionismo e alla scomposizione di ascendenza cubista, con i quali l’artista era venuto in contatto nei suoi viaggi a Parigi e in Svizzera, dove riparò nel 1943 e dove, tra gli altri, incontrò Wotruba, Germaine Richier, Giacometti. Solo Pomona, divinità minore del Pantheon romano antico, mantiene negli anni la sua classica, sensuale monumentalità, quasi a contraltare della drammaticità tematica e formale che caratterizza la piena maturità dell’artista. Marini non negava la fascinazione per il colore, e non solo sulla tela o sulla carta, ma anche nelle sculture in legno. Acrobati e Arlecchini, temi frequenti nella sua opera pittorica, non sono tuttavia un divertissement; caso mai, sono figure per nulla estranee alle malinconie circensi di Picasso. Ciò che conferma questa mostra è la straordinaria capacità dell’artista di cogliere quella primarietà formale che perseguì per tutta la vita in ambiti diversi, coniugando la cultura mediterranea con quella nordica. Insieme, emerge con forza la sua appartenenza a un’epoca in cui anche il «Miracolo» (titolo di molti suoi cavalli e cavalieri schiantati al suolo) è sempre trauma e deflagrazione spirituale. Il cavaliere di Marini è il Saulo sulla via verso Aleppo cantato da Montale in «Siria», figura tragicamente attuale, come indica la freccia tracciata col sangue che chiude quei versi.

«Cavallo e acrobata» (1946) di Marino Marini. Firenze, Museo Marino Marini. Foto Archivio Museo Marino Marini Firenze