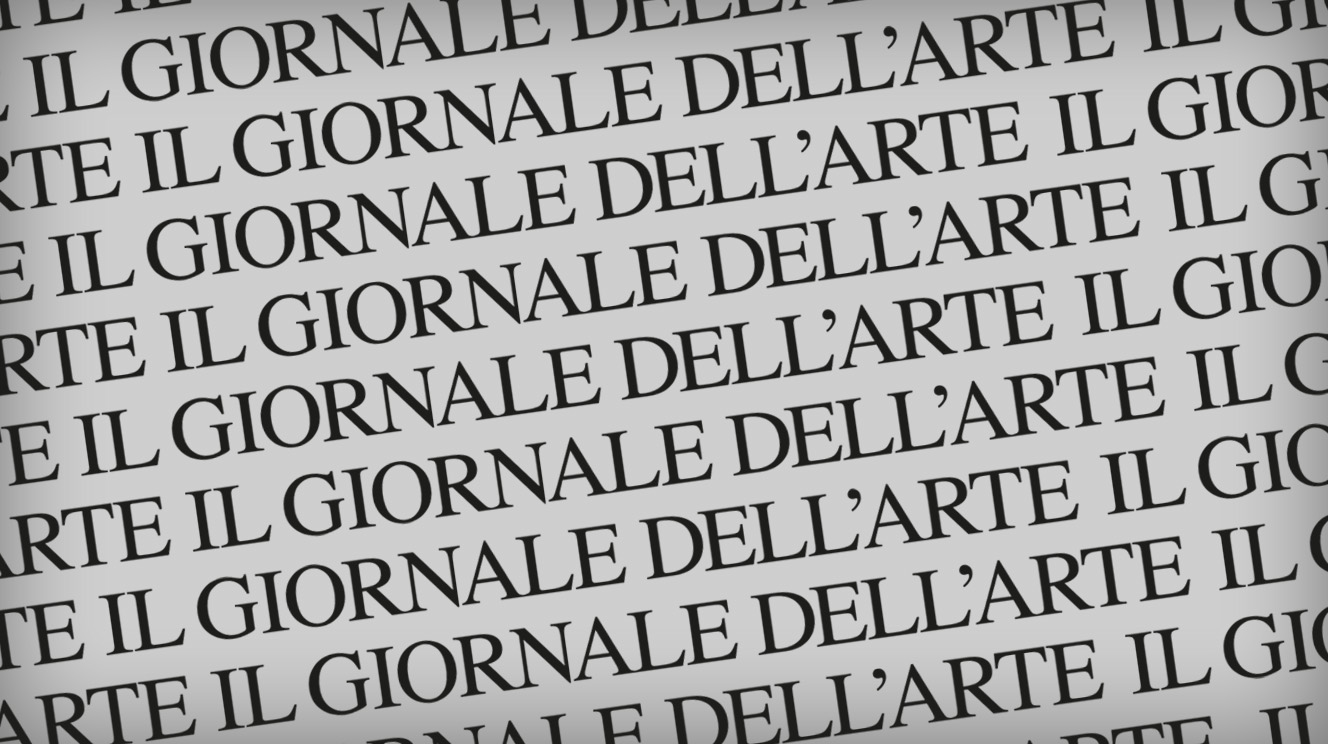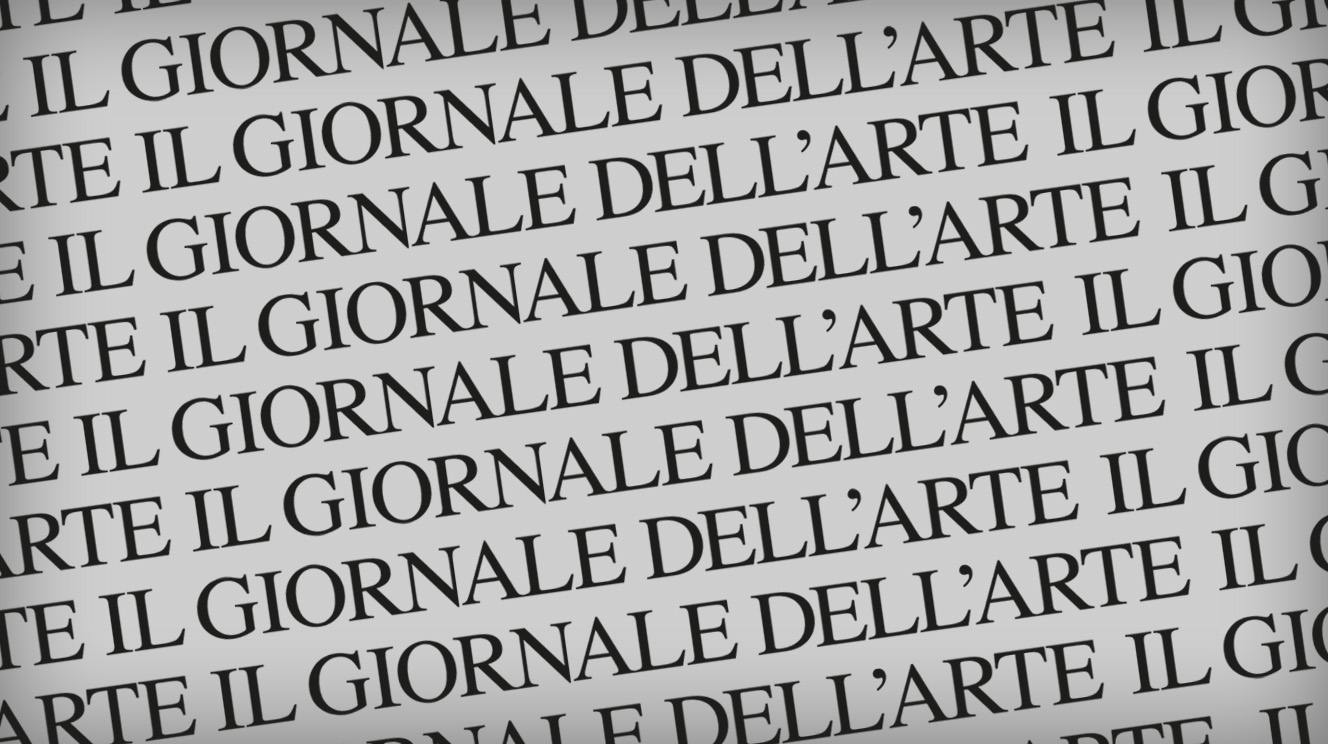Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Sandro Barbagallo
Leggi i suoi articoliLa Sala di Costantino, l’ultima delle quattro «Stanze» dei palazzi vaticani che Giulio II Della Rovere e il suo successore Leone X Medici affidarono a Raffaello, è anche l’ultima in ordine di tempo a essere restaurata.
I lavori che avranno inizio in questo mese di febbraio, e che si protrarranno per i prossimi otto anni, rappresentano infatti il tassello finale di un’impresa avviata nel 1982 con il restauro degli affreschi della Stanza dell’Incendio di Borgo, proseguita negli anni ’90 nella Stanza della Segnatura e dal 2002 al 2013 nella Stanza di Eliodoro.
L’intervento sul ciclo costantiniano sarà condotto dal Laboratorio restauro dipinti dei Musei Vaticani, guidato da Maria Ludmilla Putska, sotto la direzione scientifica di Antonio Paolucci e Arnold Nesselrath.
La metodologia da adottare verrà definita sulla scorta delle esperienze acquisite dal maestro Paolo Violini nel restauro della Stanza della Segnatura e della Stanza di Eliodoro, e con il supporto del Laboratorio di diagnostica diretto da Ulderico Santamaria, che ha già avviato le analisi e indagini preliminari.
A differenza degli altri ambienti, però, il restauro della Sala di Costantino si presenta particolarmente rilevante perché finalmente, come rileva il direttore dei Musei Vaticani Antonio Paolucci, «i suoi affreschi verranno liberati da quella patina scura e polverosa a cui siamo abituati, per svelarci, come mai prima d’ora, quanto sia stata veramente universale l’eredità di Raffaello». L’urbinate aveva infatti iniziato a progettare la decorazione dell’ambiente più grande dell’allora appartamento papale (10x15 metri, 13 metri di altezza) sul finire del 1517, ma fece in tempo solo a prepararne i cartoni, poiché la morte lo colse il 6 aprile del 1520, a soli 37 anni, dopo quindici giorni di febbre «continua e acuta», che secondo il Vasari fu causata dagli «eccessi amorosi» e infelicemente curata con inutili salassi. Anche se dipinta dai collaboratori di Raffaello dopo la sua morte, la Sala di Costantino rappresenta concettualmente l’incipit di quel motivo celebrativo storico-politico che trova compimento nelle Stanze successive.
Se le rappresentazioni della Stanza della Segnatura, destinata a biblioteca del papa, dovevano esprimere la ragione, la morale, la giustizia e l’ideale di bellezza incarnati da colui che è stato prescelto dal collegio cardinalizio a divenire il successore di Pietro; l’ambiente che la precede, ossia la Stanza di Eliodoro, allude all’inviolabilità della «persona» del santo padre e del «patrimonio» della Chiesa, grazie alla sempre presente protezione divina. L’origine del potere temporale e la superiorità dell’autorità papale sull’imperatore sono invece documentate nella Sala di Costantino.
Le grandi pareti affrescate con «La visione della croce», «La battaglia di Ponte Milvio», «Il battesimo di Costantino» e «La donazione di Roma attraverso l’offerta, da parte dell’imperatore, di una statua della dea Roma a papa Silvestro», altro non sono che l’esaltazione dei successi politici della Chiesa di Roma. Successi che però trovano il loro apice, non solo simbolico, nella disfatta del paganesimo e nel trionfo della religione cristiana, non a caso rappresentato nella grande volta affrescata.
Qui, al centro di un elegante spazio architettonico dalla prospettiva simmetricamente perfetta, un simulacro pagano è miseramente rovinato a terra dal piedistallo, per lasciare il posto al Crocifisso.
La responsabilità dell’imponente cantiere è stata affidata a Fabio Piacentini, restauratore dei Musei Vaticani, che sarà affiancato da un team di sei professionisti italiani assunti a progetto (uno dall’Opificio delle Pietre Dure, due dall’Iscr, tre dalle Scuole regionali di Valorizzazione dei Beni culturali). La sequenza dei restauri avrà inizio dalla parete con «La visione della croce», davanti alla quale sono stati già montati i ponteggi, e proseguirà in senso orario interessando man mano anche la porzione di volta corrispondente e il basamento. Quest’ultimo, interessantissimo nei dettagli, si caratterizza per quei chiaroscuri «color del bronzo» a «imitazione» dei rilievi della Colonna Traiana, realizzati da Polidoro da Caravaggio e da Maturino da Firenze, entrambi cresciuti nella bottega di Raffaello.
La storiografia ufficiale stabilisce che Raffaello fece in tempo a lasciare soltanto i cartoni di questo ciclo. Osservando a lungo gli affreschi della Sala di Costantino dopo aver osservato attentamente quelli delle Stanze precedenti tutti già restaurati si potrà intuire in quali parti risulti evidente la mano del più valente della cosiddetta cerchia dell’urbinate, ossia Giulio Romano. Così come risulta evidentissima una discrepanza di stile esecutivo che da «La battaglia di Ponte Milvio», in cui l’eleganza compositiva e l’abilità esecutiva sono una diretta continuazione degli affreschi delle Stanze precedenti, passa a «La visione della croce» e da questa a «Il battesimo di Costantino» e a «La donazione di Roma». Con tutta probabilità, non solo «La visione della croce» è stata dipinta dopo «La battaglia», ma in entrambe risulta preminente la presenza di Giulio Romano, che guarda caso «tanto imparò dalle colonne antiche di Traiano e d’Antonino». Giorgio Vasari, infatti, che continua a essere una fonte unica per la storia dell’arte, sostiene nelle sue Vite che Giulio «se ne valse molto negli abiti de’ soldati, nell’armature, insegne, bastioni, steccati, arieti, e in tutte l’altre cose da guerra che sono dipinte per tutta quella sala…» E se consideriamo che le ultime due pareti non rappresentano affatto scene di guerra, ecco che l’indicazione del maestro aretino diviene alquanto circoscritta. A che cosa rimanda, d’altronde, quel volto grottesco del nano che si mostra con l’elmo a destra della Visione, che quasi come una firma del suo autore rimanda alla fisiognomica degli affreschi di Palazzo Te, dove Giulio Romano si è poi recato lasciando Roma? Ma come dice giustamente Antonio Paolucci: «Capiremo solo dopo i restauri che qui siamo alle vette della pittura e che Raffaello ha continuato a fecondare la pittura italiana ed europea attraverso la sua scuola: quella di Giulio Romano, del Penni, Giovanni da Udine, Polidoro da Caravaggio, di Perino, Raffaellino dal Colle…».
La domanda, però, resta un’altra: che cos’è rimasto dei cartoni preparatori di Raffaello e della sua idea di voler realizzare la decorazione della Sala di Costantino con colori a olio? Poco o nulla sappiamo al riguardo, ma il prosieguo dei restauri potrebbe riservarci qualche sorpresa. Perché mai nelle due pareti da lui affrescate Giulio Romano ha incollato alle pareti due figure allegoriche (la Mansuetudine e la Giustizia) realizzate a olio su carta? Rappresentano forse un’ossequiosa attenzione dell’allievo nei confronti del maestro? Ai risultati dei restauri l’ardua sentenza.

La parete della Sala di Costantino con «La visione della croce», Musei Vaticani