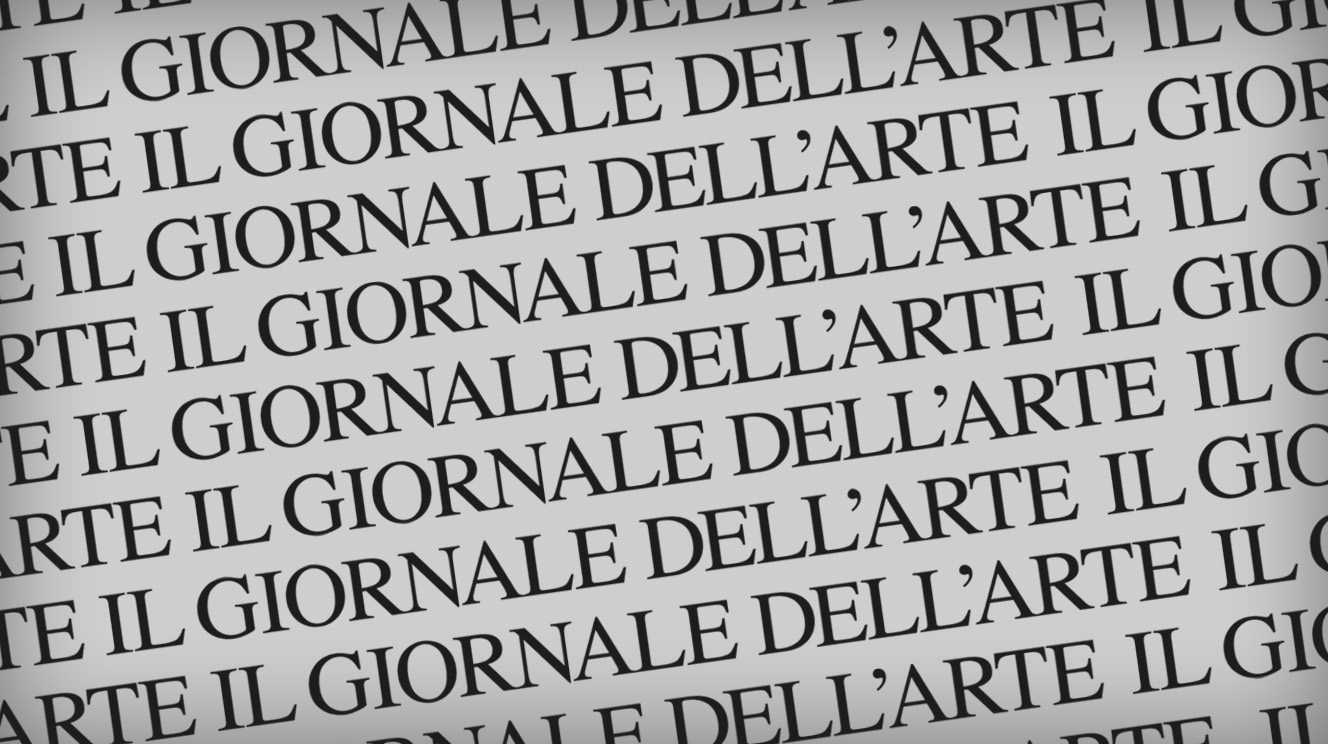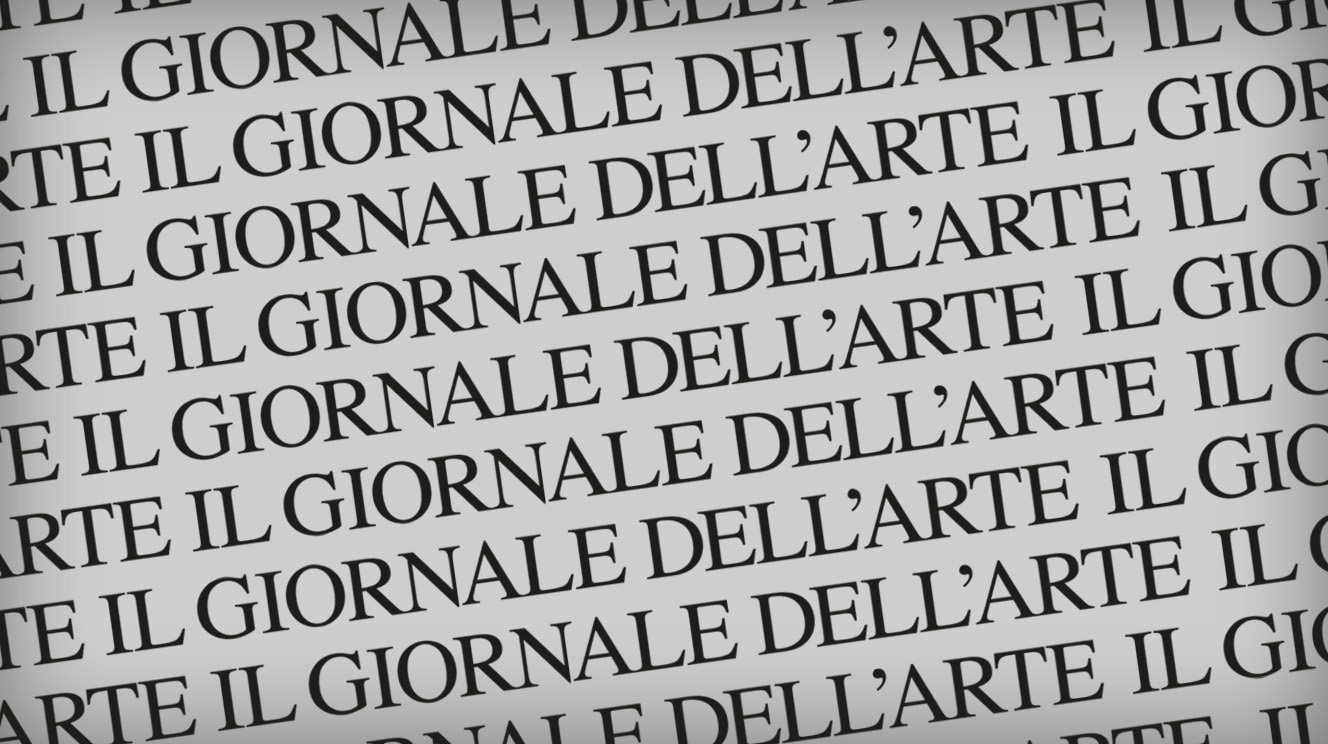Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Bruno Zanardi
Leggi i suoi articoliGrandi polemiche in questi mesi per i restauri condotti su Colosseo, Ciborio di Arnolfo nella Basilica di Santa Cecilia, a Roma, e Basilica inferiore di Assisi. Perché? Risposta semplice. Sta sempre più venendo al pettine il nodo dell’immenso ritardo culturale del settore e la conseguente immensa confusione e inefficienza di attori e regole. Ritardo culturale, confusione e inefficienza che trovano origine e sintesi nel fatto che ancora oggi le politiche ministeriali continuano a far coincidere la tutela con il restauro e il restauro con il restauro critico-estetico, come ancora si fosse al Convegno dei soprintendenti del 1938 (77 anni fa) quando Bottai, Longhi, Argan e Brandi così impostarono il problema: senza alcun collegamento con la questione ambientale. Il collegamento fu fatto nel 1948 (67 anni fa) dall’art. 9 della Costituzione, ma inevitabilmente in via di principio; da allora però mai nessuno, Mibact e Università in primis, ha riempito quell’articolo di contenuti formativi, giuridici, tecnico-scientifici e organizzativi, così da averne annullato ogni concreto effetto sulla tutela del patrimonio storico e artistico del Paese.
Il problema strati colorati
Partiamo dalle polemiche aperte da un gruppo di noti restauratori sul restauro del Colosseo sponsorizzato da Diego Della Valle e oggi terminato per dieci arcate. Chi ha ragione? Tutti e nessuno. Per vari motivi. Innanzitutto il piano procedurale. Inopinatamente una ventina d’anni fa le attività di restauro sono state equiparate ai lavori pubblici, quindi messe ex lege in gara, ivi compresi i lavori al Colosseo, la cui gara è stata vinta da un’impresa edile. Certo, impresa con al suo interno dei restauratori, certo un lavoro guidato dall’attuale direttore dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (Iscr), nuovo, inutile e reboante nome dell’Istituto centrale del restauro, ma titolare del restauro del monumento forse più noto del mondo è, e resta, un’impresa edile, «sputtanando» in questo modo la storica tradizione del restauro italiano. E lasciamo perdere se a fare del restauro un lavoro pubblico è stata la masochistica pressione dei restauratori dell’Associazione che raduna i diplomati Iscr e Opd, l’Ari, i quali, così facendo, intendevano estromettere dalla piazza i restauratori privi d’una preparazione accademica, senza capire che non era in quel modo che si poteva regolare un mercato da sempre tenuto aperto dalle Soprintendenze a decine di migliaia di figure di tutti i generi, una vicenda assurda, ma comunque tale. Più in particolare, senza capire che facendo del restauro un lavoro pubblico inevitabilmente si apriva la strada alle imprese edili, perché queste, certamente più delle microimprese artigiane (diplomate o meno), hanno mezzi, capacità tecniche, imprenditoriali, organizzative e finanziarie, oltre che una più o meno trasparente possibilità d’accesso ai requisiti burocratici, per intervenire su interi palazzi e chiese, a partire dal Colosseo. Né hanno mai voluto ammettere che anche tra i restauratori non formati ce ne sono di bravissimi.
Veniamo adesso alle critiche al restauro del celeberrimo monumento che sono tutte e sempre e solo nella ratio 1938 di Argan e Brandi, cioè di natura tra storicistica ed estetica, perciò ininfluenti sul piano conservativo, a riprova del solito ritardo culturale del settore. Per gli oppositori del restauro del Colosseo il problema è che il paramento lapideo del monumento antico-romano si presenta, dopo la pulitura, otticamente disomogeneo. Come in effetti è perché il restauro ha conservato sulle pietre gli strati colorati (da nerastri a giallo ocra) di ossalato di calcio sempre presenti su ogni monumento, a qualsiasi latitudine. Il che ci riporta agli anni ’80 del Novecento (qui il ritardo è di una trentina d’anni), quando si vide che quegli strati nulla c’entravano con le policromie antiche, innescando un vasto dibattito tra restauratori, archeologi ed esperti scientifici per stabilire quale ne fosse la natura. Se semplici strati di alterazione, ossia se esito della trasformazione nel tempo di protettivi superficiali antichi. Un dibattito nei fatti mai risolto in sede scientifica, a ennesima dimostrazione della fragilità culturale del settore, così da essere infine divenuto, il problema degli strati colorati di ossalato, una dilettantesca quanto onanistica esercitazione estetizzante tra chi li vedeva un valore dell’antico alla Riegl, quindi da conservare, e chi invece li vedeva un disturbo estetico per la purezza postwinckelmanniana del bianco delle pietre, quindi da rimuovere. Risultato? Che da allora il restauro delle pietre viaggia in Italia sul sentimento della scuola universitaria cui appartiene il soprintendente, cioè il direttore dei lavori (ex lege), volta a volta in carica. Così che, mentre al Colosseo ha vinto la visione estetico-storicistica del problema, da qui la conservazione degli strati colorati di ossalato casualmente depositati a chiazze sulle pietre, con un evidente fastidio estetico nella vista del monumento, a duecento metri di distanza per la facciata della chiesa del Gesù (Michelangelo, Vignola, Della Porta) ha vinto la visione postwinckelmanniana del problema, quindi la facciata è stata fatta pulire operando la radicale rimozione di ogni traccia degli strati di ossalato, ciò che l’ha resa innaturalmente bianca e pura, nei fatti «nuova», con un non meno fastidioso effetto estetico. A ulteriore conferma dell’immensa confusione che regna nelle Soprintendenze italiane, ma prima ancora dell’assoluta verità dell’affermazione fatta nel 1866 (qui il ritardo diventa d’un secolo e mezzo) da Eugène Viollet-le-Duc, cioè che (cito all’ingrosso) «restaurare un edificio, ma questo vale per qualsiasi manufatto, significa restituirlo in uno stato in cui non è mai esistito». E infatti mai sono esistiti come oggi si vedono né il Colosseo né la facciata del Gesù.
Il ciborio capitozzato
Passiamo adesso al ciborio della Basilica di Santa Cecilia, a Roma, opera eseguita nel 1293 da Arnolfo di Cambio. Qui, durante il rifacimento dell’impianto d’illuminazione della chiesa, si è provveduto a capitozzare quel raro capolavoro dell’arte medievale dell’Occidente, eliminando la parte più alta della cuspide centrale in marmo e contestualmente rimuovendo dai vertici delle quattro guglie laterali i vasi di metallo con i gigli fatti porre in opera dal cardinal Paolo Camillo Sfondrati (che nella Basilica volle essere sepolto) quando alla fine del Cinquecento venne miracolosamente ritrovato proprio sotto il ciborio il corpo incorrotto della Santa, miracolo onorato con la meravigliosa statua realizzata nel 1599 da Maderno. Come si vede, un carico di storia da far tremare le vene ai polsi prima di osare solo sfiorarlo un monumento del genere. Invece? Invece le suore (ma ci dev’essere di mezzo anche qualche architetto, nulla me lo toglie dalla testa) hanno deciso di far capitozzare il monumento e, di fronte a Marina Righetti, professore ordinario che da sempre studia il Medioevo romano e del ciborio conosce tutto a partire dall’integrale autografia arnolfiana, hanno affermato pressappoco con queste parole: «La cuspide è falsa. Poi togliendola si vede meglio il mosaico di Pasquale I nell’abside. Inoltre il nostro non è un restauro, ma una manutenzione». Marina Righetti che, inorridita davanti a quello scempio e alla sostanziale insensatezza delle affermazioni delle suore, ha subito scritto alla nuova soprintendente di Roma, lo stesso architetto denunciato un paio d’anni fa da Italia Nostra perché, quando era a Venezia, faceva allegramente transitare le grandi navi dei turisti davanti a San Marco, ma, almeno fino a qualche giorno fa, non ha ricevuto risposta. A questo punto si tratta di sperare che il mutismo della nostra abbia origine in un’invincibile maleducazione, non nell’impegno a studiare come far passare gli autobus doppi di Rutelli sotto l’Arco di Tito.
Pretesa manutenzione
Concludiamo questa breve e non allegra rassegna del restauro in Italia nell’anno 2015 con un argomento ancora più spinoso, la pretesa manutenzione in corso sugli affreschi della Basilica inferiore di Assisi. Storicamente, questi affreschi sono stati restaurati dall’Icr con l’aiuto, a partire dagli anni Settanta, della Soprintendenza dell’Umbria. Ultimo intervento, tra il 1986 e il 1995, una generale e vera manutenzione dei lavori fatti nei precedenti decenni sugli affreschi dell’intera Basilica, vera manutenzione perché condotta spolverando a secco le superfici dipinte con pennelli di martora, infine operando solo i pochi consolidamenti necessari: teste chi l’ha materialmente eseguita, Paola Passalacqua. Che cosa succede nel frattempo? Che nel 1997 un terremoto causa quattro morti e la distruzione degli affreschi nelle parti apicali della navata centrale della Basilica superiore. Né chiediamoci come mai durante il lavoro di manutenzione di qualche anno prima Icr e Soprintendenza dell’Umbria non avessero fatto condurre un’indagine sul rischio sismico della Basilica, monumento posto tra l’altro in una zona d’Italia ad alto rischio sismico e messo ancora più in pericolo, nel caso d’un simile evento, dalla presenza d’un tetto in cemento armato posto in opera nel 1956 e incredibilmente lasciato ancora oggi in situ. Sia come sia, dopo quel disastro, l’Icr cerca di farsi perdonare intervenendo sulla Vela perduta di Cimabue. Non però eseguendone una copia, come si poteva benissimo fare grazie alle migliaia di copie fotografiche autentiche del manufatto autografo, ma rimettendo in sito una minima parte delle molte centinaia di migliaia di frammenti in cui la Vela è stata letteralmente macinata dal terremoto, rendendone in tal modo per sempre impossibile un loro ritorno a intero. Un intervento tra critico ed estetico nella «ratio 1938» (sempre 77 anni fa) dei soliti Argan, Brandi ecc., il cui risultato è stato l’aver ridotto quel glorioso dipinto a uno sciame di farfalle (i frustoli informi di colore) che vola su una spiaggia (la tinta cosiddetta «neutra»). In sintesi, un restauro insensato dal punto di vista storico, inservibile sul piano critico, inutile in termini iconografici, infine ridicolo, quando non offensivo, se confrontato con l’immensa arte di Cimabue. Quel che allora subito si disse, restauro tuttavia difeso con la solita franca arroganza di chi trova forza, non nella competenza, ma nel ruolo burocratico. L’allora direttrice dell’Icr indicò «pretestuosa la distinzione fra le parole “originale” e “autografo”» di chi voleva porre in opera una copia; affermazione che Claudio Ciociola, tra gli ultimi allievi di Gianfranco Contini, ordinario alla Normale di Pisa e presidente della Società dei filologi della letteratura italiana, commentò così: «Avrei buttato fuori dall’esame qualsiasi studente avesse fatto un’affermazione del genere», mentre oggi la dessa è stata destinata ad ancora più importanti incarichi. Tutto ciò per dire (in via d’ipotesi, sia chiaro) che, vista la verticale caduta culturale dell’Icr attestata dal restauro della Vela di Cimabue, i frati del Sacro Convento hanno deciso di affidare la cura degli affreschi della Basilica inferiore (Giotto, Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Puccio Capanna, insomma una cospicua parte dell’empireo della civiltà figurativa dell’Occidente) a un restauratore di fiducia. Cura degli affreschi seguita da un soprintendente dell’Umbria privo di pubblicazioni su argomenti assisiati, e intervento forse sovradimensionato, visto che la manutenzione degli anni Ottanta-Novanta aveva dimostrato un’ottima conservazione dei dipinti della chiesa inferiore, come dimostrato in re dal non essere caduto nemmeno un loro minimo frammento col terremoto del 1997. Intervento sovradimensionato, tuttavia accettabile quando si fosse operato a secco, con pennelli di martora, fissando l’intonaco solo nei punti in cui minacciava davvero di crollare, né mai toccando (mai toccando, ripeto!) i dipinti con acqua (distillata o meno), tantomeno conducendone una nuova reintegrazione, insomma operando con infinita leggerezza come oggi si fa, ad esempio, nella manutenzione dei restauri nella Cappella Sistina (in Vaticano, Stato estero…), leggerezza non rilevata dalle due funzionarie della Soprintendenza dell’Umbria andate in Basilica a vedere la «manutenzione» in corso sugli affreschi di Pietro Lorenzetti. Nessuna azione ministeriale è seguita all’allarmata relazione fatta dalle due funzionarie su quanto da loro osservato in Basilica. Tomaso Montanari su «la Repubblica» ha denunciato l’irritualità dell’intervento e un sospetto schiarimento generale nel chiaroscuro dei dipinti «mantenuti». Dopodiché silenzio assoluto. I frati si sono messi a chiedere fondi sia per riportare a intero le casse e casse di frammenti rimasti a terra dopo il già visto, assurdo, restauro della perduta Vela di Cimabue (ricomposizione semplicemente impossibile), sia per il restauro degli affreschi eseguiti nel 1365 da Andrea da Bologna nella Cappella di Santa Caterina della chiesa inferiore, affreschi che non hanno bisogno d’un restauro, bensì (forse) solo d’una manutenzione; da eseguirsi a secco, con i soliti pennelli di martora.
Il futuro
Tre vicende, queste appena dette, che molto contribuiscono a far apparire ancora più incerto di quanto già non sia il futuro della conservazione materiale del nostro patrimonio storico e artistico. Futuro fragilissimo perché Mibact e Università mai hanno capito che il loro compito d’istituto non è più il dilettantesco giudicare se la reintegrazione d’una lacuna di restauro ha un’intonazione troppo calda o troppo fredda, com’era nell’intatta, dal punto di vista socio-ambientale, Italia del 1938, bensì di definire con la massima precisione, quindi sulla base di specifiche e ben fondate competenze professionali, il corpo di azione tecnica (formativo, organizzativo, tecnico-scientifico e giuridico) da dare al vero nodo della questione della tutela in Italia, la conservazione preventiva e programmata del patrimonio artistico nel suo insieme e del rapporto tra quell’insieme e l’ambiente in cui da millenni si trova. Questione decisiva ma ancora oggi ignota a Università e Mibact, nonostante la sempre più evidente fragilità di città storiche, monumenti e opere d’arte a fronte di inondazioni, frane, terremoti, speculazione edilizia, radicali variazioni nella distribuzione della popolazione (= spopolamento), fortissimo invecchiamento del clero (l’unico che ancora tiene aperte e custodisce le oltre 100mila chiese storiche italiane), restauri sbagliati e così via. Tanto da non essere in grado, i soliti Mibact e Università, di distinguere tra restauro e manutenzione così che non possano mai esserci infingimenti di specie sul tema, quelli con cui invece professori e soprintendenti (e suore) fanno ormai da più parti fesso e contento chi vorrebbe almeno un minimo di crescita culturale del settore usando l’artificio nominalistico di dichiarare azione conservativa di manutenzione l’immarcescibile restauro critico-estetico-1938; e siamo sempre a 77 anni fa e alla cultura di tutela di Bottai, Longhi ecc., e al non aver ancora capito, Mibact e Università, come i restauri siano sempre potenzialmente dannosi, ancor più quando s’intervenga su opere già restaurate. Tutto ciò premesso mi si consentano tre domande al Ministro Franceschini.
Quali potranno essere le prospettive per la conservazione materiale del patrimonio storico e artistico del Paese quando, come oggi accade, a coordinare le scuole universitarie di restauro è un architetto bocciato al concorso da Ordinario del 2014, scrivendo in sede pubblica la Commissione giudicante che il detto architetto «deve ancora affrontare le tematiche fondanti del settore per potere aspirare a raggiungere la piena maturità scientifica»?
Crede che una Riforma come la sua, che consiste in massima parte nel far ruotare di sede i soprintendenti, possa avere effetto sulla conservazione materiale del patrimonio?
Crede cioè che la Sua Riforma possa avere senso benché non sia stata incardinata a una nuova politica di tutela sostenuta da una nuova legge che non sia l’ennesima rifrittura della legge 1089/39?
Altri articoli dell'autore
L’Italia possiede le linee guida per la prevenzione dei disastri ambientali da quasi 50 anni, ma non le ha mai applicate
Politica, ideologia, burocrazia e miopia hanno cinicamente liquidato la possibilità di preservarci: le non scelte sono i responsabili effettivi dei morti e dei disastri che affliggono l’Italia. Eppure sapevamo. I piani non sono certo mancati
Anche nel turismo l’innovazione senza efficienza fa solo danni