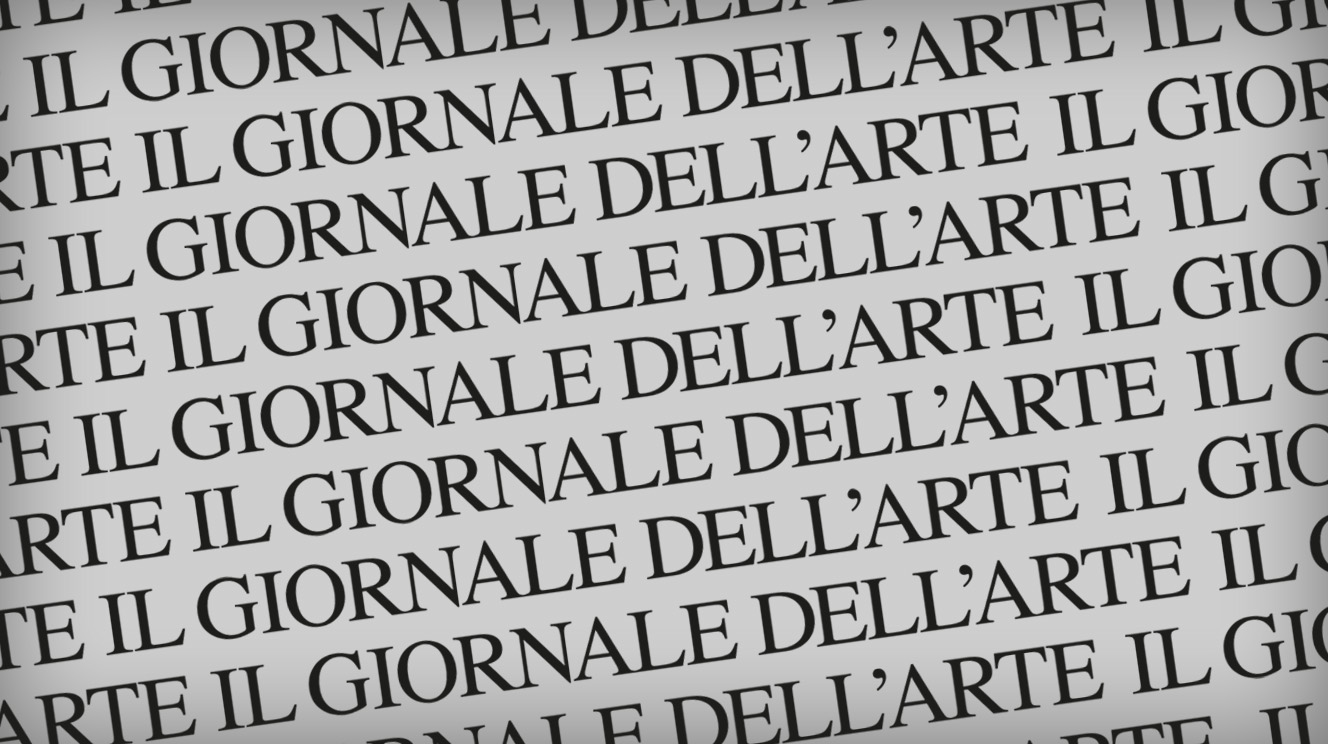Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Lemme
Leggi i suoi articoliLeggi particolarmente protettive per i beni ecclesiastici sottratti o rubati
Basta leggere le cronache giornalistiche per constatare come il fenomeno della sottrazione di beni culturali appartenenti alla Chiesa cattolica e alle sue istituzioni sia in espansione, ponendo problemi tutt’altro che trascurabili per il mercato dell’arte. I furti nelle chiese vengono qualificati come «sacrilegi» e, in taluni ambienti (specie nella cultura contadina) il recupero dei beni rubati viene seguito da riti espiatori, quasi che la comunità dei fedeli (come si dice oggi, «il popolo di Dio») si senta collettivamente responsabile del sacrilegio compiuto con la sottrazione violenta della cosa alla devozione. Purtroppo, i beni rubati non portano impresso il timbro della loro provenienza chiesastica: una volta sottratti, essi si confondono con gli altri beni privati a soggetto religioso, che circolano regolarmente nel mercato dell’arte antica, del quale costituiscono la larga maggioranza.
Di qui, l’esigenza di conciliare due opposti interessi: da un lato, l’affidamento dell’acquirente nella legittimità del possesso di chi risulta venditore; dall’altro, l’esigenza di recuperare, propria di chi sia stato derubato.
Al riguardo si impone un chiarimento preliminare: gli enti ecclesiastici (diocesi, parrocchie, istituti religiosi, seminari, società di vita apostolica ecc.) sono persone giuridiche private, quando costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica e dunque sono assoggettati alle norme privatistiche previste dal codice civile (articoli 1 legge 20/05/1985 n. 222 e 831 codice civile), salvo quanto previsto dalle leggi speciali. Al riguardo l’articolo 10/1 del decreto legge 42/04 prevede che tali beni, appartenendo a enti, sia pur privati, non possano essere alienati, quando sussista un loro qualsiasi interesse lato sensu culturale, senza l’autorizzazione da parte della competente Amministrazione, che può esercitare la prelazione. L’alienazione abusiva, sul piano del diritto civile, è nulla (articolo 164) e il fatto ricade nel delitto di cui all’articolo 173, che punisce tale alienazione abusiva con la reclusione da quindici giorni a un anno, oltre la multa.
La natura delle pene (reclusione e multa) qualifica il fatto come delitto (articolo 39 del codice penale) e pertanto la cosa proveniente da alienazione abusiva si considera come proveniente da delitto e il suo acquisto successivo, avvenuto nella consapevolezza dell’origine ecclesiastica del bene, integra a sua volta il grave delitto di ricettazione (articolo 648 codice penale), punito con la reclusione da due a otto anni. Questo, sul piano strettamente penalistico. Ma come opera l’equilibrio tra i due interessi prima indicati sul piano del diritto civile? Vale a dire:
a. l’acquirente di buona fede di un bene ecclesiastico rubato può invocare la regola di cui all’articolo 1.153 del codice civile e quindi rivendicare un acquisto a titolo originario in virtù di tale norma, che equipara il possesso al legittimo titolo di proprietà?
b. In ogni caso, la nullità dell’acquisto, ovviamente perfezionato in difetto di autorizzazione, non ritenuta necessaria per l’apparente legittimità del possesso del bene, può consentire all’acquirente di beneficiare quanto meno dell’usucapione ventennale?
Esaminiamo singolarmente i due diversi problemi. Una sentenza ormai risalente al 1992 (Cassazione prima sezione civile, 7.4.1992 n. 4260), ma alla quale, a mia conoscenza, non hanno fatto seguito ulteriori e diverse pronunzie, afferma l’inapplicabilità della regola di cui all’articolo 1.153 in quanto tale norma prevede che l’acquisto si perfezioni con la consegna della cosa, ma questa non può aver luogo perché proibita dalle norme di legge. Infatti, l’articolo 61/1 del decreto legislativo n. 42 proibisce la consegna della cosa prima che lo Stato abbia manifestato la sua volontà di esercitare il diritto di prelazione, che a lui compete, come abbiamo già visto. Se nessuno ha notificato allo Stato la vendita intervenuta, la nullità di essa produce l’ulteriore conseguenza che il diritto di prelazione possa essere esercitato senza limiti di tempo.
E, a questo punto, veniamo al secondo problema: può concretarsi l’acquisto per usucapione quando il bene sia soggetto sine die al diritto di prelazione dello Stato? In altri termini, se tale diritto viene considerato imprescrittibile, come potestà pubblica e dunque esercitabile in eterno, nessuna usucapione potrebbe compiersi quanto meno in danno dello Stato.
Peraltro, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo afferma l’esigenza di un «giusto equilibrio» tra l’interesse pubblico generale e l’irrinunciabile esigenza di salvaguardia dei diritti dell’individuo. Proprio in questo contesto, la Corte europea dei Diritti dell’uomo (Cedu), in una sentenza del 5 maggio 2.000 (Beyeler contro Governo italiano: si trattava del diritto di prelazione esercitato dallo Stato italiano per l’illegittima uscita dal territorio dello Stato del famoso «Ortolano del manicomio di Arles» di Van Gogh), ritenne ingiustificato l’esercizio del diritto di prelazione al medesimo prezzo convenuto per la vendita, quando esso era esercitato a un notevole lasso di tempo di distanza dal negozio di alienazione.
Applicando tale principio al caso considerato, quale ne sarebbe la conseguenza?
Il caso appare assai problematico: una sentenza del Consiglio di Stato (sezione VI, 21.02.2002 n. 223) afferma infatti la possibilità dell’usucapione ventennale nel caso di acquisto di beni di enti ecclesiastici. Per contro, la sentenza Beyeler non limita nel tempo il diritto di prelazione ma afferma soltanto che, quando sia decorso un lasso di tempo notevole rispetto alla vendita, il prezzo debba essere adeguato. Quindi, lo Stato potrebbe esercitare senza limiti di tempo il suo diritto di prelazione e la sola conseguenza sarebbe il doveroso pagamento degli interessi, quando il tempo trascorso avesse superato la normale ragionevolezza. Questo lo stato delle cose.
Esorto dunque mercanti e collezionisti ad astenersi dall’acquisto di beni la cui circolazione tragga origine da un furto, anche remoto, agli enti ecclesiastici. Avvertendo inoltre che se il bene offerto in vendita avesse un’originaria, anche remota, destinazione al culto, esso risulterebbe assolutamente inalienabile per effetto della cosiddetto «dicatio ad cultum», ossia una sorta di vincolo di destinazione, che sottrae la cosa a ogni possibilità di circolazione, fino a quando la devozione popolare consideri la stessa ancora come oggetto di venerazione. Quando viene meno la consuetudine sacrale? Nessuno può dirlo: si pensi al Tempio di Gerusalemme e ai suoi divini arredi, il cui uso venne ritenuto sacrilego da Dio, che proprio per questo punì con la morte il profanatore Baldassarre, come rappresentato nello splendido dipinto di Mattia Preti attualmente a Capodimonte.
Altri articoli dell'autore
I beni culturali possono essere dichiarati di particolare interesse solo se la loro esecuzione risalga ad almeno cinquant’anni
La capacità (e l’obbligo) di correggersi della Pubblica Amministrazione
Va introdotta una distinzione tra ricerca significativa e ricerca inutile: la prima aggiunge qualcosa alle conoscenze già acquisite, la seconda si limita a riproporre il «déjà dit»
Il conflitto tra Russia e Ucraina mette in luce un relativismo che parte da Giovanni Battista Vico