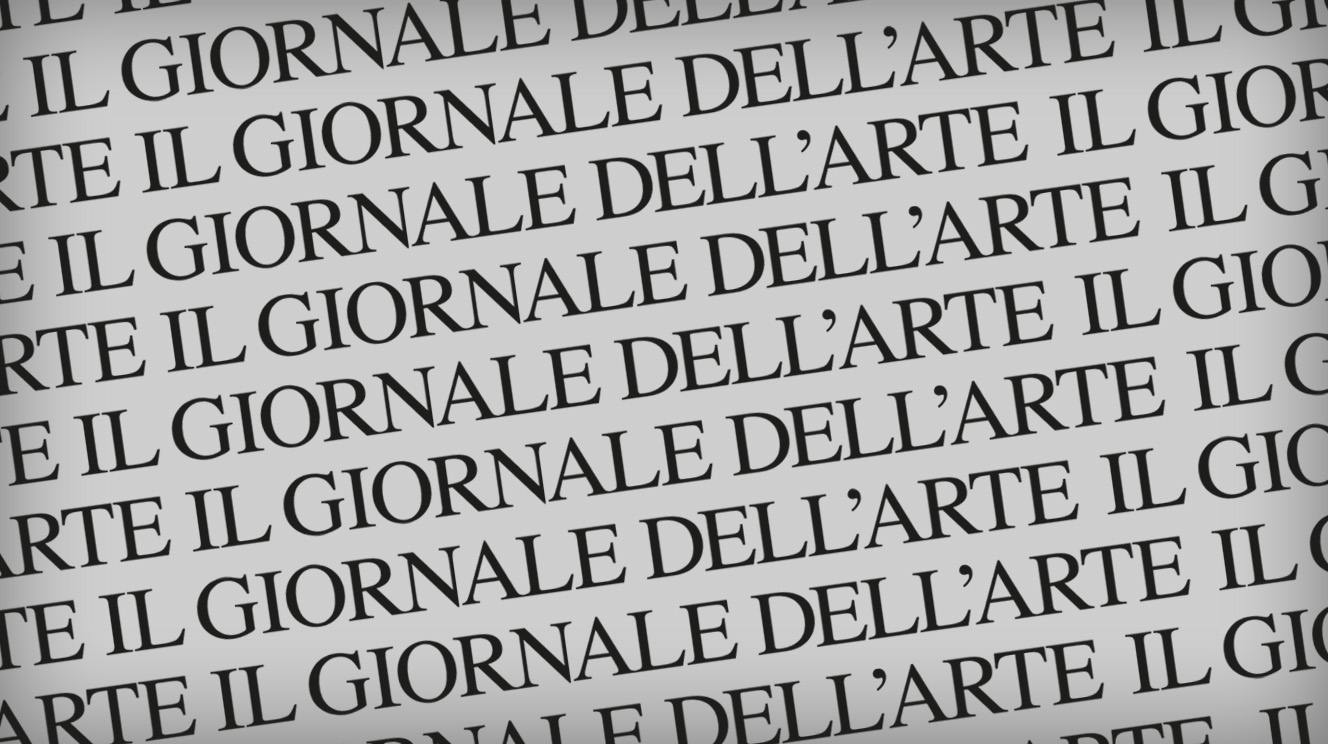Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Giovanna Barni
Leggi i suoi articoliIn occasione della presentazione dei nuovi bandi di gara per la gestione dei servizi museali, la sensazione che abbiamo avuto confermerebbe quanto letto tra le righe negli ultimi mesi negli articoli di giornale (a giugno 2014 Francesco Merlo dalle pagine di «la Repubblica» attribuiva al gestore privato il 50% degli incassi del Colosseo; a novembre Paolo Fantauzzi su «L’Espresso» accusava sempre il concessionario della Domus Aurea -come per il primo caso, Coopculture- di trattenere come aggio il 70% del biglietto, Ndr). I gestori privati dei servizi sarebbero da sostituire con un modello di società in house alla stregua della francese Réunion des musées nationaux, non ancora disponibile ma «in costruzione», e comunque sono additati come unici responsabili, da ormai troppo tempo, della «scarsa redditività per lo Stato», derivante dalla attuale gestione privata dei servizi al pubblico, nonché «dell’abbandono di siti e circuiti cosiddetti minori». Due punti che meritano una risposta non solo perché proprio la Réunion des musées nationaux, che nel decennio scorso fu concessionaria di alcuni musei romani, poi si vide costretta ad abbandonarli a causa di condizioni poco redditive e «vessatorie» per l’impresa; ma anche perché, probabilmente, la rigidità di certe regole e vincoli nel rapporto pubblico-privato hanno in gran parte frenato la crescita e l’espansione del settore.
Sul primo punto, negli ultimi mesi la stampa si è particolarmente impegnata, alimentando una totale confusione tra biglietti e servizi, incassi e guadagni:
sono stati attribuiti ai gestori della biglietteria in proroga oggi, fino al 50% degli incassi, senza conoscere la normativa vigente che limita al tetto del 15% (aggiornato al 30% dopo il D.M. n.222/2005) l’aggio per il concessionario; in alcuni casi è stata attribuita al gestore una quota del 70% del biglietto, laddove non si trattava del biglietto di ingresso ma di quello legato ad un servizio straordinario di assistenza didattica che comporta elevati costi, tutti a carico del gestore e che produce per la Soprintendenza una roy netta del 30%. A titolo esemplificativo si è accusato il concessionario della Domus Aurea di trattenere come aggio ben il 70% del biglietto, senza sapere che alla Domus non esiste un «biglietto», ma un complicato servizio di visita guidata al cantiere, i cui costi sono sostenuti solo dal gestore, cui spettano gli incassi che includono pertanto tutti gli oneri e una roy del 30% alla Soprintendenza; sono stati evidenziati come guadagni, i «ricavi» da didattica, libreria, prenotazioni, caffetteria, confondendo introiti lordi con guadagni nella ripartizione tra Stato e concessionari.
In ogni caso, al di là dei numeri errati, occorre chiarire soprattutto che:
a) i ricavi dei servizi servono innanzi tutto per coprire i costi esclusivamente a carico del gestore (personale di front office e di back office e relative spese di coordinamento, le tecnologie di supporto, le spese generali, gli investimenti per arredi e attrezzature, i prodotti editoriali e di fruizione);
b) molti costi sono fissi, non variabili, quindi spesso (e facilmente nei musei sotto i 100mila visitatori) non generano guadagni quanto piuttosto perdite, anch’esse solo a carico del concessionario;
c) le concessioni in essere sul territorio nazionale non sono tra loro confrontabili dal momento che i costi a carico del concessionario cambiano rispetto al tipo di contratto stipulato di volta in volta tra le parti.
A ciò si aggiunga un altro tipo di valutazione, cui nessuno ha mai accennato, ovvero quella che misura anche quei fattori di «utilità sociale» che l’impresa culturale apporta ben oltre la redditività derivante dagli incassi. Tanto per citarne alcuni:
a) il gettito fiscale proveniente dalla tassazione ordinaria (Irap, Ires, oneri sociali/Inail quota aziendale, Iva sui ricavi) e da una tassazione indiretta (oneri sociali quota dipendente, Irpef dipendenti) a favore dello Stato: per fare un esempio che ci coinvolge da vicino, solo nel 2013 CoopCulture ha riversato nelle casse dello Stato, nelle forme descritte, quasi 18 milioni di euro pari al 38% del proprio fatturato tra tasse dirette e indirette;
b) fornire un’occupazione qualificata in un settore in cui le assunzioni sono ferme da anni (solo in CoopCulture sono in servizio oltre 1.200 professionisti di cui l’84% inquadrato a tempo indeterminato);
c) innescare occasioni di fatturato e di crescita all’industria creativa nel suo complesso per il tramite dei servizi aggiuntivi (editoria, tecnologia, performing arts, marketing e comunicazione..);
d) valorizzare un’intera filiera produttiva in termini di accoglienza di qualità, efficacia organizzativa, stimoli all’industria turistica (agenzie di viaggi, tour operator,..).
In tema di valorizzazione dei siti minori, secondo punto della nostra analisi, siamo davvero convinti dell’urgenza di estendere servizi e qualità della fruizione anche a quel patrimonio minore diffuso che costituisce la vera ricchezza italiana, nonché una imperdibile occasione per creare reddito e occupazione. E la forma cooperativa risulta essere, proprio in queste situazioni, quella che più di altri permette una migliore aderenza ai territori e ai loro circuiti.
A questo obiettivo, che è da inquadrarsi nell’ambito di una progettazione integrata di valorizzazione più complessa, il privato, anche cooperativo, può contribuire, certamente non da solo.
Molte pubblicazioni e altrettanti convegni si sono espressi negli ultimi anni in tal senso, individuando ipotesi di lavoro importanti, applicabili soprattutto al sistema dei circuiti minori.
Ricordiamo ad esempio la proposta di messa a sistema territoriale dei servizi, tale da consentire evidenti economie di scala, e un diverso modello, più flessibile, di fruizione dei siti in ordine ai giorni e agli orari di apertura. Nonché l’integrazione dei servizi in concessione con i servizi strumentali in appalto, che potrebbe offrire ulteriori economie di gestione utili a garantire gli standard minimi di fruizione anche per un patrimonio minore e diffuso e, al contempo, la possibilità di sviluppo di una rete imprenditoriale, in specie cooperativo. Ancora, è stata avanzata e motivata l’ipotesi di un’eventuale eliminazione, su questi siti, del limite massimo di aggio (oggi pari al 30% del totale degli introiti di biglietteria). Operazione, questa, da condursi con il minimo sforzo da parte dello Stato e una resa più sostenibile per le imprese.
Monitoraggio e valutazione dei benefici, integrazione dei servizi in funzione di una classificazione per cluster del patrimonio (siti maggiori/medi/minori) e dei contesti territoriali, misure per la sostenibilità del patrimonio diffuso, interventi di sostegno alla domanda e audience development, così come caldeggiati in Europa. Sono questi i temi «nuovi» sui quali ci piacerebbe aprire una fase di dialogo in vista dell’emanazione delle nuove gare, a tutela dei risultati fino ad oggi raggiunti e nell’obiettivo comune di migliorarli.
Articoli correlati:
Servizi aggiuntivi nei musei statali. Consip prepara le gare
Miraggio Consip
Altri articoli dell'autore
Il secondo lockdown rischia nel 2021 la dispersione di un capitale umano indispensabile. Il caso: duemila professionisti senza ristori fino a quando?