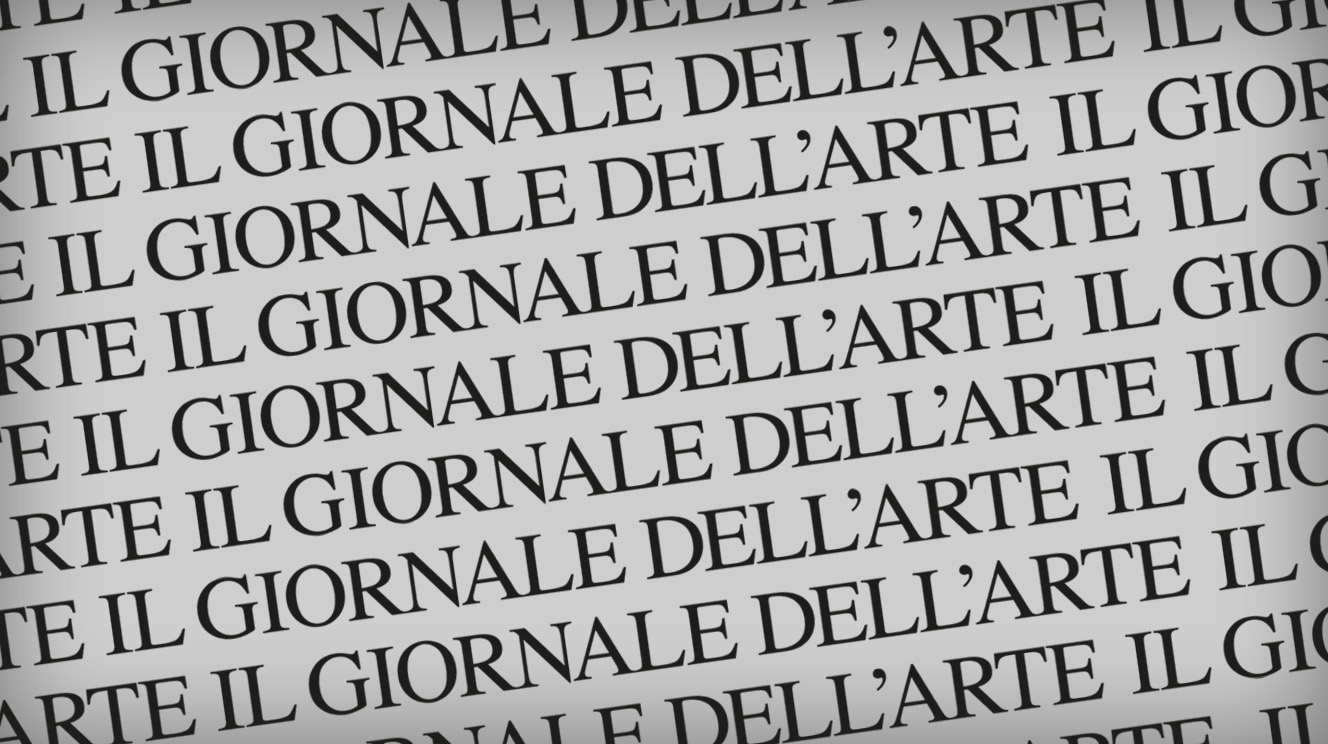Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Castelli Gattinara
Leggi i suoi articoliNon solo Impressionisti in questo autunno romano. Per fortuna esistono ancora mostre di studio, intelligenti e raffinate, che gettano sguardi differenti sull’arte dei secoli passati.
E di questo si tratta, nel caso di «Raffaello, Parmigianino, Barocci. Metafore dello sguardo», a cura di Marzia Faietti, direttrice del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi ed esperta di Rinascimento italiano, organizzata da MetaMorfosi ai Musei Capitolini, dal 2 ottobre al 10 gennaio (catalogo Palombi).
«Mi avevano proposto una mostra su Raffaello, racconta la curatrice, argomento facile e difficile allo stesso tempo, un nome grande ma troppo inflazionato, con le monografiche al Prado e al Louvre, le mostre in programma a Oxford, Vienna e Venaria, un vortice che trovo noiosissimo».
È a quel punto che nasce l’idea di una rassegna sull’urbinate visto attraverso gli occhi di due artisti non coevi ma sempre del Cinquecento, sul concetto di «tramando», affrontato però dalla parte degli artisti e non degli storici dell’arte. Dato poi che la collezione di disegni e stampe che la Faietti dirige ha due cospicui fondi di Parmigianino e di Barocci, due maestri molto diversi tra loro ma entrambi storicamente associati a Raffaello e grandissimi disegnatori come lui, il cerchio si è chiuso.
74 le opere esposte, in gran parte disegni, qualche stampa e una manciata di dipinti, seguendo il fil rouge dello sguardo, dei più giovani Parmigianino e Barocci su Raffaello, delle fonti cinque-seicentesche (volutamente non oltre) su loro che guardano a Raffaello, ma anche il nostro su questi tre giganti dell’arte e il loro su di noi, attraverso pochi scelti ritratti: l’«Autoritratto» di Raffaello, quello di mezza età e il «Ritratto di giovane donna» di Barocci dagli Uffizi, l’«Antea» di Parmigianino da Capodimonte (però non certa perché già promessa a un’altra mostra), due capolavori di Barocci dei Vaticani (la «Madonna delle ciliegie» e l’«Annunciazione»).
«La mia attenzione sullo sguardo, spiega la Faietti, ha una dimensione piuttosto ampia, come “tramando” tra artisti, come visione all’interno della propria opera o all’esterno, perché tutti sono stati chiamati a dare una rappresentazione spaziale postalbertiana, convincente per la loro epoca, e ognuno lo ha fatto a modo suo».
Parmigianino e Barocci sono due figure antiaccademiche, anarchiche, fuori dal coro, che non potevano piacere a Vasari. Del primo, elegante e raffinato, le fonti sottolineano la grazia, la soavità, la bellezza; ne fanno una sorta di «Raphael redivivus» in cui sarebbe trasmigrata l’anima del maestro. Il secondo è acclamato come la nuova gloria di Urbino, che riprenderà finalmente il percorso aperto dal maestro. In realtà il Parmigianino sarà «l’alter Raphael», come lo chiama la Faietti, si differenzierà da quella matrice divenendo un artista molto intellettuale e all’avanguardia. Barocci invece da Raffaello assumerà più che altro il metodo, il famoso «ottimo universale», l’eclettismo che lo renderà capace di combinare tra loro filoni culturali diversi, Venezia, la Lombardia, il centro Italia e Roma. Tutti e due si possono leggere come vie alternative rispetto all’Italia artistica di Vasari, ma entrambi guardano a Raffaello, e consentono anche a noi di guardare a lui con altri occhi. Dopo le fonti e gli artisti, l’ultima parte della mostra è dedicata ai temi: lo specchio, lo sguardo e il volto, la metafora della finestra analizzata soprattutto nel Parmigianino.
«Se l’ultimo Raffaello tenta di superare il quadrangolo albertiano potenziandolo, cercando una spazialità infinita, che sarà quella da cui parte Correggio per le sue cupole, conclude la Faietti, il Parmigianino ne rovescia i termini, ribalta tutto sul primo piano, con la composizione che esce verso di noi, si pensi agli affreschi della Steccata. Una soluzione di una modernità sconcertante e una delle sue eredità più belle».
Altri articoli dell'autore
Tra Foro Romano e Palatino sono stati ritrovati i resti di una lussuosa dimora con una sala per banchetti a forma di grotta e uno straordinario mosaico impreziosito con conchiglie, vetri e tessere blu egizio
Si inizia con l’enigmatico scultore ateniese. Altre due monografiche saranno dedicate a Prassitele e a Skopas
Stéphane Verger nel chiostro di Michelangelo ha fatto eseguire interventi su sette teste di animali antiche (quattro di età adrianea e tre rinascimentali) e ne ha commissionata un’ottava a Elisabetta Benassi
Lo scavo condotto dalla Soprintendenza speciale di Roma ha riportato alla luce strutture in laterizio e un sontuoso apparato decorativo riconducibili a una committenza di altissimo rango, quasi sicuramente imperiale