
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Silvia Mazza
Leggi i suoi articoliSiracusa. Anche quest’estate il «Seppellimento di santa Lucia» del Caravaggio dovrà sostenere condizioni conservative proibitive nella chiesa eponima della Badia, in Ortigia, in cui fu trasferito, si disse «provvisoriamente», sei anni fa. Stando, infatti, al monitoraggio microclimatico effettuato dal Centro per il Restauro (Crpr) di Palermo nell’arco di un anno solare (2014-2015), i valori della temperatura e dell’umidità relativa rilevate nella chiesa da luglio a settembre sono al di sopra dei limiti massimi con percentuali che si attestano anche al 100%. Dati resi pubblici in occasione della conferenza organizzata il 18 maggio scorso dal direttore del Museo Bellomo Lorenzo Guzzardi in risposta agli interrogativi che ponevamo sullo stato conservativo e la valorizzazione del dipinto. La Soprintendenza, però, non sembra avere particolare fretta nel risolvere la faccenda: «il quadro gode di ottime condizioni ed è tenuto di continuo sotto controllo», si legge in una nota pubblicata a seguito del dibattito sulla pagina Facebook, a firma della soprintendente Rosalba Panvini e della dirigente della sezione per i beni Architettonici storici-artistici, Fulvia Greco. Tutto sotto controllo, dunque, malgrado il microclima estremale e l’incredibile circostanza per la quale il dipinto sia anche addossato alla legittima pala d’altare, fatto in sé già deprecabile per la totale disattesa delle basilari nozioni sulla valorizzazione e fruizione delle opere d’arte, anche se si trattasse di un’opera «minore» e non del polidoresco Deodato Guinaccia, e che diventa ancora più grave per tutta una serie di criticità che potrebbe innescare sotto il profilo conservativo. A rischio di contemporaneo degrado sono esposte, infatti, entrambe le opere d’arte, come ha spiegato durante il suo intervento del 18 al Bellomo il prof. Franco Fazzio, che aveva preso parte alle indagini diagnostiche eseguite sul dipinto dallo stesso Crpr nel 2006: «il dipinto di Caravaggio è stato restaurato presso l’ex Icr di Roma tra gli anni 1972-79 e rintelato con la tecnica definita “classica” in quanto basata sull’utilizzo di materiali tradizionali, quasi esclusivamente di natura organica, come gelatine animali e adesivi a base di farine vegetali. Queste, in condizioni microclimatiche ideali costituiscono un perfetto terreno di coltura per lo sviluppo di microrganismi, in particolare da parte di spore fungine. I valori non ottimali rilevati nella chiesa offrono seri spunti per un attacco da agenti biodeteriogeni che avrebbero come terreno di coltura l’opera del Caravaggio e da questo la facile propagazione al dipinto subito dopo retrostante, vittima di un microclima ad effetto serra».
Ma al «Seppellimento di santa Lucia» serve un nuovo intervento conservativo?
L’intervento di Fazzio è stato, peraltro, degno di interesse, in quanto ha segnalato per la prima volta un errore in un restauro, quello del prestigioso istituto romano, che pure ha fatto giurisprudenza (diretto da Alma Maria Mignosi Tantillo e Michele Cordaro, condotto da Laura e Paolo Mora). «Durante la campagna di indagini del 2006, la fluorescenza in ultravioletto, ha spiegato il restauratore, ha consentito la lettura delle stesure dei vari strati di vernici applicate sulla superficie pittorica del dipinto del Caravaggio. Il risultato sorprendente metteva in luce la notevole disomogeneità di questo film protettivo fatto di grossi scompensi, discontinuità e ossidazioni a varie intensità, con disturbo, nel visibile, della giusta lettura dell’intera superficie pittorica». Ma non è tutto. «Altro aspetto significativo è che la stesura delle vernici è avvenuta col dipinto non posto in piano orizzontale, come prassi richiede, ma disposto e posizionato di fianco e/o di taglio, oltretutto orizzontalmente rispetto alla verticalità della scena. Tutto ciò, come operazione, sarebbe poco discutibile se non si notasse, in più parti della superficie, la maldestra stesura con pennellate abbondanti, tali da aver prodotto vistose percolature».
Soprintendenza-mostrificio
E mentre la tutela viene interpretata in modo discutibile, vale la pena, forse, ricordare che nella stessa chiesa in piazza Duomo l’estate scorsa, quando erano già note alla Soprintendenza le condizioni ambientali di cui si è detto, la soprintendente Panvini aveva allestito (lei archeologa) una mostra sul Barocco in cui quindici oli di Mattia Preti venivano accostati al capolavoro dell’ultimo Caravaggio. Cocuratore non uno storico dell’arte, come pure avevamo scritto «ingenuamente» anche noi, ma un geologo, Franco La Fico Guzzo. Era stata anche l’estate in cui, sempre l’archeologa, aveva curato una mostra sul Rinascimento, trasferendo l’«Annunciazione» di Antonello da Messina dal Bellomo nel Museo archeologico (!) di Palazzolo Acreide, paese ad appena 40 km da Siracusa, con dubbio bilanciamento delle ragioni conservative e dei profili culturali e scientifici sottesi all’operazione. Quest’estate, invece, ai già insolitamente numerosi eventi espositivi che si possono intestare negli ultimi anni all’istituto preposto alla tutela, il mostrificio si arricchisce di un’esposizione di nuovo a Palazzolo Acreide, stavolta al Museo dei Viaggiatori, museo privato per il quale sono stanziati sedici mila euro. Lo consente una circolare dell’aprile scorso, quella che ha stabilito che il 30% dello «sbigliettamento» sia sottratto al bilancio indistinto della Regione, destinandolo all’Assessorato Beni culturali e Identità siciliana e che prevede eventi in partenariato con soggetti privati. Una bella cifra se si pensa che ai poli museali regionali sono stati assegnati (a ciascuno) appena 2.000 euro e che alla stessa Soprintendenza non si trovano i soldi per ripristinare le linee telefoniche e il sistema informatizzato, con evidenti rallentamenti anche nel rilascio di autorizzazioni e pareri, e quindi nel fondamentale esercizio della tutela, come denunciato dall’esasperato personale interno: malgrado la scarsa attenzione ai vertici, alla base resiste la coscienza della propria mission istituzionale. Insomma, una misura in sé buona, ma che non può non fare avvertire una volta di più il peso dell’assenza di quel Consiglio Regionale Beni culturali di cui abbiamo denunciato il mancato reinsediamento da ben otto anni e che servirebbe anche a valutare la qualità di eventi come questi, garantendo che le magre risorse siano indirizzate a quelli davvero meritevoli.
Quando e come il Caravaggio rientrerà alla Borgata?
Un organo, quest’ultimo, il cui pronunciamento sarebbe stato quanto mai auspicabile proprio nel caso del «Seppellimento di santa Lucia». La questione, infatti, della restituzione del dipinto alla chiesa originaria, da noi sostenuta con argomentazioni anche inedite utili a sottolinearne ulteriormente l’intima connessione storico-artistica col monumento, richiederebbe infatti il contemperamento di più fattori, da quelli conservativi, si è detto, a quelli della valorizzazione dell’opera e alla riqualificazione della piazza in cui si trova la chiesa di Santa Lucia Extra Moenia e più in generale del quartiere della Borgata in cui ricade. La Soprintendenza, invece, stando a quanto ha dichiarato la Greco al «Giornale di Sicilia» (29 mag. ’17) ha già cominciato «i lavori per l’adeguamento microclimatico della chiesa», i cui parametri termoigrometrici, rilevati dal monitoraggio microclimatico condotto in parallelo anche su questa chiesa dal Crpr, sono risultati altrettanto inadeguati. Non si capisce, dunque, perché si starebbe valutando anche «la possibilità di una grande teca di vetro per il quadro», soluzione che noi stessi abbiamo sostenuto intervenendo alla conferenza del Bellomo, recuperando una proposta (mentre la Greco ce ne attribuisce la paternità) avanzata dal Crpr quando l’opera, oltre dieci anni fa, fu ricondotta alla Borgata: soluzione comunque di compromesso che, difficile negarlo, non potrà che interferire con la piena godibilità del dipinto. Ma, allora, si interviene sulla chiesa e anche sul quadro: quale il motivo di questa ridondanza? E esistono, poi, già dei preventivi per cui si possa sostenere, come si legge nello stesso articolo, che i costi di questa teca microclimatizzata siano equiparabili a quelli di un intervento sull’intero monumento?
Il parere del tecnico
A questo punto non sarebbe opportuno chiedere parere all’Iscr e/o al Crpr? È davvero possibile intervenire efficacemente sulla chiesa o esistono sistemi alternativi alla teca per isolare il dipinto da essa? È quanto abbiamo domandato a Roberto Ciabattoni, del Laboratorio di Fisica dell’Istituto romano. La sua premessa, intanto, conferma le carenze di chi avrebbe dovuto tutelare il dipinto: «uno dei principali fattori che determinano il degrado di un manufatto è il rapporto di scambio termo-igrometrico con l’ambiente circostante: parametri microambientali sbagliati possono danneggiare il manufatto in breve tempo o determinare le condizioni generatrici di un lento ma costante deterioramento». Venendo, dunque, al nostro quesito, per il tecnico «la soluzione ottimale sarebbe quella di condizionare l’ambiente o, in alternativa, una porzione di esso. Per esprimermi su queste ipotesi dovrei visionare i luoghi, pertanto la considero una possibilità “da verificare”. Quando non è possibile intervenire su tutto l’ambiente espositivo, si cercherà di proteggere l’opera creando zone condizionate mediante l'attuazione di una climatizzazione “zonale” , realizzata tramite “flussi di aria canalizzati”, che garantiscano un ricircolo di aria trattata nella zona “attorno” al manufatto. Ove non fosse attuabile, si può intervenire circoscrivendo l’ambiente climatico con la collocazione dell’opera all'interno di un ambiente confinato e controllato (vetrina climatizzata). Pertanto la soluzione della teca, escludendo l'ipotesi di potere climatizzare tutto o parte dell'ambiente espositivo, è quella che potrebbe garantire una corretta conservazione». Oggi, dunque, si è in grado di condizionare un’ambiente, una porzione di esso o un contenitore, ma, precisa Ciabattoni «trattandosi di sistemi attivi, dobbiamo dotarli di dispositivi di controllo e, all’occorrenza, intervenire con gli aggiustamenti necessari, ovvero devono essere manutenuti». A tutto questo si riferisce la Greco quando parla di «lavori per l’adeguamento microclimatico della chiesa»?
Se, però, guardiamo ad altri celebri casi, quella della climatizzazione «zonale» sembra essere una soluzione virtuosa con scarsa applicazione anche fuori dall’isola, e che in definitiva si scontra con i limiti di un approccio alla tutela incapace ad attribuire valore prioritario alla prevenzione e alla manutenzione. Prendiamo proprio il caso di altre opere del Caravaggio, quelle della cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi per la quale era stato proposto e non realizzato; qualcosa di simile era stato fatto per il Cenacolo vinciano a Milano, ma fortemente criticato, mentre agli Scrovegni a Padova era stato ipotizzato, ma poi si è finito per realizzare la climatizzazione su tutto l’ambiente.
C’è poi un’altra questione: il Comune è stato coinvolto in questa operazione, dato che proprio la mancata riqualificazione della piazza in cui insiste la chiesa è stato uno dei principali motivi del flop dell’operazione che tra il 2006 e il 2011 aveva già ricondotto il Caravaggio nel quartiere della Borgata? Anche se allora si disse che il successivo trasferimento alla Badia era stato dovuto a ragioni conservative e oggi invece sappiamo che anche la chiesa di piazza Duomo non ne offre affatto di migliori. Secondo le guide «l’aspetto più critico è legato all’accessibilità, ci dice Pietro Piazza, gruppi sia di giovani che di anziani lamentano l’eccessiva distanza da percorrere (700 m a piedi in discesa, che al ritorno vogliono dire in salita) dal parcheggio in cui vengono lasciati i pullman e la mancanza dei servizi (un solo bar con l’unico wc della zona). Inoltre il quartiere si presenta sempre trasandato e trascurato, dando l'impressione di essere una zona malfamata».
In conclusione, quella che servirebbe è un’azione di concerto: Regione (Soprintendenza), Fec, proprietario del dipinto, e Comune «non possono mancare a questo compito di civiltà», per usare le parole di Brandi sulla destinazione del dipinto all’indomani del restauro degli anni ’70. Se ancora una volta non ci si dimostrerà all’altezza del compito, non sarà allora tanto meglio ripensare seriamente a una definitiva musealizzazione del capolavoro?

Particolare del «Seppellimento di santa Lucia» di Caravaggio
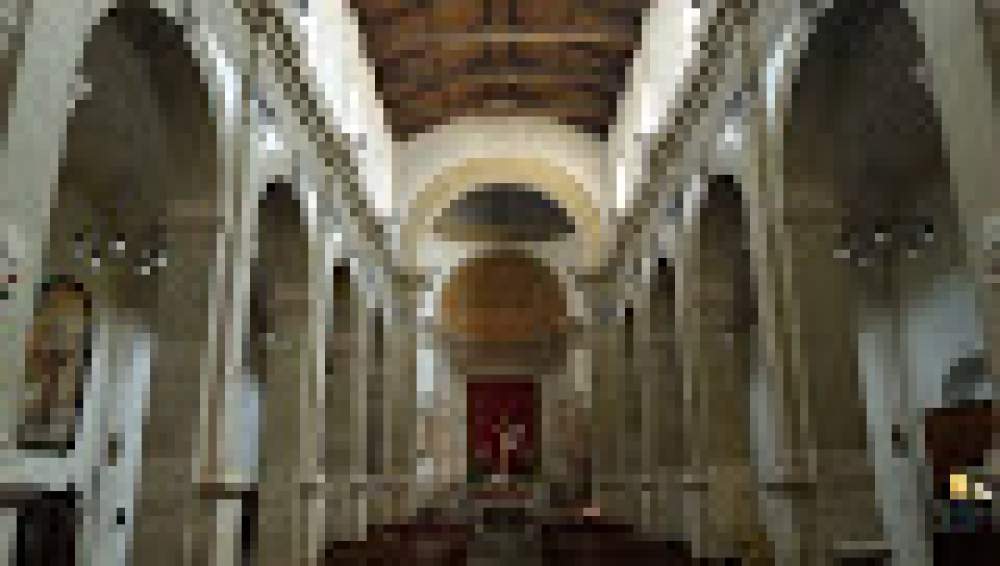
La Chiesa di Santa Lucia Extra Moenia

La chiesa della Badia in Ortigia
Altri articoli dell'autore
La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera
Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni
Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma
Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.



















