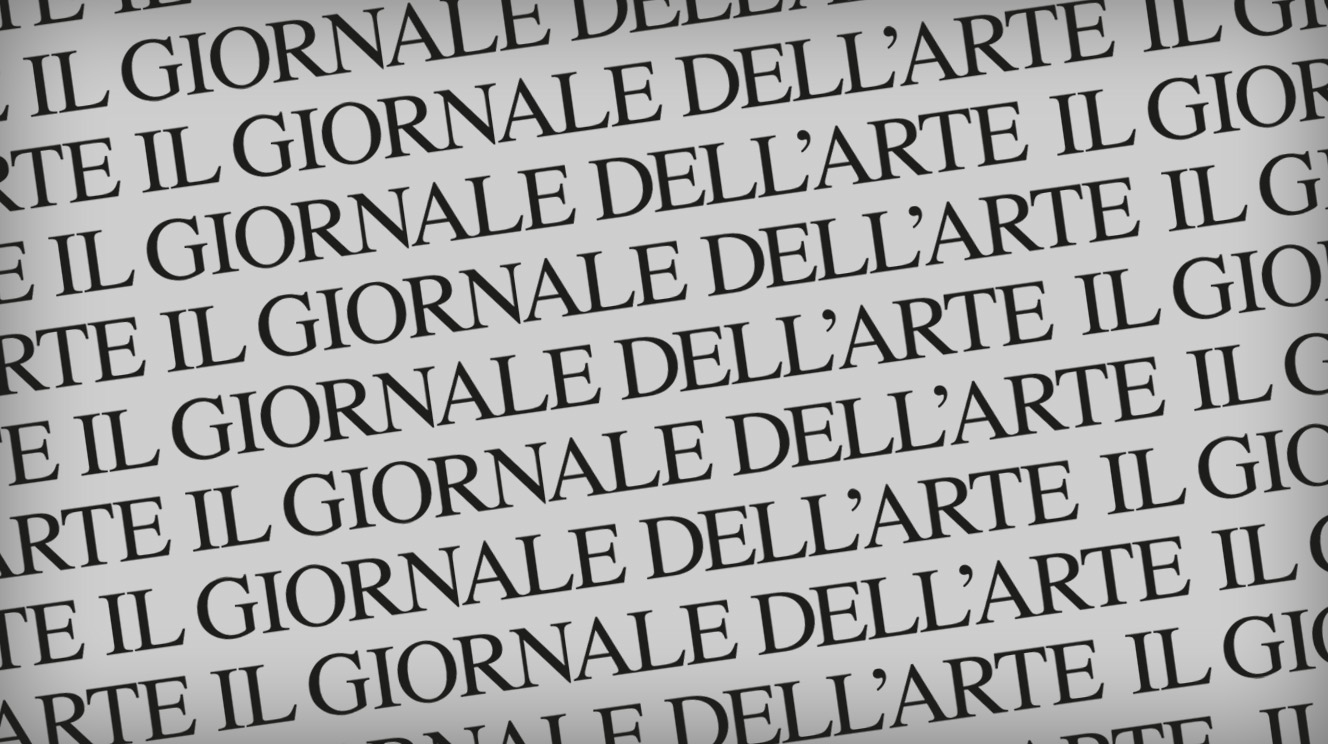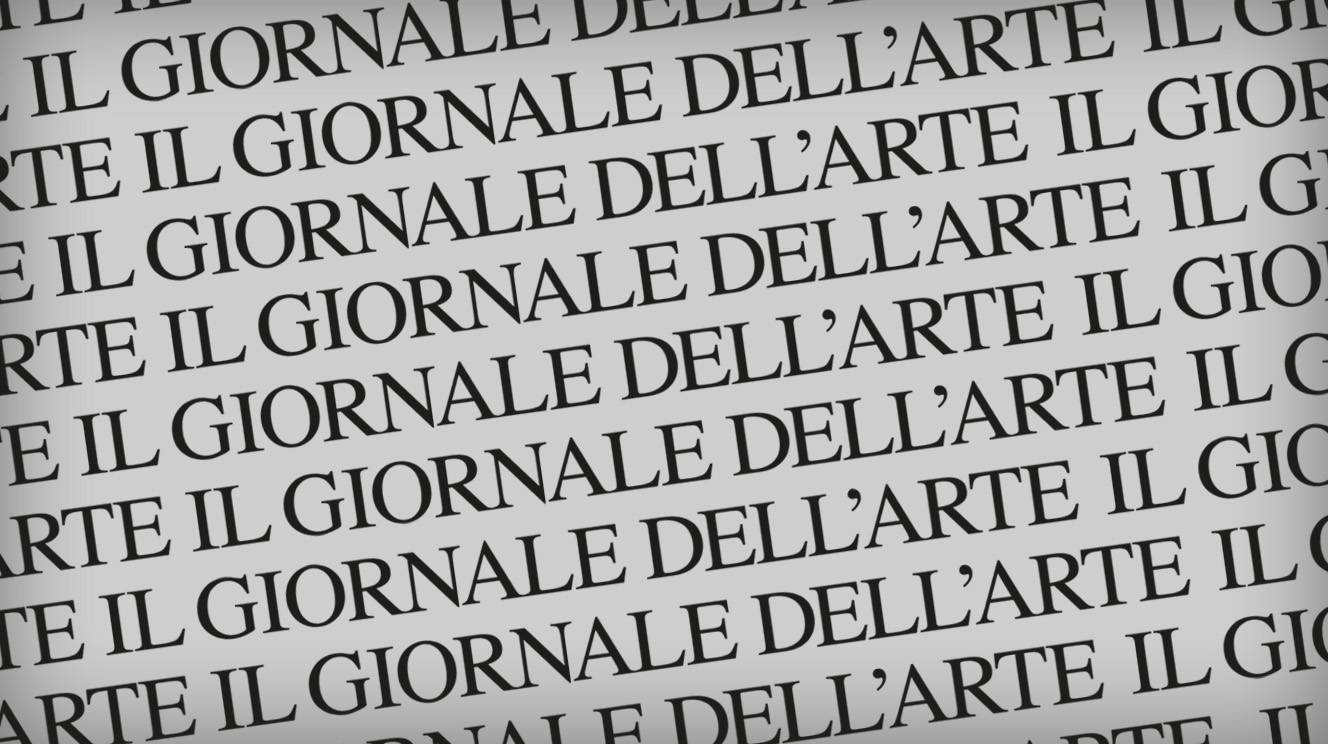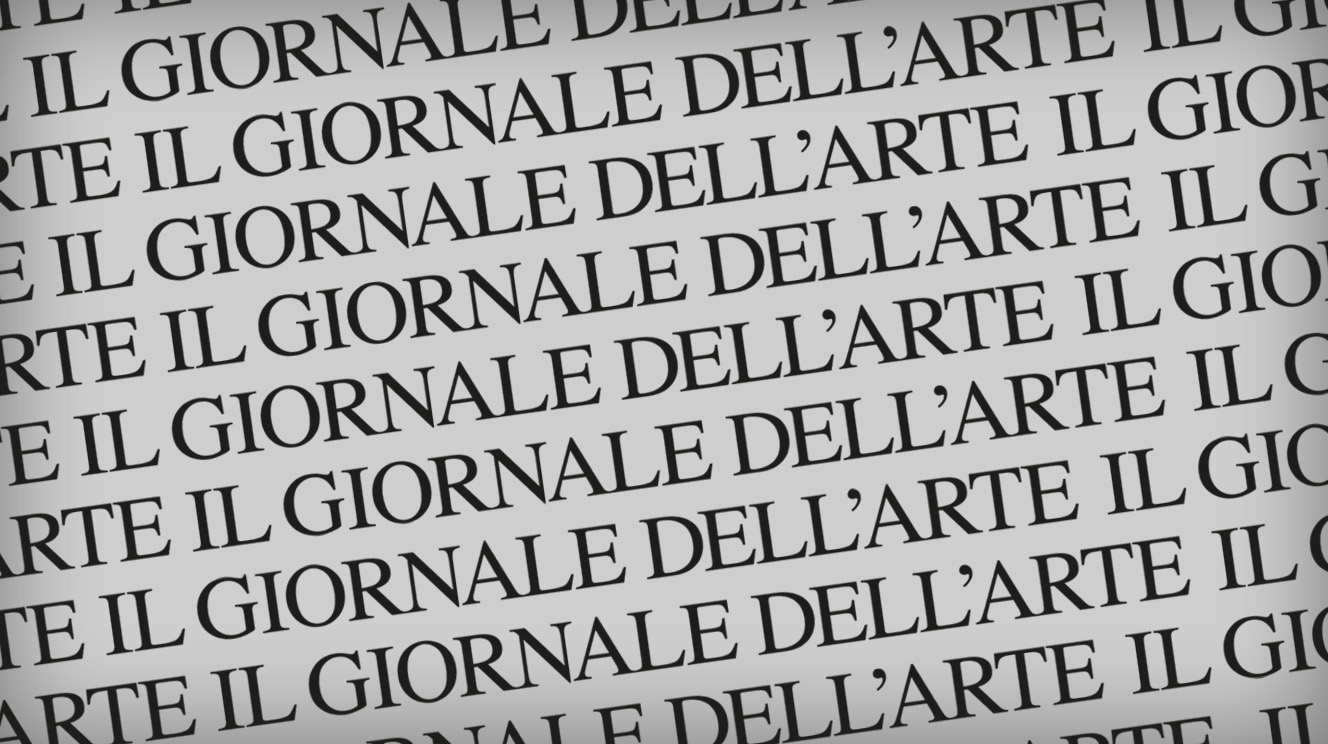Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Massimiliano Capella
Leggi i suoi articoliIl patrimonio tessile indiano è al centro della mostra «The Fabric of India» che il Victoria and Albert Museum di Londra presenta fino al primo gennaio come evento principale del tradizionale V&A India Festival. Il percorso illustra attraverso duecento pezzi la maestria tecnica e la creatività dei maestri tessutai indiani, con esemplari datati dall’età tardoantica all’età contemporanea. Si passa da tessuti più ordinari ai pregiatissimi e colorati sari da cerimonia, dai paramenti sacri antichi alle bandane di moda sin dal XVIII secolo, fino alla spettacolare tenda utilizzata dal sultano Tipu (1750-99), sovrano della dinastia di Mysore, allestita nella galleria centrale della mostra e visitabile al suo interno per poterne ammirare la dettagliatissima decorazione. L’introduzione alla mostra rivela i processi creativi per la realizzazione a mano dei tessuti indiani, partendo dalla materia prima, dalle fibre di seta al cotone e alla lana, che rappresentano una delle principali risorse naturali dell’India. Parte integrante della lavorazione tessile sono il processo di tintura, che utilizza solo coloranti naturali come il melograno e l’indaco, e le complesse tecniche di stampa e di ricamo che si sono tramandate attraverso i secoli. La lavorazione del tessuto indiano più degli altri è emblematica della ricchezza, del potere e della devozione religiosa del suo popolo: i tessuti sacri realizzati per templi e santuari sono certamente quelli che vantano l’impiego dei migliori materiali disponibili e del più alto livello tecnico di decorazione. Tra i tessuti religiosi di maggior pregio in mostra figurano un panno narrativo in lampasso di seta risalente al 1570 ca, raffigurante gli antenati della divinità Vishnu, esposto accanto a una camicia del XVI secolo con incisi in inchiostro e vernice d’oro i versetti del Corano. La mostra celebra anche l’opulenza della lavorazione riservata ai tessuti destinati alle corti, in modo particolare a quelle delle dinastie Mughal e Deccani nel XVIII secolo, e l’importanza per l’economia indiana dell’esportazione dei tessuti a livello globale fin dall’età antica, come dimostrano tre frammenti superstiti di tessuti indiani risalenti al IV secolo. Tra i materiali destinati all’esportazione sono presentati anche tessuti che rivelano l’eclettismo degli artigiani indiani ad adattare i disegni e le tecniche di lavorazione a una vasta gamma di mercati differenti, come nel caso del blocco tessile stampato nel XV secolo destinato all’Indonesia e in una serie di arazzi, copriletti e abiti per il mercato europeo, realizzati in robusto tessuto di cotone indiano chintz, popolarissimo in tutta Europa tra XVII e XIX secolo, come rivela anche l’esposizione di biancheria da letto appartenuta al principe Eugenio di Savoia (1663-1736). La fortuna di alcuni tessuti e soprattutto dei motivi decorativi indiani ha portato presto alla nascita di un largo fenomeno di imitazione (già nel XIX secolo), con la produzione di tessuti indiani «made in Europe».
In contrapposizione a questa tendenza, all’inizio del XX secolo, la lavorazione tessile indiana è diventata sempre più un importante simbolo della resistenza al dominio coloniale, e nel 1930 il Mahatma Gandhi chiese al popolo indiano di filare e tessere rigorosamente a mano, creando un panno tradizionale, il Khadi, divenuto uno strumento politico del movimento di indipendenza. Accanto a questi aspetti sociali e politici la mostra si conclude con uno sguardo sulla nuova fioritura dell’industria tessile indiana legata alla moda contemporanea: molti designer indiani come Manish Arora, Abramo e Thakore, Rahul Mishra, Rajesh Pratap Singh e Aneeth Arora utilizzano infatti tecniche handmaking fantasiose che hanno permesso una rapida affermazione internazionale. Il sari, l’abito tradizionale dell’India, resta ancora il capo centrale nella produzione di moda dei giovani designer emergenti, sempre più inteso come elemento per coniugare design innovativo con un’identità tradizionale unica.
Altri articoli dell'autore
Nel 1980 Roberto Capucci decide di presentare le sue creazioni solo nei musei: l’abito diventa pittoscultura degna della Biennale di Venezia