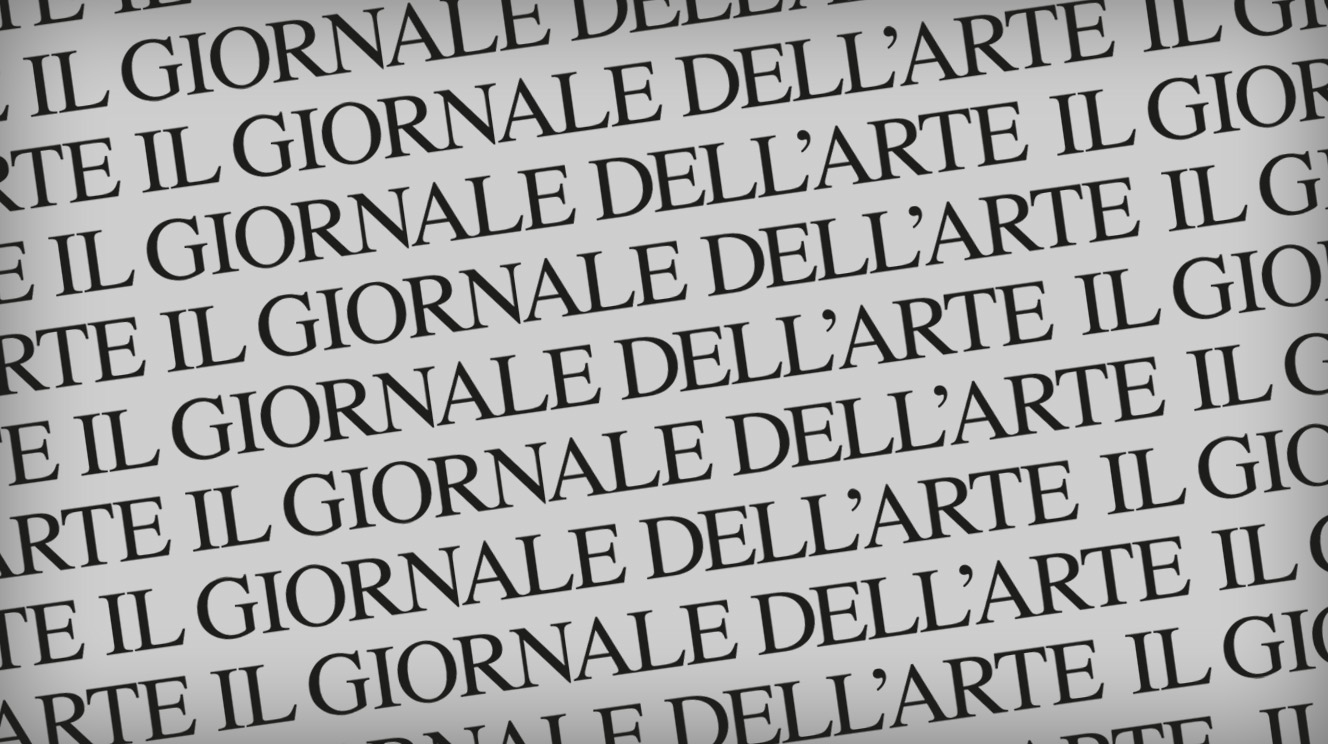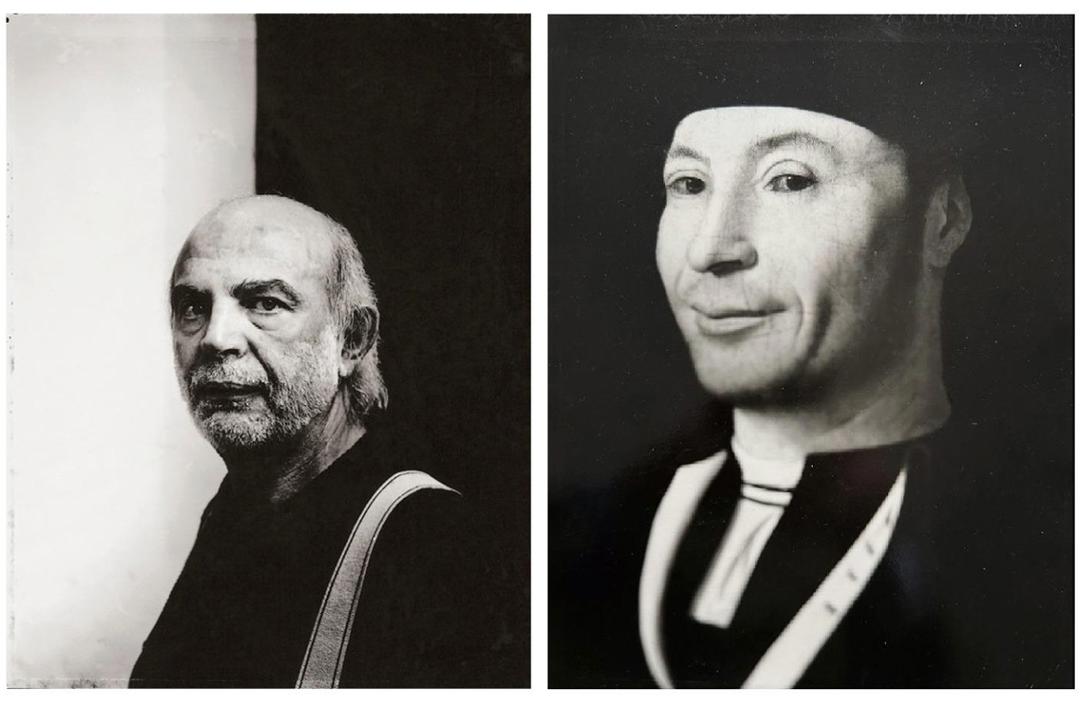Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Guglielmo Gigliotti
Leggi i suoi articoliL’America torna a omaggiare Alberto Burri con una grande retrospettiva al Solomon R. Guggenheim Museum, aperta dal 9 ottobre al 6 gennaio (alla mostra è dedicato il «Focus on Burri», allegato a questo numero). «The trauma of painting», questo il titolo della mostra, è l’evento principale delle celebrazioni del centenario dell’artista, nato il 12 marzo 1915 e morto il 13 febbraio 1995.
La curatrice Emily Braun ha selezionato oltre 100 opere di tutti i periodi dell’artista umbro, in stretta collaborazione con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri di Città di Castello, presieduta da Bruno Corà, che ha prestato quaranta opere. In mostra lavori dalla fine degli anni Quaranta agli ultimi anni di vita di Burri, a iniziare dai «Catrami», realizzati nel ’49, miscelando olio, catrame, sabbia, vinavil e pietra pomice.
Seguono i lavori denominati «Muffe» e «Gobbi» del ’50-’52, realizzati i primi, sfruttando le efflorescenze prodotte dalla pietra pomice combinata alla pittura a olio, e i secondi gonfiando la superficie dei quadri mediante rami incurvati posti dietro la tela. I «Sacchi» dei primi anni Cinquanta, con le loro logore tele di juta, strappate e rammendate, sono il ciclo burriano più noto in America, quindi nell’allestimento lungo tutte le sei rampe del museo progettato da Frank Lloyd Wright trovano ampia rappresentazione, ma la mostra intende dare nuove centralità anche a cicli meno noti fuori dall’Italia.
Così è per i «Ferri» e per i «Legni» della seconda metà degli anni Cinquanta, e così è per le sontuose «Plastiche» dei primi anni Sessanta, su cui Burri, come per i «Legni», interviene con l’azione forgiante del fuoco. L’idea di arte come processo in atto trova la sua forma ancora più limpida nei «Cretti» degli anni Settanta. Questi vengono realizzati mischiando creta, caolino e bianco di zinco e attendendo che il contatto con l’aria gonfi e crepi la superficie, fino al momento in cui uno strato di vinavil steso dall’artista blocchi lo sviluppo.
È il momento in cui il reticolo della crettatura raggiunge un suo grado di bellezza. In mostra è dato ampio spazio anche ai «Cellotex», realizzati a partire dalla fine degli anni ’70, perseguendo un’articolazione in grandi cicli tematici, da «Il viaggio» del 1979 a «Orti» del 1980, ad «Annottarsi» del 1985. Parte a sé fanno i monocromi degli anni Cinquanta che, sotto il titolo «I Bianchi», sono per la prima volta raccolti in un insieme unitario.
Dichiarata intenzione della curatrice è rivedere il ruolo di Burri nel rapporto con gli Usa. Dall’America ebbe molto, ma all’America anche molto diede. Iniziò a dipingere proprio come prigioniero di guerra nel Texas nel ’43-45, e a Chicago, New York e Los Angeles ha avuto, dal ’53, le prime mostre in gallerie fuori dall’Italia, per non parlare della retrospettiva ospitata nel ’78 dallo stesso Solomon R. Guggenheim Museum di New York. Burri, poi, sposò nel ’55 un’americana, Minsa Craig, e dal ’63 ha iniziato a trascorrere lunghi periodi a Los Angeles, alternandoli ai soggiorni nell’amata Città di Castello.
Ma Burri si innesta in quel passaggio dell’arte del ’900 chiamata New dada, capeggiata da quel Rauschenberg che realizzò i «Combine paintings» solo dopo aver fatto visita, nel ’53, allo studio di Burri a Roma. New York, in altri termini, intende con questa mostra riconoscere all’artista italiano il ruolo di ispiratore di tante ricerche fondate sulle materie ready made e sulla processualità, che caratterizzeranno la generazione degli artisti americani operativi a partire dagli anni Sessanta. In Italia, che Burri sia stato, come disse Kounellis, «un faro», era da tempo un dato storicamente acquisito.
A saperlo per lungo tempo furono però solo gli artisti, tanto che alla Biennale di Venezia del ’52 un suo «sacco», intitolato «Lo strappo», venne rifiutato dalla giuria. Ad essere accolto nella stessa Biennale, nella sezione del «bianco e nero», fu invece lo «Studio per lo strappo», che però venne acquistato da un artista, appunto, Lucio Fontana. Pochi mesi dopo Burri ebbe una visita in studio di James Johnson Sweeney, allora direttore proprio del Guggenheim di New York. E iniziò l’avventura americana.
Altri articoli dell'autore
Una mostra nel Palazzo Bellomo di Siracusa presenta le meditazioni fuori dal tempo del fotografo
Guidati da Oscar Tuazon, altri 12 artisti internazionali espongono sculture, dipinti, installazioni, video e fotografie ispirati all’acqua
Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma tre personalità di spicco della pittura novecentesca italiana in due allestimenti
L’ha spuntata su 44 candidati. Ha lavorato con il Centro Pecci di Prato, il MaXXI, La Quadriennale e la Fondazione Prada