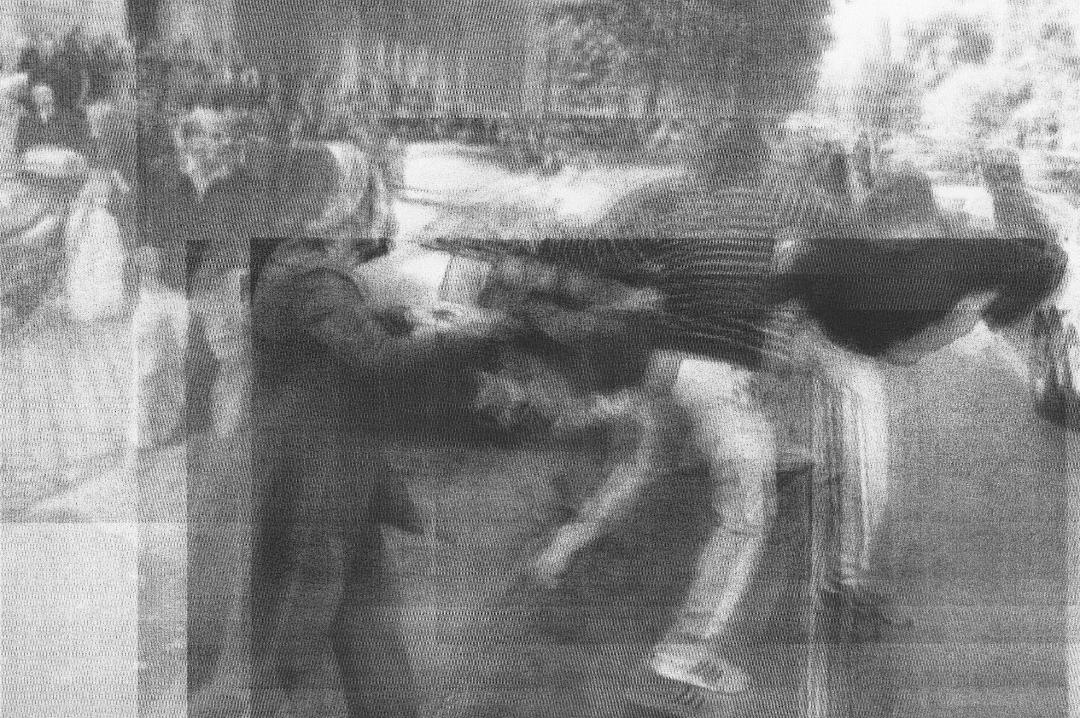Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Gilda Bruno
Leggi i suoi articoli«Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo», scriveva il filosofo spagnolo George Santayana, esponendo la capacità umana di tramutare istinto, passione e caos in un’esperienza di vita improntata alla razionalità e all’«ideale» nel suo The Life of Reason. È una massima che, alla luce di quanto sta succedendo nel mondo, evidenzia quanto lo scrittore avesse sottovalutato l’abilità dell’uomo di tradire sé stesso. Perché se neppure i conflitti documentati in diretta social riescono a impedirci di incorrere negli stessi errori del secolo scorso, cosa può farlo? È impossibile ripensare al 2024 senza evocare gli scatti ritraenti corpi in fin di vita e martoriati, o villaggi ridotti in macerie, condivisi da cittadini e giornalisti palestinesi e dalla comunità internazionale. Ma pensare che la crisi in Medio Oriente sia stato l’unico evento di cronaca del 2024 significa sottovalutare il quadro che vede la società in preda a molteplici emergenze epocali: il protrarsi della guerra Russia-Ucraina che, al suo terzo anno, secondo dati rilasciati da Kyiv, le Nazioni Unite e «Bbc Russia», al 13 febbraio 2025, avrebbe registrato un totale di 148.359 morti tra soldati di entrambi gli schieramenti e civili ucraini (sebbene si pensi che i numeri reali siano di gran lunga più alti), e che proprio questo 7 marzo, a fronte di nuovi attacchi da parte del Cremlino nella regione del Donetsk, ha visto una delle sue giornate più sanguinose di sempre. E come non citare il conflitto civile in Sudan, il palesarsi sempre più forte del cambiamento climatico, il riaffiorare di tensioni pregresse nell’ex-Urss, l’inversione di marcia sui diritti civili in vari governi del mondo, l’ascesa dell’era «antiwoke» del presidente Donald Trump.
Tra le immagini degli ultimi 12 mesi ce ne sono due difficili da dimenticare. La prima, realizzata dal fotoreporter Mohammed Salem nel corridoio di un ospedale e vincitrice del World Press Photo 2024, mostra una donna palestinese avvinghiata alla nipote rimasta vittima di un missile israeliano. Il viso della protagonista è nascosto nell’incavo del braccio, tra un velo ocra, un maxi abito in jeans e quell’ultimo abbraccio rubato. Quello della bambina, avvolto come il resto del suo corpo da un telo bianco. La seconda, scattata dallo spagnolo David Ramos, racconta il nubifragio abbattutosi su Valencia lo scorso ottobre. In primo piano, un passante e il suo cane camminano lungo un’immensa colata di fango tra detriti, cartelli stradali sradicati e automobili accartocciate su sé stesse in una testimonianza agghiacciante e inconfutabile dell’avanzata della crisi ambientale. A rendere la foto ancora più inquietante è l’attitudine disinvolta dell’uomo, il quale, vestito di tutto punto all’indomani dell’alluvione, si lascia alle spalle le conseguenze della tragedia. È una scena che fa pensare a quanto sia diventato naturale distaccarsi dalla sofferenza. Un contrasto che, come scrive Neelika Jayawardane su «Al Jazeera», ci ricorda di come solo a rappresentazioni «appetibili» di quest’ultima (vedi gli innumerevoli parallelismi tra la «World Press Photo of the Year» e le opere d’arte occidentali raffiguranti la Vergine Maria con il figlio Gesù) venga concessa una piattaforma mediatica.

David Ramos, «Una serie di macchine ammassate nella strada assieme ad altri detriti a seguito dell’alluvione che ha colpito Valencia il 30 ottobre 2024». Courtesy David Ramos e Getty Images
Nonostante i tentativi di sanitizzazione, a pervadere la narrazione delle vicende del 2024 è stato un misto di rabbia, dolore, sgomento, speranza, solidarietà e rassegnazione. In un sondaggio condotto su Instagram da un gruppo di giornalisti indipendenti riguardo le immagini che più hanno incarnato l’atmosfera degli ultimi 12 mesi c’è chi parla del coraggio dei manifestanti scesi in piazza a Tbilisi contro una legge che limita la libertà di parola di Ngo e media indipendenti qualora questi ricevano più del 20% dei propri fondi da enti internazionali, e la cui entrata in vigore impedisce alla Georgia di diventare parte dell’Unione Europea. Chi in una foto di un giovane steso sulla sabbia dopo aver varcato il confine dell’Egitto (tratta da «Home» del fotografo sudanese Ammar Abdallah), percepisce «lo sfinimento intrinseco alla lotta per il diritto a esistere, e il ciclo di violenza che la contraddistingue», come spiega l’artista visuale Jermaine Francis. Chi, come la giornalista culturale Ashleigh Kane e la video producer Isabel Bonnet, punta al Trump sanguinante immortalato dal fotografo Ap Evan Vucci a fronte del suo sventato attentato il 13 luglio scorso come a un monito del suo incombente secondo mandato. Chi «nelle lacrime della comunità di colore e delle donne presenti al “concession speech” di Kamala Harris» ha rivisto sé stessa e tutti i suoi amici, tra cui la scrittrice statunitense Hannah Bertolino. E chi nei selfie distopici dell’esercito israeliano, prova «dei crimini di guerra da esso commessi giornalmente», vede «l’assurdità di quest’epoca», racconta l’editorialista Alex Milan Durie.
Forse però, a racchiudere il ribaltamento dell’archetipo dell’eroe a cui stiamo assistendo, dove sono gli individui ad armarsi contro le falle di istituzioni che dovrebbero servire i cittadini, è la foto indicata dall’artista e designer californiano James Burial, che «ritrae le urla di Luigi Mangione», unico indagato dell’omicidio del ceo di United Healthcare Brian Thompson, alla sua prima comparsa in tribunale: un ragazzo neppure 27enne che, si dice, abbia commesso un gesto estremo per via delle conseguenze inguaribili di un incidente da lui subìto precedentemente, e che ora rischia l’ergastolo senza condizionale. E potrebbero indurre uno stato di passività generale anche la costante esposizione a scene di violenza e disastri tipici della nostra epoca, il nulla di fatto del mandato di arresto indetto dall’International Criminal Court nei confronti dei leader israeliani e le spiegazioni contro la condanna del saluto romano che due volte Elon Musk avrebbe fatto durante il suo insediamento alla Casa Bianca questo 20 gennaio (smentito dai suoi collaboratori come un gesto attraverso cui «Elon esprime i suoi sentimenti dicendo “voglio darti il mio cuore”»). Perché se è vero che, come spiega la sociologa di Harvard Caitlin Begg, «le fotografie di eventi politici possono spronarci a interagire con ciò che accade in tutto il mondo, molti vengono paralizzati da questo flusso incessante di immagini». Per evitare che rappresentare un mondo al collasso ne acceleri il declino, «dobbiamo spingerci oltre lo spettacolo visivo».
Altri articoli dell'autore
Realizzati con telescopio e smartphone, gli scatti nell’ultimo libro del fotografo palermitano restituiscono un ritratto poetico e straniante della capitale britannica, sospesa tra escapismo, solitudine e opportunità di redenzione
Al Foto Forum di Bolzano una riflessione collettiva sulle dinamiche di trasmissione e fruizione di materiali visivi disturbanti
Tratti da «Video Portrait Gallery» (1975-2002), opera seminale della performance artist serba, due filmati a lungo dimenticati riprendono vita in un’ipnotica sequenza di fermo immagini alla Saatchi Yates
Azu Nwagbogu: «La cosa più radicale che un festival d’arte può fare è mettere il pubblico a disagio»
La 15ma edizione di LagosPhoto, «Incarceration», ci mette di fronte a «prigioni fisiche e gabbie mentali, plasmate da vincoli invisibili mai messi in discussione». Parola al direttore