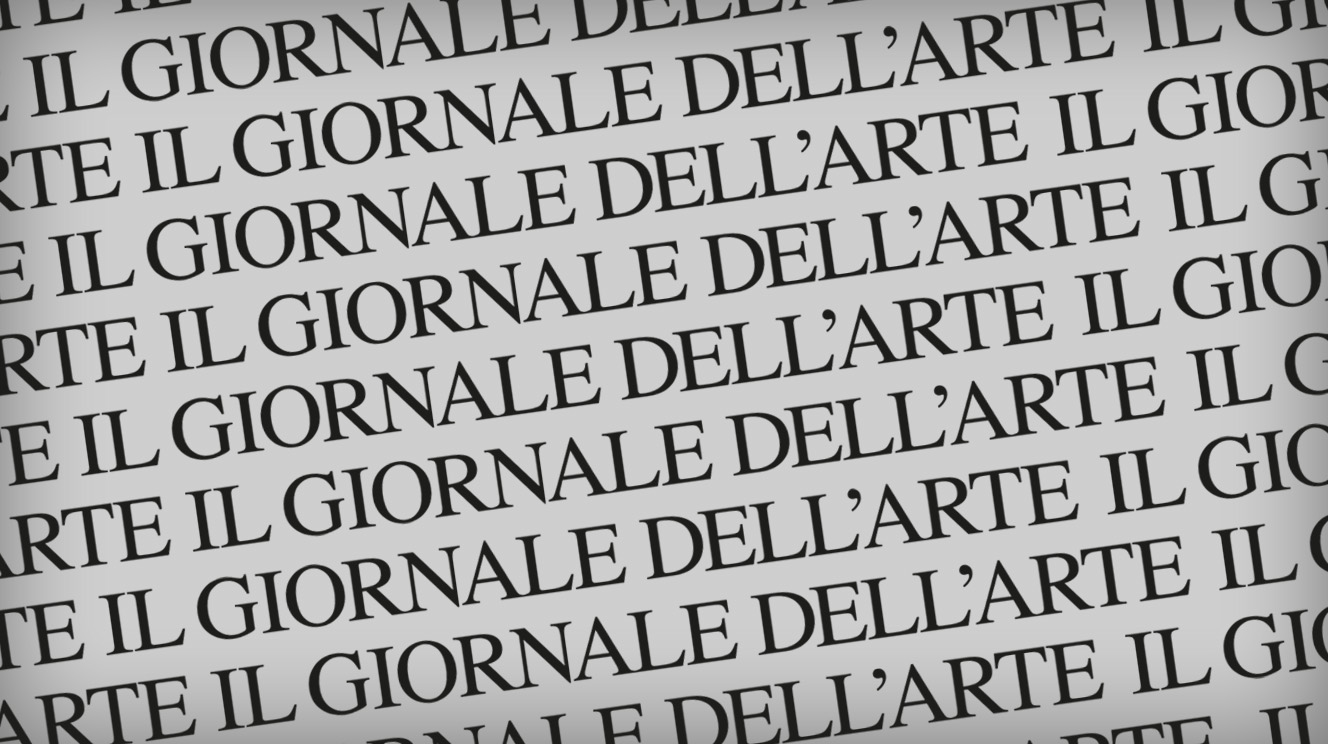Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Silvia Mazza
Leggi i suoi articoliUna collezione ancora tutta da studiare, da Van der Weyden a Tintoretto, da Andrea del Sarto a Guido Reni, che una dinastia siciliana ha raccolto nello splendido palazzo nobiliare a Partanna
Un Caravaggio, forse anche un Antonello da Messina, da duecento anni attendono l’occhio di un connoisseur che ne riconosca la mano. Nella sontuosa villa a Partanna, in provincia di Trapani, la baronessa Valeria, ultima erede di una famiglia patrizia d’origine veneta, arrivata in Sicilia al seguito di Carlo V d’Asburgo, è custode della collezione Santo Canale, con opere di Francesco Laurana, Rogier van der Weyden, Tommaso de Vigilia, Riccardo Quartararo, Raffaello e allievi, Andrea del Sarto, Tintoretto, oltre a sculture, disegni, maioliche e reperti archeologici.
Uno straordinario patrimonio d’arte, segregato per secoli e per scelta del nobile casato che lo ha collezionato, che si presenta in esclusiva a «Vernissage». Un patrimonio, anche, miracolosamente sopravvissuto al bombardamento che il 9 maggio del 1943 a Palermo devastò l’elegante palazzo di famiglia a Porta Felice (su disegno di Filippo Juvarra), messo in salvo appena in tempo nella dimora suburbana, perché «col solo atto di nascere, racconta l’ultimogenita della baronessa, Valentina, Valeria salvò la famiglia e tutti i beni artistici»: un ufficiale tedesco invitato al suo battesimo nel 1941 avvertì, infatti, che l’intera marina di Palermo era un obiettivo militare.
Sappiamo dei Gangi, dei Lanza Branciforte o degli Alliata, poco o nulla dei Santo Canale. Una famiglia segnata da un’attitudine carsica, sotterranea, e introversa, che li ha distinti anche nella Palermo dei fasti e che poi li ha portati a cercare riparo nel limbo solitario della propria villa. Tra i suoi membri annovera grandi imprenditori, ingegneri e giuristi, appassionati collezionisti d’arte, con i quali si colloca al centro delle vicende culturali e politiche che videro costruire l’Unità d’Italia, nascere le prime industrie della cantieristica navale, le prime ferrovie italiane e l’uso delle grandi macchine a vapore. Fra questi ci fu un Napoleone, ingegnere navale, che unendosi in matrimonio con Ortensia Beauxu Sella, nipote del ministro Quintino, collegò gli interessi siciliani della famiglia a quelli dell’imprenditoria piemontese. Il grande collezionista è Giuseppe (detto Pepè), eclettico, forse più per temperamento che per gusto.
Anche se il nucleo consistente della pinacoteca è dovuto all’importante lascito, a metà Ottocento, della baronessa Marianna Consiglio di Sciacca. Da Villa Santo Canale, eretta intorno al 1500, sono passate personalità come Vittorio Emanuele II, Vincenzo Bellini o Gioacchino Rossini. Sorge ai limiti della Piana dei Colli, zona eletta nel ’700 da numerose dimore aristocratiche, oggi prostrate a una decadenza che ne ha sopraffatto lo splendore originario, da cui si distingue perché integra e ben conservata, circondata dal vasto parco con viali prospettici, polmone che le dà ossigeno soffocata com’è dal cemento di una sregolata crescita edilizia suburbana del capoluogo. Da quelle si differenzia anche per alcune peculiarità architettoniche, come lo scenografico scalone monumentale a tenaglia interno, invece che in facciata.
Pure il prospetto, classicamente ritmato e disegnato (tanto appena accennato ne è l’aggetto) da un doppio ordine di lesene, è insolitamente inquadrato da due corpi più elevati, di cui uno è una torre di epoca anteriore inglobata nel nuovo edificio. Lo scalone, dove spicca la piccola veduta settecentesca del «Palazzo alla Marina» e la grande pala del «San Benedetto incontra Totila» del caravaggesco Pietro d’Asaro, conduce al piano nobile, all’infilata delle due sale della Biblioteca, il cui fondo antico è costituito da circa 1.900 volumi, fra i quali 5 incunaboli e 169 cinquecentine, edizioni di Aldo Manuzio del XVI secolo e la prima edizione dell’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert. Nel salone c’è un «Madonna col Bambino» firmata dal Tintoretto, un Francesco Laurana e anche quel «Battesimo di Cristo» esposto nel 1951 nella grande mostra su Antonello da Messina e la pittura del ’400 in Sicilia, che potrebbe essere di mano dello stesso Antonello; così per lo splendido «San Sebastiano» si fa fatica a sospendere il nome del Caravaggio.
E ancora, si ammirano opere di Claude Lorrain, Van Dyck, Pietro e Rosalia Novelli, Guido Reni e Jusepe de Ribera. Fino a non molti anni fa c’era pure una «Morte della Vergine» di Petrus Christus, venduta alla Timken Art Gallery di San Diego. In una vetrina spicca un pezzo d’eccezione: una brocchetta a filtro con coperchio e iscrizione in arabo sul collo, che agli occhi di un attento conoscitore quale fu l’islamista Umberto Scerrato è parsa senza dubbio di età federiciana. Quindi, nella Sala da pranzo grande, ci sono, tra l’altro, quattro scene di caccia e due nature morte del napoletano Baldassarre De Caro; mentre due vetrine custodiscono maioliche di Cherinto Del Vecchio, di manifattura settecentesca Malvica (palermitana) e orientale. Nella Sala da pranzo piccola sono da menzionare almeno le due nature morte con strumenti musicali di Evaristo Baschenis.
Tra gli ambienti di servizio, infine, un singolare vano con scala «spezzata» (per agevolare la salita) e cieca (non conduce a niente) accoglie una collezione di lumi d’epoca. A testimoniare il gusto eclettico anche pezzi del presepe di Giovanni Antonio Matera o reperti archeologici dall’età neolitica a quella ellenistica. In queste stanze in cui la vita accade quotidianamente, per cui le lettere di Rossini in una teca dell’alcova possono trovarsi accanto a una pomata callifuga, perché «in casa Santo Canale l’antico, il moderno e l’utilizzo quotidiano convivono senza gerarchie», come osserva la baronessa, e su questi oggetti il tempo è passato in modo capovolto, invece di depositare polvere e opacità, a diffondere luce ed emozioni. Tutto è ancora da scrivere.
Poche le paternità certe delle opere d’arte, con tre inventari storici che si contraddicono e ai quali si aggiunge pure quello redatto dalla Soprintendenza, quando appena qualche anno fa ha sottoposto a vincolo la collezione. Non solo custode di questo straordinario patrimonio, ma lei stessa collezionista, Valeria Santo Canale è una personalità singolare. Di lei la figlia dice: «È capace di zappare con gli operai in campagna e la sera partire, ospite dell’Aga Khan in Costa Smeralda». Nel luglio del 1991 mise mano alla ristrutturazione della Villa, a cominciare dai tetti. Ma in quel luglio Palermo non fu la città dei paesaggi cotti dal sole di Lojacono: piovve come non se ne aveva memoria. Quattro volte di gesso affrescate per una quadratura totale di 384 mq cedettero, sotto il peso dell’acqua, sugli originali pavimenti in ceramica policroma. Si salvò unicamente quella dell’alcova. «Soltanto in quella notte, ricorda la baronessa, il preventivo lievitò di un miliardo di lire». Ma le opere non si toccano. Un giorno di quegli anni un noto storico dell’arte le snocciolò il valore dei quadri, lei sorrise e rispose: «Professore, io so solo che queste opere valgono tutto il lavoro che faccio, da sola, per tenerle in vita».
Altri articoli dell'autore
La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera
Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni
Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma
Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.