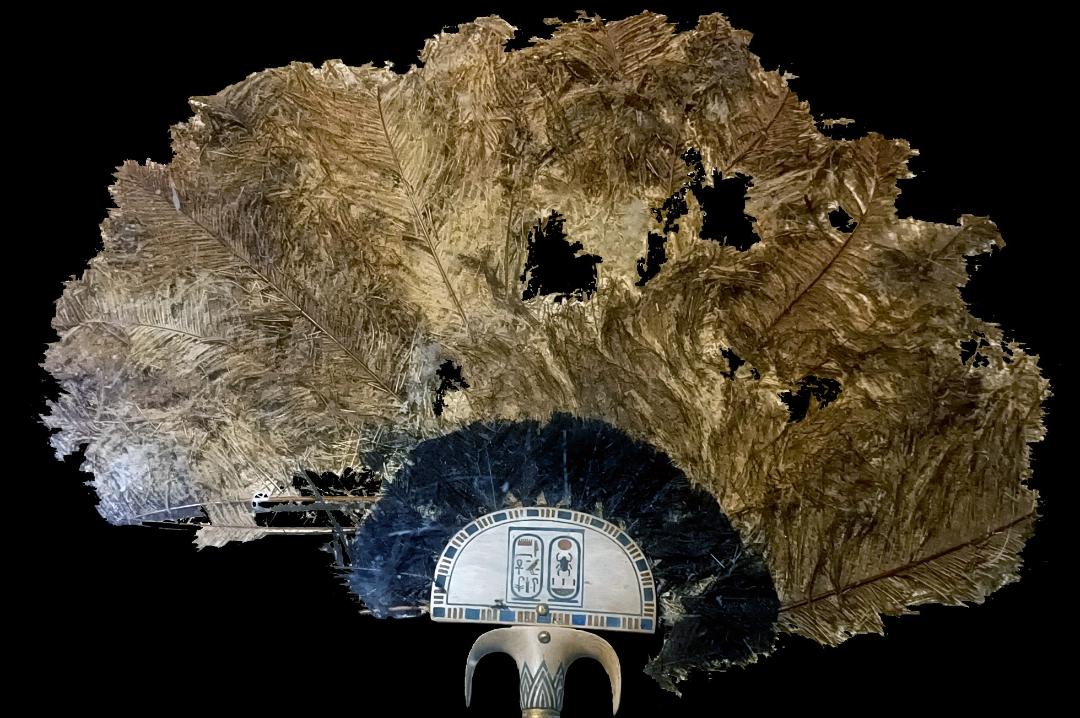Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Giuliani
Leggi i suoi articoliUn viaggio di seimila anni a ritroso nel tempo scandito da sei metri di stratigrafia di scavo, un museo archeologico contemporaneo dove la cultura materiale al suo interno viene raccontata attraverso pannelli digitali e installazioni tridimensionali e la ricerca scientifica viene condivisa con la comunità locale.
Tutto questo, e molto altro, si trova racchiuso nel Megamuseo di Aosta, l’estesa area megalitica di Saint-Martin de-Corléans, ai margini del capoluogo valdostano, scrigno straordinario di imponenti megaliti che trovano confronti nel sito svizzero di Sion. Inaugurata nell’estate 2016, poi chiusa al pubblico e riaperta alle visite a fine 2023 con un nuovo allestimento, l’area museale è al centro di una rivoluzionaria valorizzazione all’interno del tessuto urbano e nel più ampio sistema della Valle.

Una veduta dell’allestimento del Megamuseo di Aosta. Foto: Enrico Romanzi
I numeri che caratterizzano il Megamuseo di Aosta sono altrettanto grandiosi: 18mila metri quadrati di spazi espositivi, 5mila metri quadrati di area archeologica e oltre 2mila reperti, suddivisi su tre piani, che si dipanano lungo un ampissimo arco cronologico. Il luogo di per sé è straordinario perché insiste in ambito urbano, ma nell’antichità si trovava in prossimità di corsi d’acqua in una posizione geograficamente strategica. Vi si praticavano riti e cerimonie e le sue origini affondano nel Neolitico, alla fine del V millennio a.C. La frequentazione del sito poi prosegue nell’Età del Rame (IV-III millennio a.C.), continua seppur con qualche interruzione nell’Età del Bronzo (II millennio a.C.) e in quella del Ferro (XI-I secolo a.C.), fino all’età romana e al Medioevo con la piccola chiesa di Saint-Martin de-Corléans che soppianta il luogo di culto funerario e pagano. Un giacimento stratificato che racconta i riti dei vivi nelle epoche più antiche quando era utilizzato come area cultuale a cielo aperto, e le sepolture dei morti con le tombe costruite nell’Età del Bronzo lungo gli allineamenti dei pali e delle stele che in origine avevano funzione rituale. Scoperto per caso nel 1969 in occasione di lavori per la realizzazione di unità abitative, il sito è protetto da un moderno edificio appositamente costruito a partire dal 2005. All’epoca, a intuirne subito la formidabile importanza fu il veronese Franco Mezzena insieme con l’archeologa Rosanna Mollo.
Oggi le ricerche proseguono grazie a un gruppo diversificato di specialisti e dal novembre 2024 all’archeologo Generoso Urciuoli è stata affidata la gestione del museo e di tutte le attività culturali e scientifiche. Nell’area archeologica si studia la cronologia delle orme dei bovini la cui retrodatazione di circa mille anni, se fosse confermata, permetterebbe di retrodatare anche l’uso dell’aratro: i solchi dell’aratura rituale del Neolitico sembrano oggi opere d’arte contemporanea. Le grandi fosse circolari al momento della scoperta contenevano ancora semi di cereali e grandi macine per la molitura forse a invocare copiosi raccolti, mentre la sequenza delle buche di pali lignei è ciò che resta dell’allineamento di stele antropomorfe e menhir pertinenti a un santuario preistorico. Simulacri destinati alla venerazione? Non è dato saperlo con certezza. L’interpretazione è ancora dibattuta e molti dubbi restano da risolvere. Menhir, lastre e stele, insieme a tutti gli altri reperti ossei e ceramici, hanno trovato posto nelle sale del museo che di recente ha ampliato la sua curva temporale e la superficie espositiva anche con la sezione romana e altomedievale e i tantissimi materiali provenienti dalle necropoli e dalla fattoria che sorse in quella zona.
Tra le svariate iniziative di primavera al Megamuseo, il 12 aprile prende il via (fino al 26 luglio) «Arature Sonore», la rassegna a cura di Fabrizio Vespa che trae ispirazione proprio dai solchi millenari di seimila anni fa in un singolare connubio tra archeologia e musica grazie alle performance di artisti e musicisti. A maggio, invece, è previsto un laboratorio di scrittura creativa in quattro incontri, mentre a giugno, in occasione delle Giornate europee dell’archeologia (14-16 giugno), porte aperte al cantiere di scavo dell’Età del Ferro (VIII-VI secolo a.C.) insieme agli archeologi e al preparatissimo staff del Megamuseo. Quest’ultimo è sempre disponibile a brevi introduzioni alla visita (ogni 30 minuti) e a due appuntamenti al giorno («A spasso nel tempo»), dal martedì alla domenica.

Una veduta dell’allestimento del Megamuseo di Aosta. Foto: Enrico Romanzi
Altri articoli dell'autore
Grazie alla raccolta fondi lanciata mesi fa, è stata riallestita la sala con il ricco corredo della sepoltura scoperta da Ernesto Schiaparelli a Deir el-Medina nel 1906
Il 12 e il 13 dicembre appuntamento al Palazzo del Popolo per l’incontro Internazionale di Studi sulla Storia e l’Archeologia dell’Etruria
Dal 30 ottobre al 2 novembre appuntamento all’ex Tabacchificio Cafasso per la manifestazione dedicata al turismo archeologico giunta alla 27ma edizione
Come per un abito di alta sartoria, la realizzazione di una teca richiede conoscenza, precisione e molta cura per i dettagli. Patrizia Venturini della Goppion ci racconta com’è nato il progetto di collaborazione con il Grand Egyptian Museum per il quale l’azienda lombarda ha prodotto oltre 150 vetrine «intelligenti» e su misura, con vetri invisibili a elevatissima tenuta