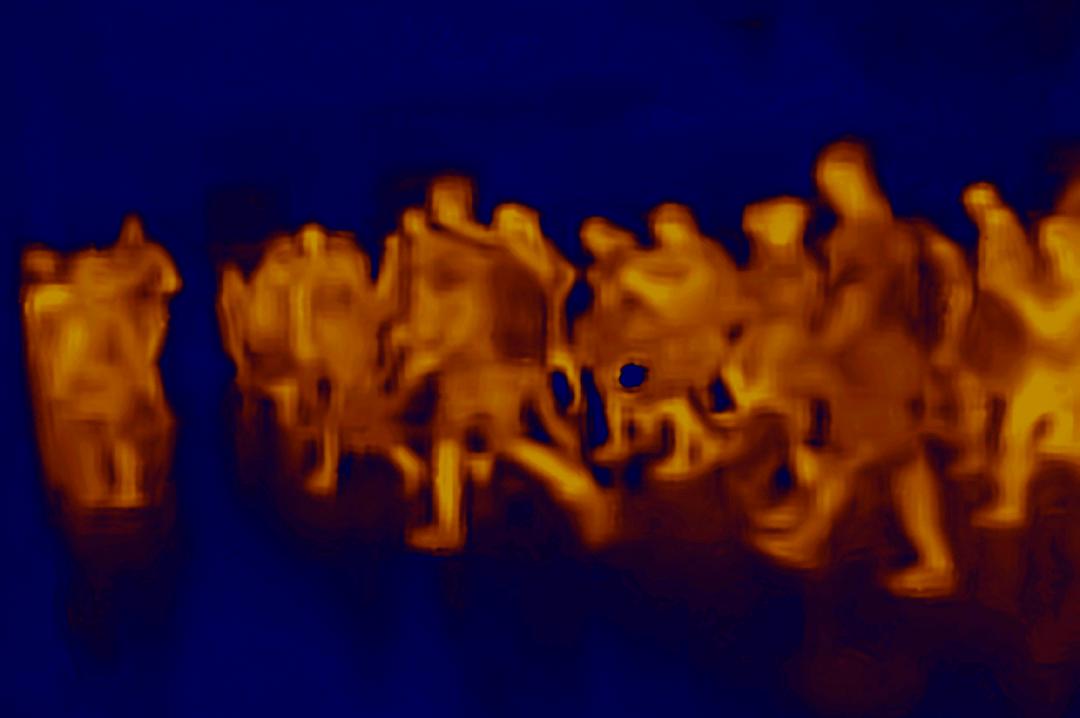Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Giulia Grimaldi
Leggi i suoi articoliSi entra da un corridoio stretto, all’inizio sembra buio e occorrono alcuni secondi per abituare gli occhi alla penombra. È una stanza quadrata dai muri neri, al cui centro c’è un cubo di metallo scuro. Dentro, riposte con estremo ordine, scatole di legno contenenti provini, hard disk, schedari, pubblicazioni, oggetti, libri che lo hanno formato e (a breve) le siringhe che testimoniano il suo passato come consumatore di droghe.
«Questa è la cassaforte che avevo ad Arles, l’ho tolta dal muro e portata qui, nessuno sa cosa ci sia dentro. Fotograferò il contenuto e lo inserirò nel libro che uscirà tra sei mesi», dice Antoine d’Agata. Poi, indicando la struttura che sta nascendo sugli scaffali che rigano le pareti. «Sto costruendo l'architettura del libro in modo fisico e ho due mesi per finalizzarlo. Devo modificare, stampare e incollare 256 carnet, ma è un processo lento». «Non pensavo ti fossi preso cura di tutte queste cose», dice l’amico fotografo Morten Andersen. Del resto, Antoine d’Agata è conosciuto per la sua vita nomade, per la scelta di non avere una casa, di abitare agli estremi della società. «Vent’anni prima di diventare fotografo ho deciso di vivere il mondo come attore, in rapporto alla mia stessa esistenza e alla comunità degli uomini. Non volevo un ruolo, una funzione specifica, ma solo esistere e sentire nel modo più intenso possibile, “to choose my side” e stare dalla parte di chi non ha mezzi, invisibile e sottomesso alla violenza politica, economica e sociale. Ho vissuto senza volere nulla in cambio: non scrivevo, non facevo fotografie. Non lo facevo per il gusto di farlo, ma perché era un mondo che mi faceva paura, un’oscurità che mi spaventava e mi attirava. Quando ho iniziato a fotografare ho continuato in questa prospettiva. Si tratta dello stesso processo, ma realizzato con un apparecchio fotografico che in alcuni casi mi permette di vivere ancora più da vicino la realtà e, certe volte, di condividerla. Condividerla per me significa contaminare attraverso la stampa, i libri, le immagini».
Ecco perché fa un certo effetto essere qui, in questo angolo appartato al quarto piano del Centre Pompidou di Parigi. Una residenza di 100 giorni che ha parecchi obiettivi, tra cui per D’Agata mettere mano ai suoi lavori, separando gli oggetti di una vita, fotografandoli, archiviando cartelle e selezionando le immagini per un nuovo libro che riesca a raccontare il suo percorso. Ma, soprattutto, il desiderio di fare il punto sul valore della fotografia, di non dare mai nulla per scontato.
«È impressionante, mi sembra di entrare dentro la tua testa», sussurra Luc Delahaye, uno dei tredici invitati a partecipare a una serie di incontri con scrittori e filosofi a cui Antoine D’Agata pone domande essenziali per la sua ricerca: il pubblico può assistere, ma si troverà a origliare a una conversazione intensa e privata, in un atto voyeuristico che fa parte del progetto stesso, con una videocamera costantemente puntata sul computer dell’artista dal quale si può seguire il suo lavoro.
C’è il bisogno fisico di raccogliere il lavoro di trent’anni di fotografia, il desiderio di mettere un punto. «Voglio vedere se riesco davvero a ricominciare daccapo. Ora ogni volta sento che c’è qualcosa che deve essere finito e ogni volta ho meno energia: voglio ricominciare ma in modo totalmente libero, questa è la grande sfida.» Sfida che in questi cento giorni D’Agata affronterà con rigore, come annuncia il titolo del progetto, «Méthode».
«C’è una logica unica e forte che attraversa tutto questo. I 256 carnet che sto posizionando sul muro sono capitoli e storie attraversati da questa logica della violenza: quella del giorno e quella della notte. La prima è una violenza economica e politica che cerco di raccontare dall’esterno, sforzandomi di essere il più freddo e obiettivo possibile. Quella della notte è la vendetta o la resistenza a quella del giorno, e la fotografo in modo partigiano, in modo fisiologico, perché è all’interno di essa che io esisto e prendo posizione. Tutto quello che ho fatto in questi trent’anni risponde a questa logica. È anche per questo che la mostra si chiama “Méthode”, perché voglio sottolineare questa trasparenza ideologica e metodologica del lavoro, nonostante ci siano a volte momenti estremi e intensi, che implicano sesso e droga, ma non si tratta di ossessioni incoscienti o di un’attrazione per l’estremo: risponde tutto a una logica politica profonda».

«Istituto abbandonato, Kyrylivs′kyj Haj, Kiev» (2021) di Antoine d’Agata. © Antoine d’Agata, Magnum Photos
La residenza al Centre Pompidou durerà fino al primo gennaio 2025, ma per avvicinarsi al lavoro di D’Agata si può iniziare dal libro appena uscito per Einaudi, Un luogo scomodo. Partito per l’Ucraina, nel 2021, con lo scrittore Jonathan Littell per raccontare Babyn Yar, un luogo alla periferia di Kiev in cui avvenne il massacro nazista del 1941, e travolti il 24 febbraio 2022 dall’invasione russa, la coppia di artisti si trova a raccontare un luogo di vecchie cicatrici e nuovi orrori, in cui la morte penetra la terra, annullando la distanza tra passato e presente in un costante tempo del dolore.
Dal punto di vista fotografico, si tratta, fin da subito, di una sfida chiara: fotografare un luogo in cui non è rimasto nulla a testimoniare il massacro; ritrovarsi in una guerra in cui viene negato l’accesso al fronte. Eppure l’apparato fotografico del libro utilizza numerose tecniche che riescono infine a catturare sia il dolore rimasto bloccato nelle profondità di Babyn Yar che il presente alienante della guerra in corso. «Si tratta a volte di scegliere una strategia narrativa, a volte una tecnica; del resto non sono uno storico, e quel che mi interessa è capire il presente per definire che tipo di azione posso avere con la comunità in cui mi trovo». Mentre le parole di Jonathan Littell si soffermano sulle storie personali di vittime del passato e del presente, l’obiettivo di D’Agata fotografa con precisione, rendendo attraverso la serialità la precisione macabra della guerra.
«Per me la serialità non è una forma assoluta desiderabile, ma un modo di indicare l’ampiezza dell’orrore e cercare di dare il senso sul lungo termine. Nel caso, ad esempio, dei letti dei pazienti che dormono all’ospedale psichiatrico, avrei potuto prendere l’immagine migliore, ma quel che mi interessava non era l’atto del dormire ma che tutte quelle persone fossero lì, che in ogni stanza ci fosse un letto e che loro dormissero esattamente al cuore di Babyn Yar, sotto delle coperte che ne annullavano un po’ l'umanità, rendendo delle forme astratte che nell’oscurità e nel silenzio diventavano qualcosa di pensante, di estraneo. 60 persone che dormono in questo modo mi danno un senso che vale molto di più di una foto sola. Preferisco perdermi nella ricerca di senso che affermare qualcosa che non risponde a niente. Trasmettere una ricerca, una domanda: è questo l’importante. È creare lo spazio per il dubbio e per porsi delle domande che rende rilevante la fotografia. Se si soddisfa solo il criterio dell’armonia e della composizione diventa inutile».
Concentrandosi sulla portata e sulla meticolosità del male, anche le immagini più crude non si compiacciono dell’orrore, ma cercano di portare alla luce quel filo spinato di violenza che lega il passato con il presente, con quel «Méthode» che contraddistingue tutta la sua vita e il suo lavoro.

La copertina del volume