
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Arte
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
Vernissage
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Economia
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale delle Mostre
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
RA Fotografia
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
Vedere a Milano
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Arte
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
Vernissage
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Economia
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale delle Mostre
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
RA Fotografia
IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola
In allegato:
Vedere a Milano
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Al Mudec si ripercorre la storia del XVI-XIX secolo per tentare d’individuare le modalità, stereotipate, con cui le figure «altre» erano rappresentate e proponendosi di restituire loro un’identità
- Ada Masoero
- 12 maggio 2022
- 00’minuti di lettura
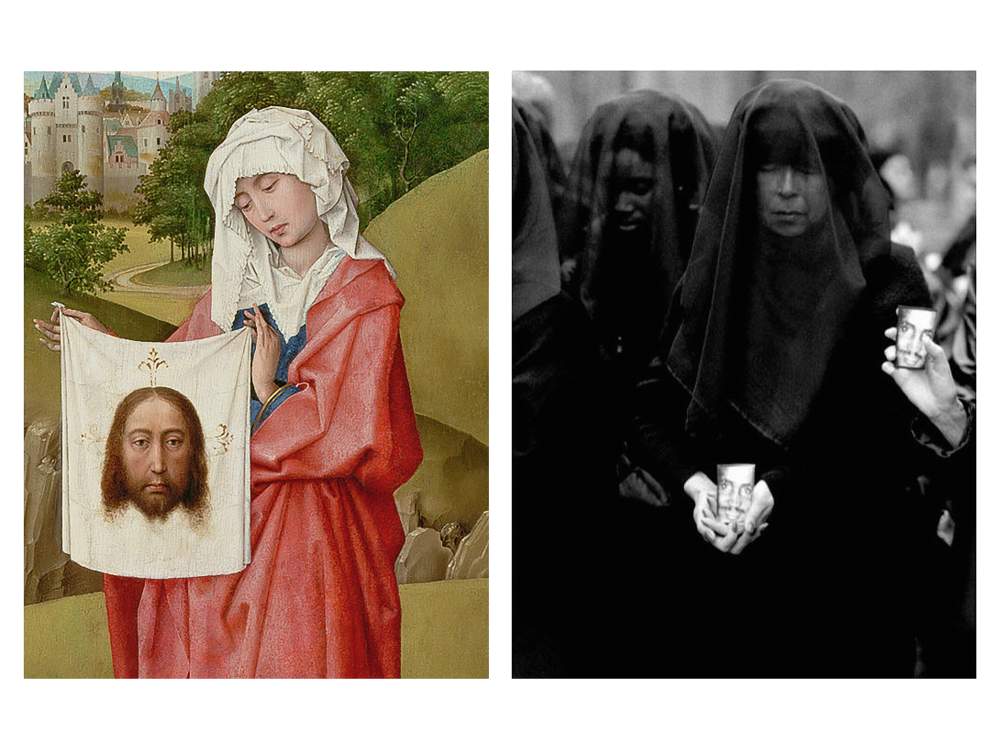
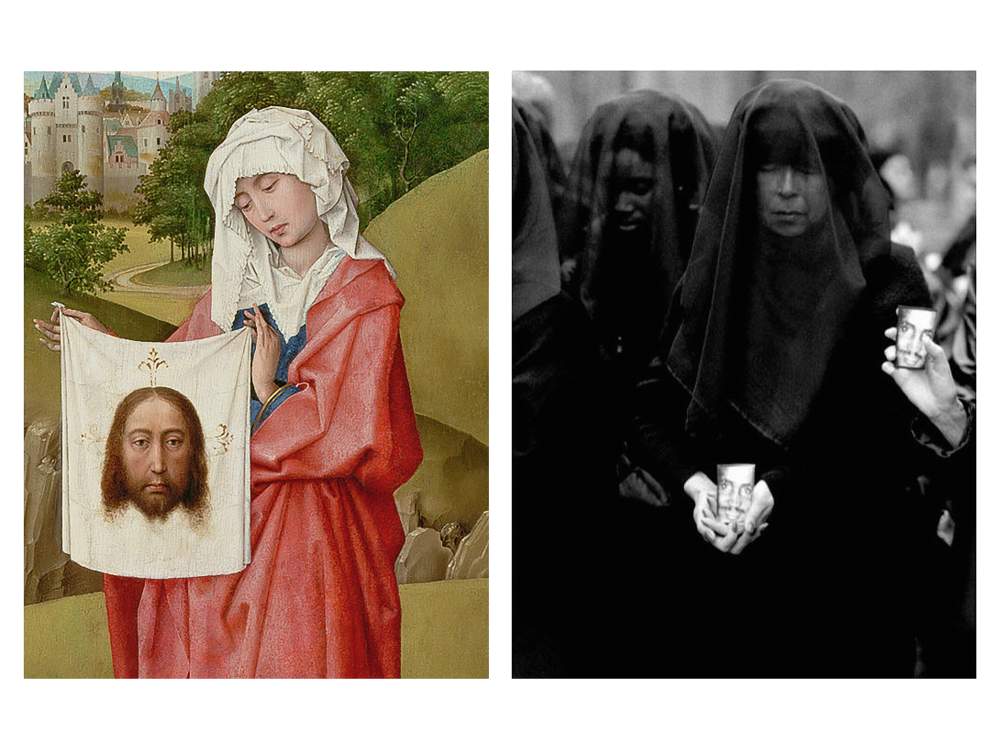
«Trittico della Crocifissione» (1440 ca) di Rogier van der Weyden e «Diallo Protest/Women in Mourning» (2000) di Paul Fusco
Ombre africane nell’Italia settentrionale
Al Mudec si ripercorre la storia del XVI-XIX secolo per tentare d’individuare le modalità, stereotipate, con cui le figure «altre» erano rappresentate e proponendosi di restituire loro un’identità
- Ada Masoero
- 12 maggio 2022
- 00’minuti di lettura
Un titolo felice, «La Voce delle Ombre», per un tema raramente affrontato: quello delle «Presenze africane nell’arte dell’Italia settentrionale (XVI-XIX secolo)». La mostra (catalogo Silvana) presentata dal 13 maggio al 18 settembre dal Mudec-Museo delle Culture affronta con la consapevolezza di oggi i modi della rappresentazione artistica di chi, in quei secoli, giungeva in Europa dall’Africa, tentando d’individuare le modalità, stereotipate, con cui queste figure «altre» erano rappresentate e proponendosi di restituire loro un’identità.
Curata dai conservatori del museo Luca Tosi, Carolina Orsini e Sara Rizzo, la rassegna (frutto delle ricerche per il riallestimento del museo), come spiega Marina Pugliese, neodirettrice del Mudec, si propone di «capire chi fossero le/i ritrattate/i e quali fossero gli stilemi e gli stereotipi ricorrenti nella loro rappresentazione».
Chi erano, dunque, queste «ombre»? Servitori, perlopiù, inseriti (in ombra, appunto) nei ritratti di personalità, come accade nelle opere della prima sezione, il cui modello è il «Ritratto di Laura Dianti con servitore» di Tiziano, qui evocato dall’incisione di Aegidius Sadeler II. La sezione «Leggenda e tradizione» mostra invece figure come Baldassarre, il re mag(i)o arabo, mentre la sezione «In carne o ossa» presenta personaggi come il principe marocchino Muley Xeque (1566-1621) che, convertitosi a Madrid, diventò Don Filippo d’Austria, Infante d’Africa e Principe del Marocco. Nella sezione «Echi e accordi», infine, il curatore Theophilus Imani, italiano di origine ghanese, accosta dettagli di antichi dipinti europei a opere fotografiche di autori neri, risignificando, alla loro luce, le immagini del passato.
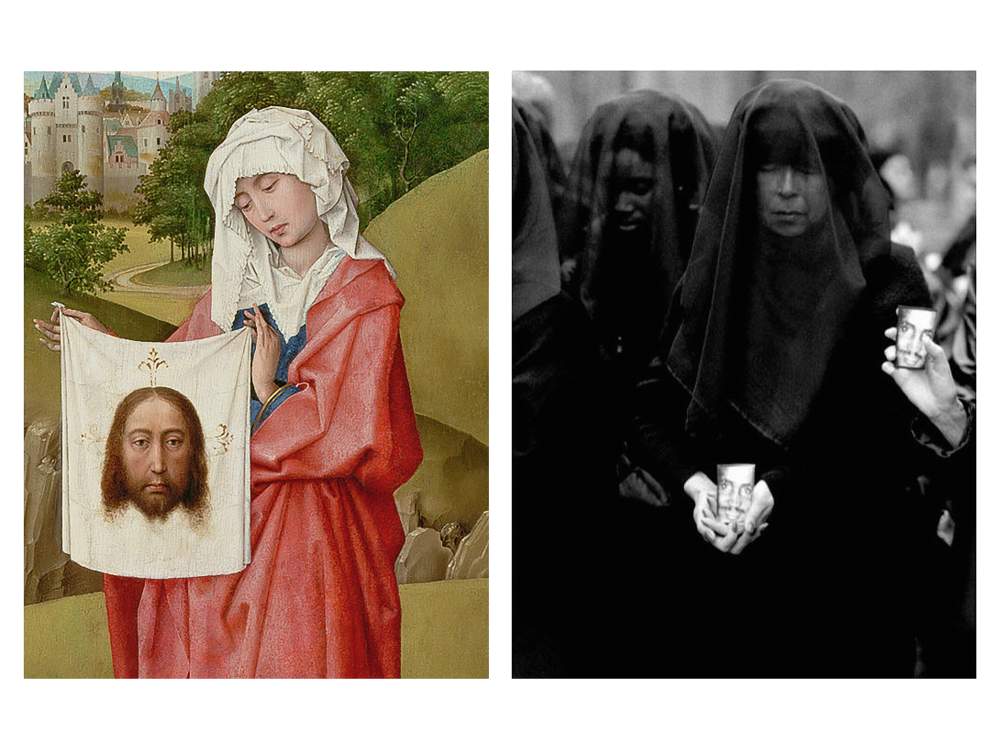
«Trittico della Crocifissione» (1440 ca) di Rogier van der Weyden e «Diallo Protest/Women in Mourning» (2000) di Paul Fusco









