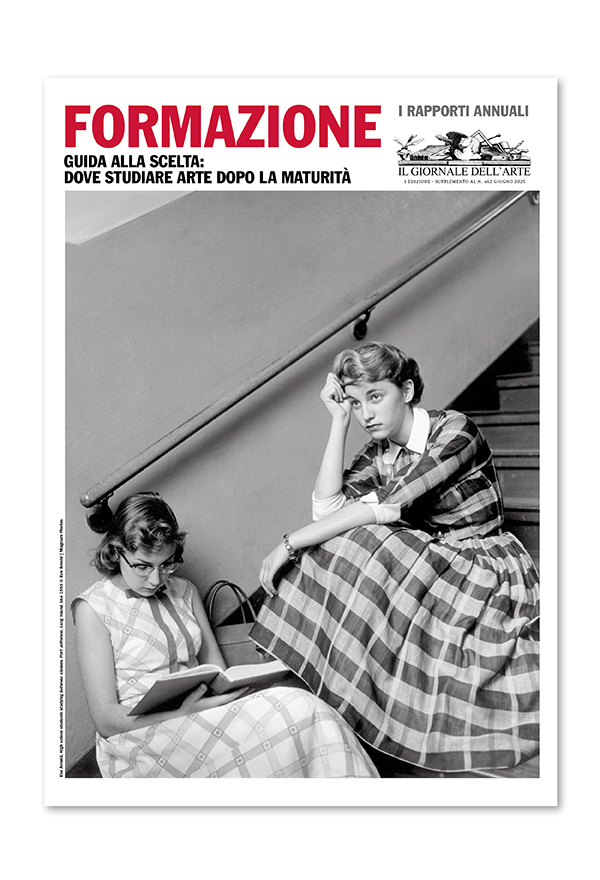Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Alessandro Martini
Leggi i suoi articoli«Dal 1998 ai primi mesi del 2024 il Ministero dei Beni culturali ha conosciuto 15 riforme. Mediamente una ogni anno e sei mesi. Una strabiliante e instancabile vocazione innovativa o un terribile stress?». E ancora: «Nel 2021 la pianta organica del Ministero della Cultura prevede 19.073 dipendenti [...] ma le persone che effettivamente lavorano in quei ranghi sono 10.753. Insomma, mancano 8.320 fra architetti, archeologi, storici dell’arte, bibliotecari, archivisti, restauratori, demoetnoantropologi e poi funzionari amministrativi, addetti alla vigilanza, alla custodia e all’accoglienza». Sono alcune delle considerazioni contenute nel volume di Francesco Erbani Lo stato dell’arte. Reportage tra vizi, virtù e gestione politica dei beni culturali, da poco edito da Manni. Erbani (Napoli, 1957), per 26 anni giornalista di «La Repubblica», è un esperto di politiche culturali, nonché memoria storica di decenni, di servizi e disservizi del Ministero fondato nel 1974 da Giovanni Spadolini. Con lui riflettiamo di temi ampi, ma anche di attualità. Coscienti di un dato spesso rimosso: «La partecipazione culturale degli italiani è bassissima. Solo il 27% dei nostri concittadini dichiara di andare in un museo una volta all’anno», come ha ricordato Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino.
Quanto ha contribuito alla nascita di questo libro il panorama per molti versi desolante della cultura italiana?
Da cronista ho frequentato per molti anni questo mondo, che è uno dei settori nevralgici dell’Italia. I beni culturali hanno la straordinaria potenzialità di fornire a un Paese la rappresentazione di sé e di alimentare conoscenza, coscienza, senso civico. Mi pareva quindi utile fare il punto sul momento attuale, raccogliendo, appunto, lo stato dell’arte. Cosciente che, lo ripeto, questo settore è fondamentale, ma è profondamente trascurato, al limite della mortificazione. Al di là di tutte le retoriche che gravano sul tema... Tuttora, se vogliamo arrivare alle vicende recenti, il patrimonio culturale è ridotto al suo portato «identitario», nazionale, quando invece il suo valore universale è l’essere aperto, a disposizione di tutti.
Qual è la situazione della cultura oggi in Italia, e del Ministero che se ne occupa?
È una condizione di grandissima sofferenza, sotto molti aspetti. A parole, ma solo a parole, la politica investe molto sulla cultura. Franceschini indicava il Ministero dei Beni culturali, oggi della Cultura, come il principale Ministero economico del Paese. Ma quanto c’è di retorico in questo assunto, e quanto invece di concretamente praticato? Quanti sono gli esiti visibili di questa dichiarazione? Sangiuliano ha attribuito invece un ruolo diverso al patrimonio culturale e al Ministero: quello di ricostruire una sorta di identità nazionale. Un ruolo che non è il suo, credo. Ciò che emerge, mi pare, è la fondamentale indifferenza della politica per la cultura, una generale trascuratezza.
Non sempre alla Cultura sono andati i migliori ministri possibili.
Certo, a lungo il Ministero è stato davvero di serie B, se non di serie C, e i suoi responsabili si ricordano a fatica. Spesso sono state figure sbiadite sia per competenze sia per statura politica. Con poche ma significative eccezioni, come Rutelli, Veltroni e Franceschini, che hanno associato alla guida della Cultura la propria forza e ruolo politico. Franceschini aveva personalmente chiesto quel Ministero... Ma non credo che sia indispensabile la competenza specifica, quanto piuttosto un profilo politico incisivo. Solo così anche il Ministero conta davvero, e di conseguenza le politiche culturali ottengono maggiore attenzione.
C’è il rischio che di cultura si parli soprattutto per inaugurazioni di mostre e musei, di record di affluenza, di grandi eventi?
È in effetti una tendenza recente, quella di utilizzare il patrimonio come «instrumentum regni», avrebbero detto i Latini. Dagli anni ’80 sul patrimonio iniziano a innestarsi una serie di retoriche. Per la prima volta, con le lunghe file davanti al Quirinale per ammirare i Bronzi di Riace, il patrimonio è stato considerato e raccontato come qualcos’altro, fortemente attrattivo. Si è iniziato a parlare di giacimenti culturali, di petrolio, di redditività economica. E così il patrimonio è stato snaturato alla radice. C’è stato una sorta di illusionismo ottico che ci siamo portati dietro fino ad oggi, con grandi mostre che si fanno soprattutto per avere finanziamenti e sponsorizzazioni private, e staccare biglietti. È l’ossessione dei numeri. Lo vediamo dalla lettera di dimissioni del ministro Sangiuliano: uno dei suoi vanti è proprio la crescita dei visitatori nei musei. Dato totalmente infondato, perché il recente incremento ha più o meno raggiunto i livelli precedenti alla pandemia. Ma questa ossessione per i numeri, che non è solo di Sangiuliano, oscura altre questioni fondamentali: perché si cerca cultura, e perché non la si cerca? Chi va nei musei, e perché? Ricordiamo che secondo l’Istat 7 italiani su 10 non ci entrano mai.
La Riforma Franceschini del 2014 aveva contribuito a migliorare la situazione?
Tra le 15 pseudoriforme in 25 anni, quella di Franceschini è la «vera riforma», e sicuramente, seppur controversa, aveva una sua logica nel concedere autonomia ad alcuni musei. La questione più discutibile è se fosse necessaria una separazione così netta dalle Soprintendenze. A un primo bilancio, alcuni musei hanno guadagnato, adottando relazioni con il territorio, le realtà sociali, economiche e culturali, l’associazionismo... Rimangono vistose limitazioni, come quella dell’impossibilità di gestione del personale, pur richiesta da molti direttori. Quale amministratore delegato di un’azienda privata accetterebbe di non poter assumere le figure professionali che gli servono? Sul fonte dell Soprintendenze, l’accorpamento avrebbe dovuto portare maggiore semplificazione, soprattutto per i cittadini, ma ha anche premiato una specie di «illanguidimento» delle competenze perché una Soprintendenza mista diretta da un architetto in un’area a prevalenza archeologica, o viceversa, ha inevitabilmente creato un senso di disorientamento. Ma la questione fondamentale è un terribile «sciame normativo»: questa Riforma ha complicato la vita di uffici già sotto pressione per le redistribuzioni territoriali e di competenze precedenti. Alcune Soprintendenze non riuscivano a usare la stessa carta intestata per più di pochi mesi...
Prima di dimettersi Sangiuliano ha nuovamente riorganizzato la struttura ministeriale in quattro Dipartimenti, sul modello già proposto dal ministro Buttiglione poi abolito dal suo successore Rutelli. Nel suo libro si chiede: «A che servono tante riforme?».
Da quanto so, la riorganizzazione è ancora a metà, i Dipartimenti sono solo sulla carta, non hanno ancora funzioni definite. Temo che provocherà un ulteriore, drammatico aumento della burocratizzazione del Ministero. Di tutto c’era bisogno, ma non di ulteriori posizioni dirigenziali. Servono piuttosto funzionari e personale operativo. Bisognerà capire dove si andrà. Che cosa significa ad esempio spostare gli Archivi nel Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e le Biblioteche in quello per la valorizzazione? C’è una specie di corsa all’innovazione per non parlare della moltiplicazione quasi ridicola dei luoghi dotati di autonomia: non doveva essere limitata ai luoghi d’eccellenza per storia e per dimensioni delle collezioni? Ora sono 60: che cosa c’è di straordinario nei luoghi del quartiere napoletano del Vomero, messi sullo stesso piano di Capodimonte? Così si perde di vista lo spirito originario dell’autonomia e si mettono a sistema luoghi vicini, ma senza alcuna storia comune. È il caso di Palazzo Venezia e Vittoriano a Roma: sono uniti solo perché sono uno di fonte all’altro?
Permane la carenza del personale interno al Ministero.
Lorenzo Casini, già capo di Gabinetto di Franceschini, nel 2016 ammetteva che nessuna riforma (e lui era artefice di quella del 2014) può avere successo se non si risolve il problema della carenza di personale del Ministero e della sua età avanzata. Una carenza che sfiora il 50%: una situazione cronicizzata e patologica, una vera emergenza in alcuni settori come gli archivi e le biblioteche, alcune delle quali sono costrette a chiudere al pubblico. I concorsi sono fatti con una lentezza terribile, coprendo alla fine solo in parte le necessità reali. Le competenze richieste in sede concorsuale sono molto generiche, non corrispondenti alle necessità delle singole sedi, oppure iperspecialistiche. È una macchina che sta girando a vuoto. L’intero sistema è vicino al collasso. Quanti funzionari di Soprintendenza sono oggi in grado di compiere sopralluoghi nel territorio loro affidato, in assenza di colleghi con cui suddividere gli impegni quotidiani? Ma nessun ministro ha mai davvero battuto i pugni sul tavolo per ottenere quanto necessario. È come se un ministro dell’Economia dovesse operare senza preoccuparsi di un debito pubblico fuori controllo. Ecco perché è importante che al Collegio Romano sieda un ministro politicamente autorevole. E che altrettanto autorevoli siano i dirigenti.

La copertina del volume «Lo stato dell’arte» di Francesco Erbani edito da Manni
Lei ricorda che la spesa pubblica italiana in cultura è lo 0,7% del totale della spesa pubblica, sotto la media europea che è dell’1%, «e ci colloca in graduatoria di poco sopra Cipro, Portogallo e Grecia».
Torno all’importanza che al Ministero sieda una figura riconosciuta e ascoltata all’interno del Governo. In parte è successo durante la lunga gestione Franceschini, almeno dal punto di vista della dotazione di bilancio. Ma il divario dell’Italia rispetto ad altri Paesi europei è spaventoso. L’Italia spende pochissimo per la diffusione della cultura in generale, tendenza confermata dalle passate leggi di bilancio del governo Meloni. E questa scarsissima attenzione da parte della politica è misurabile anche per altri aspetti. Abbiamo anche il più basso numero di laureati in Europa, il più basso livello di lettura di giornali e di libri. Dopo il percorso scolastico molte competenze svaniscono. È un intreccio perverso che produce qualcosa di simile all’arretratezza, proprio in tempi in cui molti, baloccandosi, discorrono di «egemonia» culturale...
Tra affitto di spazi museali per eventi privati e prestito di opere a eventi non culturali, anche all’estero, le recenti politiche ministeriali sono state accusate di «monetizzazione della cultura». Non certo una novità: quando si è avviato questo processo?
Direi almeno dalla metà degli anni ’80, con un’accelerazione negli anni successivi. È un’articolazione, in qualche modo, del neoliberismo: io Stato o Ente locale do pochi soldi a te e tu ti arrangi a trovarli, persino concedendo le tue sale e i tuoi beni a matrimoni o cene aziendali. Molti istituti hanno bilanci così risicati che sono quasi indotti a comportarsi così. È un sistema da cui è difficile uscire.
Troppi musei di prima fascia sono ancora senza direttore, come i Musei Reali di Torino e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Per non parlare di Capodimonte, il cui direttore Eike Schmidt è stato a lungo in aspettativa (accettata dall’ex ministro Sangiuliano) in coincidenza con la sua sfortunata corsa a sindaco di Firenze.
Quella di Capodimonte è un’anomalia gravissima. Parlo soprattutto della Commissione che ha scelto Schmidt (ex direttore degli Uffizi, Ndr) e del ministro che l’ha nominato. Non potevano non conoscere le sue aspirazioni politiche, che ne avrebbero fatto un direttore dimezzato. Come si può guidare un museo così pregiato facendo il capo dell’opposizione in Consiglio comunale a Firenze? Inoltre un uomo di parte può essere alla testa di un luogo di cultura statale incarnandone la disponibilità a essere un luogo di tutti? Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei maggiori musei archeologici d’Italia e d’Europa, è diretto da un anno ad interim da Massimo Osanna, perché non si è deciso se l’ex direttore Giulierini può nuovamente partecipare al bando. È una situazione ai limiti del grottesco, ma non l’unica purtroppo.
Si parla molto poco di archivi e biblioteche. Nel suo libro, addirittura definisce gli archivi «un’emergenza democratica». Perché?
Gli archivi non sono riservati ai soli studiosi, ma sono aperti a tutti i cittadini. Lì è conservata la memoria di piccole e grandi istituzioni e sono raccontate le singole storie del Paese. Vi si conservano i documenti utili nella quotidianità, ma anche ciò che può servire alla comunità a riconoscersi e a guardare avanti. Quella di cui sono vittime gli archivi è quindi una trascuratezza che incide nella vita democratica del nostro Paese. L’attuale direttore generale degli Archivi Antonio Tarasco, pur di grande competenza, non è un’archivista, ma un giurista. E ci sono Archivi di Stato in diversi luoghi d’Italia diretti da funzionari ministeriali spesso privi di competenze specifiche. C’è qualcosa di drammatico in tutto questo. E per le biblioteche ripeterei cose analoghe, compresa la situazione allarmante della Biblioteca Nazionale di Firenze, la maggiore in Italia per patrimonio custodito.
Veniamo alla concessione «onerosa» per l’uso di immagini di un’opera del patrimonio pubblico. Lei racconta il lungo iter, fin dal decreto ministeriale del 2023 che ha scosso editori, studiosi e addetti ai lavori. Da marzo è stata ripristinata la gratuità nel caso di pubblicazioni di carattere scientifico, divulgativo e didattico. Che cosa racconta questa vicenda?
Racconta il tentativo di far cassa nella maniera più fantasiosa: è vera «finanza creativa». «Vediamo come raschiare il fondo del barile», si saranno detti... Far pagare le pubblicazioni scientifiche è un controsenso, in chiaro contrasto con la diffusione della cultura. E infatti i rilievi del mondo accademico e della Corte dei Conti sono stati la pietra tombale su questo assalto alle immagini e al patrimonio pubblico. Indecente un po’ come l’aumento vorticoso del prezzo dei biglietti di molti musei italiani. Mancano i fondi e quindi la cultura è finanziata da chi ne usufruisce. La filosofia che sostiene queste operazioni è che lo Stato fa un passo indietro e lascia che sia il mercato a operare e a gestire.
Che cosa si aspetta, e che cosa ci possiamo aspettare, dal neoministro Alessandro Giuli?
Giuli è una persona con competenze culturali, ma anche con una storia politica molto chiara, in linea con la parte più di destra della maggioranza di Governo. Deve essere visto all’opera e per questo giudicato. Certo è chiamato a un grande impegno.
Nel capitolo «Il museo che verrà» lei cita alcune esperienze in cui i luoghi di cultura si offrono come «servizio pubblico».
Sono diversi, ma tutti orientati a fare di un museo uno spazio di coesione sociale, di mitigazione delle disuguaglianze, di apertura ai cittadini migranti, alle fasce più deboli della popolazione. Christian Greco, ad esempio, ha una visione di questo tipo per il suo Museo Egizio a Torino: un luogo di crescita civile, che però non piacque a Giorgia Meloni. Un lavoro altrettanto meritevole lo fanno quotidianamente altri musei in tutt’Italia, dalla GAMeC di Bergamo, con chi è in carcere, con le scuole e i più anziani, al Museo Civico Etnologico e Archeologico di Modena.... Sono iniziative che devono essere evidenziate e incentivate. Sono spunti di riflessione per il nuovo ministro.
Serve davvero un Ministero della Cultura?
Un Ministero che abbia competenze sul patrimonio, sulla creatività culturale e sulla tutela del paesaggio, non solo ci dovrebbe essere ma dovrebbe avere un peso politico e una capacità di incidere molto, molto più forte.
Altri articoli dell'autore
Per tre giorni, Intesa Sanpaolo apre le porte della sua iconica sede, che in dieci anni ha accolto mostre, reading e spettacoli di successo, da Tiziano ad Alessandro Barbero. Ora arriva Andy Warhol
Aperture straordinarie e musei statali (e non) a 1 euro sabato 17 maggio per la XXI Notte Europea dei Musei, iniziative in tutt’Italia domenica 18 maggio per la Giornata Internazionale dei Musei
Invitata al Salone del Libro di Torino, dove il 18 maggio sarà al centro di un dialogo con Melania Mazzucco, la signora del romanzo «artistico» festeggia il 25ennale dell’edizione italiana di «La ragazza con l’orecchino di perla»: «Scrivo quando vedo una storia con un vuoto da colmare, un mistero da risolvere»
Allestita alle Corderie dell’Arsenale e in varie sedi di Venezia, la 19ma Mostra Internazionale di Architettura riunisce 300 progetti di 756 partecipanti: «Voglio una Biennale “laboratorio”, in cui formulare un pensiero nuovo»